
Io Citto
Tu Citta

“I
SEGRETI NASCOSTI SULLE TERRE DEL RE PORSENNA”
Io Citto Tu Citta
“I SEGRETI NASCOSTI SULLE TERRE DEL RE
PORSENNA”
PREFAZIONE:
GRANDI MENTI
& piccoli geni:
La storia dell'Archeologia è costellata di
scoperte la cui "paternità" resta anonima, e non mancano neppure anzi pullulano
esempi di importanti grandi scoperte, fatte da “dilettanti" non accademici che,
spinti dalla pura passione, sono riusciti a risolvere complicatissime sciarade:
basti ricordare l'italiano Giovanni Battista Belzoni saltimbanco degli inizi
dell' '800, il cui nome resta impresso all'interno della piramide di Chefren.
Intuitivi si nasce, curiosità , passione, e
voglia di scoprire, uniti a tanta esperienza da autodidatti, fanno si che a
volte un analfabeta qualsiasi, un normale cittadino che ha STUDIATO “a modo
suo”,
possa scoprire importanti strutture nascoste.
L’Italia, “e non solo” deve la maggior parte del
suo patrimonio archeologico, a scopritori, rimasti magari ignoti, ed anche a
migliaia di “tombaroli” che scoperti, consegnavano il loro ricco bottino alle
autorità.
Il ricercatore esperto, non ha diploma, ma
esperienza, sa cogliere ogni minimo cambiamento morfologico del terreno;
raccoglie e custodisce storie leggende e racconti dei vecchi abitanti delle
campagne, sa mettere insieme quello che anno veduto e raccontato gli altri, con
quello che vede lui, poi l’intuito, la fantasia, e la passione per le cose
nascoste, fanno il resto.
La lettura di questo libro è molto semplice, si
tratta in pratica di seguire il filo di due (amanti) “Un Citto ed una Citta”,
che incontrandosi furtivamente e casualmente in zone Etrusche, ne descrivono
dettagliatamente le caratteristiche.
Il romanzo è stato arricchito di “Cenni Storici”
in modo che anche chi non conosce la storia Etrusca, possa capirne di più, in
modo da seguire meglio la lettura del testo.
INTRODUZIONE:
Abbiamo scritto
questo libro con il solo aiuto della nostra esperienza, la nostra dimestichezza
con certe zone, e terreni, conoscenze geologiche, morfologiche, storiche, e
architettoniche locali, acquisite col passare degli anni.
Ci ha reso il
compito molto più facile il fatto che uno di noi, “Stefano Romagnoli”, sia
esperto in ricerche storico scientifiche, con circa 30 anni di esperienze
accumulate, (essendo nato in queste zone, ed avendo conosciuto la classe
Contadina, ha avuto modo quindi di acquisire: “storie; dicerie; racconti e
leggende”, e tutto quello che si sono tramandati per centinaia di anni i vecchi
Contadini del paese, con i loro racconti, in vegliatura serale, nelle campagne
locali), è stato in grado di dare la sostanza informativa, e storico-scientifica
a questo libro.
Le cose che descriveremo, in queste “
Questa Cittadina
Toscana ‑ Sarteano ‑ ci preme molto, ed è da tenere molto in, considerazione,
soprattutto per il fatto che, non le sono mai state date le dovute attenzioni
storiche, (e non è per forma di campanilismo che noi si cerca di raccontarle)
sia perché Sarteano è un paese antico, ed anche per il fatto che è situato tra
la bassa regione Toscana, la regione Umbra, ed il Lazio, è da considerarsi senza
ombra di dubbio una zona Archeologica di elevata importanza.
La cittadina di
Sarteano ha il privilegio (oltre a quello della sua posizione geografica
favorevole e panoramica), di essere un grande altopiano, con molta campagna
coltivabile e fertile.
Confina sia con il
comune di Chiusi che con CHIANCIANO, e racchiude i
luoghi, che andremo a scoprire insieme in questo nostro lavoro di ricerca
e di elaborazione scientifica, al fine di riportare indietro nel tempo questo
Paese, e raccontarlo proprio come era all’epoca Etrusca.
Tutto è cominciato
così:
Trovandosi dopo una
giornata di lavoro, la sera al bar, una volta dopo l'altra, un discorso dopo
l'altro, abbiamo cercato di raccontare la storia di SARTEANO, ai tempi in cui
era, a parer nostro, una grande NECROPOLI ETRUSCA (di rilevante importanza), ma
fino ad oggi poco considerata sotto il profilo archeologico, ciò in parte dovuto
alla vicina Chiusi, (che ha sempre cercato di accentrare tutte le attenzioni
archeologiche su di essa), sminuendo tutto quello che non era parte concreta
della sua città.
Abbiamo fatto tutto
questo con l'aiuto di alcune cartine topografiche, raccogliendo vecchie storie e
leggende, raccontate dalla gente del posto, cercando di rendere il più possibile
dettagliata la nostra ricostruzione e descrizione dei “tesori nascosti sulle
terre del Re Porsenna”.
Sperando che quando
avrete letto i dati tecnici di ogni zona, vorrete verificarli di persona, per
poter così ammirare dal vivo le tante bellezze storiche e archeologiche, ma
sperando che non vi mettiate assolutamente a fare gli scavatori clandestini,
perché dobbiamo ricordarci che tutti i tesori d'arte e archeologia, fanno parte,
oltre che del nostro patrimonio artistico Nazionale, anche di noi stessi, perciò
sono già nostri, e della nostra Nazione, quindi cerchiamo di non auto
derubarci...
Si avverte inoltre
che alcune frasi, situazioni o citazioni potrebbero essere frutto della fantasia
di chi ce le ha raccontate, ma grazie all'aiuto delle carte, dei nostri studi
dettagliati sui punti in questione, pensiamo d'aver fatto un lavoro
accettabile, e nello stesso tempo,
leggibile da tutti, non volendo essere considerati esperti di archeologia, ma
dei semplici cittadini, un po’ più intuitivi e costrittivi di tanti altri.
“Alcune parti del
libro fanno parte di una ricerca, sistematica fatta al solo scopo di arricchire
di cenni Etruschi questo stesso testo.
Le ricerche dei
testi classici Etruschi sono state fatte sul materiale disponibile nella rete
Internet, in siti e luoghi ove era possibile prendere ed utilizzare certe
informazioni allo scopo divulgativo e costruttivo, per l’informazione
IMMEDIATAMENTE DOPO E’ STATO INVIATO
L’ESPOSTO PER COMUNICARE A TUTTE LE AUTORIRITA’ COMPETENTI, LE SCOPERTE
FORTUITAMENTE AVVENUTE DURANTE
DOPO SOPRALLUOGHI ED ACCURATE INDAGINI
NE RICERCHE ABUSIVE, NE VIOLAZIONI
RIGUARDANTI I CODICI “ALLORA VIGENTI “ DELLA LEGISLATURA DEI BENI CULTURALI
TUTTI I PUNTI DESCRITTI DA QUESTO LIBRO
SONO STATI SEGNALATI IN PRESENZA DI UNA COMMISSIONE DI OPRALLUOGO DELLA QUALE
FACE PARTE, ANCHE L’ISPETTORE ONORARIO DELLA LOCALE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA.
IL LIBRO E’ STATO SOLAMENTE IN PARTE,
AGGIORNATO, PER
POTER DARE AL MOMENTO DELLA SUA
PUBLICAZIONE, UNA PIU AMPIO RISCONTRO TRA I PUNTI CHE INDICAMMO, E QUELLI AD
OGGI GIA VENUTI ALLA LUCE NEI MEDESIMI PUNTI.
--------------------------------------------
“Ad oggi sono già
venute alla luce parecchie Tombe Etrusche DI ELEVATA IMPORTANZA, nei punti
esatti da noi descritti nel libro, ed anche indicati di persona alla
commissione d’inchiesta durante i sopralluoghi, avvenuti nel settembre 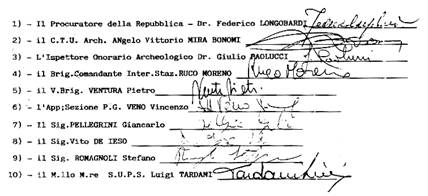
LE FIRME DEI TESTIMONI AI SOPRALLUOGHI
Legenda:
Dromos
Canale di larghezza tra gli 80 e i
Tegolo, o Tegoli
Specie di tegole somiglianti a quelle dei nostri tetti, ma di forma più
piatta, e dai bordi rialzati, erano usati per coprire. Nicchie, Dromos, e alcuni
tipi di Tombe dette a cassettone. All'interno sono di materiale cotto argilloso,
e color carbone al centro della sezione, con aggiunta di una parte di materiale
metallico sbriciolato nell'impasto.
Tappo
La pietra, con la quale venivano chiusi gli ingressi alle camere delle
Tombe.
Frontale
La parete di pietra o tufo che troviamo di fronte, e che va fin su al
livello della superficie del terreno, quando camminiamo dentro il Dromos, in
direzione della Camera centrale, vediamo il frontale proprio davanti a noi, in
fondo al Dromos.
Riempiticcio
In gergo significa il materiale che riempie i Dromos, spesso detriti di
materiale derivanti dallo scavo di costruzione della Tomba stessa, misti a terra
e detriti rossi di coccio, alcune volte nel Riempiticcio vengono ritrovati
piccoli Bricchi in miniatura e Lacrimatoi, gettati come voto durante la
ricopertura dei Dromos.
Cippo
Pietra di forma rettangolare o cubica, di peso circa "80 ‑ 100" Kg la
quale veniva posata sul piano al livello del terreno nel punto dove
incominciavano i Dromos, dopo aver riempito gli stessi, praticamente fungeva da
Lapide, e nello stesso tempo indicava il punto della sepoltura, in quanto con il
passar degli anni assestandosi il terreno e con la crescita dell'erba, non
avrebbero più dato modo di poter individuare il punto preciso della sepoltura.
Spillone
Attrezzo per la ricerca dei Dromos, (spesso usato dagli scavatori
clandestini) composto da un manico e da un'asta di solito di acciaio, con una
buona punta sulla sua sommità. Questo strumento conficcato nel terreno in punti
distanziati da loro in maniera giusta fornisce all'esperto la profondità precisa
del livello del Tufo sotto lo strato di Terra, quando succede che per un metro
circa lo Spillone va in profondità più del normale, ma poi ritorna come prima,
siamo in sostanza passati perpendicolarmente al canale di un Dromos.
Saggi
Scavi effettuati in punti ove si presume trovarsi un Dromos, o comunque
un’ipotesi di Tomba, fatti normalmente con una profondità di
Bucchero Pesante
Tipo di vasellame etrusco, costruito in cotto di colore nero, a volte dipinto o
con rilievi, di spessore superiore al normale vasellame leggero.
Greppo
Muro in pietre a secco, o anche di sola terra, o tufo, che divide un
piano Campo da un altro, di solito si trovano in terreni collinosi, dove
vengono usati per meglio sfruttare le terre dove altrimenti la pendenza non lo
permetterebbe.
Homus Rovus
Umano di elevata altezza che abitava la zona dell'Etruria nel periodo che va
dall'anno
Nicchiaio
Insieme di nicchie, a volte anche più di 40, tutte ben disposte
lateralmente ad un Dromos di circa 60 centimetrie di poca profondità rispetto
agli altri, un esempio simile lo si può vedere in Solaia bassa, Sarteano (SI).
Pendolo
Strumento usato da rabdomanti e ricercatori , di solito attaccato ad una
catenella, lo strumento si tiene in mano camminando, e si dovrebbe muovere
portando il suo possessore in direzione del materiale ricercato, il testimone da
pendoli è un materiale in piccoli
pezzi che va posto all'interno del pendolo, per fare la ricerca mirata. Se
all'interno di un pendolo il rabdomante inserisce un pezzetto d'oro, la materia
che troverà nei terreni usandolo, sarà prevalentemente appunto oro.
UNO
SCHEMA APPROSSIMATIVO DELLA ZONA DENOMINATA “ETRURIA”

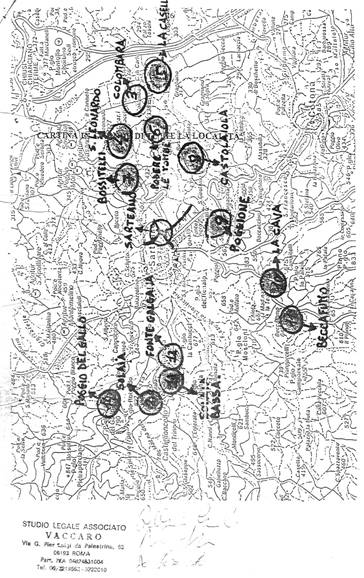
Copia della cartina ufficiale, cioè quella inviata allegata all’esposto
per denunciare le scoperte archeologiche, servì solo come riferimento per i
sopralluoghi approfonditi.
CENNI STORICI:
Cronologia Etrusca:
Secolo X a.C. Fasi finali della civiltà del
bronzo.
Secolo IX a.C. Fasi iniziali della civiltà del
ferro; cultura «villanoviana» nei territori dell’Etruria «propria» e sua
espansione verso l’Emilia-Romagna e il Salernitano. Formazione delle comunità di
villaggi. Secolo VIII a.C. Navigazione degli Etruschi nel Tirreno meridionale.
Inizio della colonizzazione greca nella penisola italiana. 775 ca. Stanziamento
dei Greci a Pitecusa, nell’isola d’Iscbia. 753 Fondazione di Roma, secondo la
tradizione varroniana. 750-725 Fondazione di Cuma. Inizio della colonizzazione
greca in Sicilia. Sviluppo del «villanoviano in Etruria - differenziazioni
sociali - fondazione del centri pre-urbani. 710-705 ca. Fondazione di Sibari, di
Crotone e di Taranto. Inizio della cultura «orientalizzante». Adozione
dell’alfabeto greco e introduzione della scrittura in Etruria (e nel Lazio).
Secolo VII a.C. Primo iscrizioni etrusche rinvenute a Tarquinia e a Cere. Pieno
sviluppo della cultura «orientalizzante». 650 ca. Demarato di Corinto si
stabilisce a Tarquinia. Influenze corinzie in Etruria. Fase evolutiva
dell’orientalizzazione. Inizio della civiltà urbana. Fioritura di Cere.
Thalassocrazia ed espansione commerciale delle città costiere dell’Etruria
meridionale. 616 Inizio della monarchia etrusca a Roma: regno di Tarquinio
Prisco (fino al 578). Secolo VI a.C. Espansione etrusca nella pianura Padana.
580 ca. Gli Etruschi sconfitti dai coloni greci nel mare di Lipari. 578 Inizio a
Roma del regno di Servio Tullio (fino al 534). 565 ca. I Greci di Focea fondano
Alalie in Corsica. 540 ca. Coalizione cerite-cartaginese contro i Focei:
battaglia del Mare Sardo. Controllo etrusco della Corsica. 534 Inizio a Roma del
regno di Tarquinio il Superbo (fino al 5l0). Fondazione di Marzabotto e di
Felsina. 525 Spedizione fallita degli Etruschi (con Umbri e Dauni) contro Cuma.
510 Distruzione di Sibari ad opera di Crotone. Fioritura di Capua etrusca. 509
Cacciata di Tarquinio il Superbo e fine della monarchia etrusca a Roma.
Espansione di Chiusi nel Lazio: il re Porsenna a Roma. 505 ca. L’esercito di
Porsenna sconfitto presso Ariccia do Aristodemo di Cuma e dai Latini. Gli
Etruschi sconfitti dai Galli al Ticino. Secolo V a.C. Thefarie Velianas signore
di Cere. Guerra tra Veio e Roma; strage dei Fabii al Cremera. 474 Gli Etruschi
sconfitti nelle acque di Cuma dai Siracusani; fine della thalassocrazia e crisi
delle città etrusche meridionali; sviluppo delle città dell’Etruria interna e
settentrionale; fioritura dell’Etruria padana e adriatica. 454-453 Incursioni
della flotta siracusana nel Tirreno settentrionale. Inizio della pressione
sannitica sulla Campania. 428 Guerra tra Veio e Roma. 426 La città latina di
Fidenae, alleata di Veio, conquistata dai Romani. 423 Capua occupata dai
Sanniti. Fine del dominio etrusco in Campania. 414-413 Un contingente etrusco
(forse di Tarquinia) partecipa all’assedio navale ateniese di Siracusa. 406
Inizio dell’assedio di Veio da parte dei Romani. Secolo IV a.C. 396 Veio
conquistata e distrutta dai Romani: il suo territorio incorporato nello stato
romano. 390-386 Scorrerie dei Galli nell’Italia centrale: Roma saccheggiata e
incendiata. 384 Incursione della flotta siracusana nel Tirreno e saccheggio del
santuario di Pyrgi. I Siracusani nell’Adriatico settentrionale. 382 Fondazione
delle colonie romano-latine di Nepi e Sutri. Ascesa di Tarquinia e sua egemonia
sulla Lega etrusca. 358 Tarquinia (con Cere e Faleri) muove guerra a Roma.
Detronizzazione del re di Cere. 353 Pace separata tra Cere e Roma. 351 Fine
della guerra e tregua quarantennale fra Tarquinia e Roma. Rivolta «servile» ad
Arezzo domata con l’intervento di Tarquinia. Marzabotto e Felsina occupate dai
Galli. Spedizioni dei Galli nell’Italia centrale. 314 Navi etrusche in Sicilia
in aiuto di Agatocle di Siracusa contro i Cartaginesi. 311 Gli Etruschi in
guerra contro Roma. I Romani penetrano nell’Etruria centrale e interna. 307 Gli
Etruschi costretti alla pace con Roma. 302 Roselle assediata e occupata dai
Romani. Intervento di Roma ad Arezzo in appoggio alla famiglia dei Cilnii.
Rivolte «servili» a Volterra e a Roselle. Completa decadenza di Spina. Secolo
III a.C. 296 Gli Etruschi nella coalizione «italica» contro Roma. 295 I
coalizzati sconfitti dai Romani a Sentino. Vittorie romane sugli Etruschi. 284
Rivolta «servile» ad Arezzo. 282 Gli Etruschi definitivamente sconfitti dai
Romani al lago Vadimone. 280 Vulci eVo1sini si arrendono a Roma. Le città
etrusche costrette ad allearsi con Roma: l’Etruria federata. Prefettura romana a
Statonia. 273 Colonie romane a Cosa e a Pyrgi. 265 Rivolta «servile» a Volsinii.
264 Volsinii conquistata e distrutta dai Romani. Saccheggio del santuario della
Lega. Volsinii ricostruita sulle rive del lago di Bolsena. Colonie di Roma a
Castrum Novum, Alsium e Fregene. 241 Faleri conquistata e distrutta dai Romani.
Trasferimento della città in altra sede. 225 L’Etruria investita da un
incursione di Galli distrutti dai Romani a Talamone. Costruzione della via
Clodia. 222 Spedizioni romane contro i Galli, dalle basi etrusche. Costruzione
della via Flaminia. 217 Annibale, in Etruria, sconfigge i Romani al Trasimeno.
209 I Romani rinforzano i presidi militari in Etruria. 205 Le città etrusche
contribuiscono alla spedizione africana di Scipione contro Cartagine. Secolo II
a.C. 196 Rivolta di schiavi in Etruria. 189 Fondazione della colonia romana di
Bononia. 186 Repressione del culto «sovversivo» di Dioniso. 183-180 Fondazione
di colonie di Roma a Saturnia, Gradisca e Pisa. 177 Fondazione di colonie di
Roma a Luni e a Lucca. Costruzione della via Cassia. Progressiva emancipazione
di elementi servili nell’Etruria settentrionale. 135 Viaggio del tribuno Tiberio
Gracco attraverso l’Etruria. 133-121 Fallimento dei tentativi di riforme sociali
dei Gracchi. 130 L’etrusco Marco Perperna eletto console a Roma.
Secolo I a. C. 91 Marcia su Roma degli Etruschi
contro le proposte di legge riformatrici del tribuno Livio Druso. Secessione e
guerra degli alleati italici contro Roma. 90 Interventi militari romani a
Fiesole, Arezzo, Chiusi e Volsinii. 89 Gli Etruschi ricevono la cittadinanza
romana. Le città etrusche diventano «municipi» dell’Italia romana. 87 Gli
Etruschi parteggiano per Mario. 82 Repressioni di Silla contro Fiesole, Arezzo e
Volterra e deduzione di colonie di veterani romani. 78 Effimere rivolte
«popolari» a Fiesole e in altre città. 63 Catilina si rifugia in Etruria e
arruola truppe a Fiesole e ad Arezzo. 49 Gli Etruschi neutrali nella guerra
civile tra Pompeo e Cesare. 40 Perugia, occupata dai seguaci di Antonio,
conquistata e saccheggiata dalle truppe di Ottaviano. 27 L’etrusco Mecenate tra
i consiglieri e i ministri di Augusto. 7 L’Etruria diventa la regione VII
dell’Italia romana.
Capitolo
1
Era la fine del mese di Giugno, stavo scendendo
da Nord con la mia vecchia auto, per andare a prendere servizio in un albergo di
Chianciano Terme, essendo ormai un cameriere di professione, il mio mestiere mi
permette di girare il mondo, così avevo deciso di passare quest'anno a
Chianciano Terme. La macchina scorreva veloce sull'autostrada del Sole, ma di
sole non ce ne era, perché il tempo minacciava pioggia così tanto che arrivato
al casello Autostradale, per pagare il pedaggio ho dovuto accendere i fari come
se fosse notte profonda, ma era solo tarda mattina. Subito dopo pagato il
pedaggio e uscito dalla Autostrada, mi sono immesso sulla normale che porta a
Chianciano Terme, la visuale della strada che paesaggisticamente m'aveva
colpito, in realtà era una bella donna, che bella sarebbe dire poco, perché
sembrava una statua, coi capelli lunghi, un volto da ingenua e nello stesso
tempo da donna vissuta. Non potevo definire la sua età, e non capivo se aveva un
vestito o era nuda, se era alta, o bassa, giovane o vecchia. Mentre la sua calda
voce mi domandava; “Scusa, vai a Chianciano Terme?”, mi dai un passaggio grazie.
Mi sembrava impossibile che stessi portando una Fata così
a Chianciano Terme . La macchina sembrava sicura di saper dove andare, il
motore cantava come un usignolo, tra curve e dossi, tra la campagna ben curata
ed il cielo che scaricava tutta la sua pioggia, dentro l‘abitacolo della mia
auto non c’era il solito puzzo del tabacco delle mie sigarette, ma c’era un
dolce profumo di freschezza da farmi girare
Zona “

Località SARTEANO
In collina, a
Famoso per il suo
campeggio, (il secondo in Europa come grandezza) che s'estende a sud del Paese
per alcuni chilometri, con ben tre piscine, acqua di sorgente a 27 gradi
permanentemente costanti, ristoranti, concerti all'aperto, ecc. Nella parte
storica del paese ci sono costruzioni a testimonianza delle antiche dominazioni
cavalleresche, come per esempio Palazzo Piccolomini, Palazzo Cennini, e tanti
altri palazzi più o meno importanti una volta dimora di duchi, marchesi e conti.
Sarteano offre al
turista molti luoghi di agriturismo, la fonte delle Canalette, la cui acqua
guarisce da sempre le malattie e le infiammazioni degli occhi; le celle di S.
Francesco, luogo di passeggiata campestre e pista per biciclette da montagna.
In queste “celle”
simili a caverne si ritirò S. Francesco d'Assisi, durante il suo pellegrinaggio,
e passò qui diversi anni della sua vita.
SARTEANO, paese
d'origine Etrusca, ma anche una città che si sta ampliando e industrializzando
molto in fretta, da poco esiste anche una zona industriale, dove gli
imprenditori hanno edificato i loro capannoni.
Sarteano domina la
valle, dai punti più alti si vedono il lago Trasimeno, quello di Chiusi, e
quello di Montepulciano.
In questo paese si
svolge in agosto la “Giostra del Saracino”, manifestazione popolare molto
antica, apprezzata dai turisti e dai cittadini, che divisi in contrade (S.
Bartolomeo, S. Martino, S. Lorenzo, S.S. Trinità ecc.), partecipano con gioia ed
impegno alla giostra, cercando di centrare su di un cavallo in corsa, un anello
con una lancia tenuta dalla la mano destra.
Il castello è in
alto al centro del paese, ormai non più visitabile per intero, perché alcune
sue parti sono pericolanti, questi domina dall'alto tutta la cittadina, ai suoi
piedi le mura che circondano gran parte di SARTEANO vecchia.
Le porte d'ingresso
al paese sono ancora lì, come una volta, mancano solo i mastodontici portoni di
legno che in tempi antichi venivano chiusi per protezione.
Sulla parte ovest di
Sarteano ci sono molti boschi e pinete, fino a salire al Monte Cetona, (
La piazza centrale
mostra al centro un monumento, ai caduti, ed alla sua sinistra le "Logge", con
all’interno i ricordi e la lista dei caduti in guerra, dalle loggie si accede al
Teatro comunale, non è enorme, ma molto ben fatto ed accogliente, ed ultimamente
anche perfettamente funzionante.
Dietro al monumento
il barbiere ed i negozi antichi, insomma una cittadina simile a Pienza,
Monticchiello, Cetona ecc.
Un tempo paese di
contadini in campagna, e di padroni nelle ville in paese, adesso invece la
situazione si è invertita, i ricchi stanno nei vecchi casolari di campagna
mentre i poveri nelle case del paese.

VISTA DI
SARTEANO
Un posto tranquillo,
salutare e ottimo per odia lo stress quotidiano delle città, o per chi ha da
spendere per comperarsi un bel casolare, ristrutturarlo ed abitarci in santa
pace.
Poco distante,
“Chianciano Terme”, che offre invece una buona e funzionante stazione termale
specializzata nella cura del fegato. In quanto a locazioni archeologiche, anche
Chianciano ne offre alcune, ben note agli abitanti locali ma forse meno ai
turisti, i quali a nostro parere dovrebbero essere spronati a vedere certi
posti, magari con passeggiate organizzate dagli alberghi stessi, o addirittura
dal Comune, o dall'Ente per il Turismo.
Una zona abbastanza
bella di Chianciano è la "Pedata", necropoli scavata per metà, che offre la
vista d'alcune tombe a camera, scavate completamente nel tufo.
Poco più in alto
lungo la "camionabile" (Chianciano), strada nella quale vengono deviati i mezzi
pesanti per evitare che si intoppino nel caos del centro, salendo verso l'alto,
si possono vedere dei resti di insediamenti etruschi, segnalati con tanto di
indicazioni e cartelli, come ad esempio “Poggio Bacherina”.
A dieci chilometri
da Sarteano c'è Chiusi, anticamente la città dimora del Re Porsenna, Lucumone e
Re degli Etruschi, e sovrano dell'Etruria intera. A Chiusi si possono ammirare
alcune tombe decorate con dipinti, nel centro storico c'è il Museo del Duomo,
dove risiedono molti reperti sia locali che provenienti dai paesi circostanti.
Le necropoli a Chiusi sono di gran lunga inferiori a quelle di Sarteano,
d'altronde secondo le nostre teorie questa città era la zona "Logistica", mentre
quella "Operativa" era più spostata verso Sarteano, e di conseguenza, anche
quella delle necropoli comuni.
Ma torniamo a
Sarteano, nelle periferie che circondano il paese,
vi sono in varie zone resti di epoca etrusca, in prossimità del cimitero
di Sarteano, ad esempio, scendendo verso nord, si può percorrere in discesa per
circa un chilometro e mezzo un pezzo di "Via Inferi" o (cupa), si tratta di una
strada etrusca scavata nella roccia molto profonda, che scende in direzione
della cartiera di Sarteano.
Questa zona è meglio
denominata 'Bocca
La tomba era d'età
"Arcaica", al suo interno furono rinvenuti un boccale di bucchero e altri
frammenti vari, ed un cippo di travertino, sicuramente appartenente alla stessa
tomba.
Andando avanti
invece, ad est, dopo il cimitero c'è un'altra località particolare denominata
“il Gorone", da "Gora", o meglio grande massa d'acqua contenuta in un recipiente
artificiale, questo "Gorone" serviva ad alimentare le macchine della cartiera
sottostante, l'acqua viene infatti ancor oggi incanalata attraverso delle
condutture e portata fin giù alla cartiera, dove per la pressione acquistata
lungo il pendio, viene utilizzata per alimentare una piccola centrale
idroelettrica. Nella località della cartiera nel marzo del 1952 fu segnalato, ma
mai accertato, il rinvenimento di una tomba etrusca con all'interno una maschera
d'oro, le voci giunsero alle autorità del paese, ma non si riuscì a saperne di
più.
Questo posto che va
da "Bocca
Lungo questo strano
pianoro, si vedono qua e là alcune pietre di forma quadrata e rettangolare, di
chiara epoca etrusca, forse servite a quei tempi per qualche costruzione in
pietra adesso non più visibile, o forse servite da basamento di sostegno per
qualche struttura. Si pensa così perché è chiaro che avendo costruito in questo
punto qualcosa di abbastanza alto, lo si sarebbe visto per così dire da mezzo
mondo, a causa della posizione stessa.
C'è da notare che
alla fine del campo, sia verso nord che verso est si vedono tracce di muri a
secco forse di sostegno, o di circondario per delimitare i confini di proprietà,
muri interessanti, ma solo dal punto di vista storico.
Un altro fatto molto
strano è che in questo pianoro non vi sono tracce di scavi o tombe etrusche, né
recenti né remote, come se il sottosuolo fosse così solido, da non aver permesso
agli Etruschi di costruire qui le loro tombe.
Che sia stato questo
pianoro enorme, la base ove poggiava un tempo il famoso “Mausoleo” eretto in
onore del “Re Porsenna”? Noi siamo convinti che il posto giusto sia questo.
Spostiamoci per un
momento a nord di Sarteano, lungo la strada che porta a Chianciano, fatti circa
tre chilometri dal paese, svoltando a destra per una via sterrata si può
arrivare in località "Santa Apollinare", un allevamento di cavalli dei più
estesi nella zona.
Dando uno sguardo in
giro, fra le stalle e il casolare del custode, c'è un pendio scosceso di
formazione tufacea, scendendo lungo questo pendio si notano bene due o tre
tombe aperte, facenti parte di una serie "a schiera", a prima vista
sembrerebbero isolate, ma guardando bene sia a destra che a sinistra, c’è lo
spazio giusto, e quindi ce ne sono almeno altre quattro (inviolate), ai lati di
quelle già aperte.
Abbiamo raccolto
anche su questa zona dei racconti locali, uno dei quali dice: "Stavamo facendo
un fossato per far scorrere l'acqua piovana più in basso, impedendo così che
quando piove molto si allaghi il terreno su cui pascolano le mandrie dei
cavalli.
Ad un certo punto, a
circa
Noi avevamo già
capito dal racconto, che in quel posto esistevano anche delle tombe di tipo "a
cassettone con copertura a Tegolo", sicuramente d'epoca Etrusca.
Effettivamente
ancora oggi si vede bene il fossato e qualche cenno di materiale di mattone
rosso, e qualche pezzo di Tegolo, vari detriti rossastri classici dei posti dove
esistevano tombe di questo tipo, in conclusione possiamo affermare che, anche
qui ci sarebbe molto da lavorare, essendovi sicuramente un 40% di Tombe ancora
inviolate, naturalmente non è una zona di facile accesso da parte dei
ricercatori in quanto proprietà privata, e quindi per compiere delle ulteriori
indagini ci vorrebbe un permesso da parte della Soprintendenza Archeologica
locale e del padrone del terreno.
Ad ovest del paese
c'è la strada che porta a "Castiglioncello sul Trinoro", fatta tutta la dritta,
verso la periferia del paese, prima della curva a destra che c'immette
all'inizio delle salite, guardando in alto si vede un casolare, "Poggio Le
Forche". Questa è una buona zona archeologica, nel 1915 intorno al casolare,
specialmente nella parte che guarda il paese furono rinvenute parecchie nicchie
a parete, diversi ziri, ed anche qualche tomba, ricca di reperti. Sempre secondo
i racconti, (discutibili) in una di queste tombe fu rinvenuto un cavallo alato,
d'oro, del peso di
Poco distante, a
circa
Attorno a questo
piccolo fabbricato si intravedono in vari punti, resti di tombe profanate, molte
delle quali sono state poi ricoperte in maniera parziale, quasi sicuramente si
tratta di tombe di epoca etrusca, questi resti testimoniano che anche in questa
zona dominante il sud‑est da un'altura non indifferente, gli Etruschi avevano
scelto i luoghi per le loro sepolture.
La vegetazione è
molto folta, e le troppe piante innestate parecchi anni or sono, fanno sì che
l'individuazione di altre tombe non profanate sia molto difficile, abbiamo
comunque calcolato che ce ne siano almeno una ventina da individuarsi nell'arco
di spazio che va dalla Caccetta, fino alla località "Cavetta", (una vecchia
cava di tufo dentro il bosco).
Sarteano adesso vi
apparirà meno velato, almeno per quanto riguarda il paese e la sua periferia,
adesso però addentriamoci nella scoperta di cose molto più ricche di mistero e
di tesori nascosti.
CENNI
STORICI:
I Personaggi Etruschi
Riportiamo brevemente la storia di alcuni
personaggi caratteristici della storia etrusca. Come già ricordato nel capitolo
precedente, è importante tenere presente che le notizie storiche pervenuteci
sono state filtrate dal mondo culturale filo romano (tranne nel caso della
vicenda del mitico Mastarna e dei Vibenna), per cui è lecito supporre che per
alcuni tratti le vicende riportate si siano arricchite di leggenda, al fine di
esaltare la cultura romana che aveva sconfitto quella etrusca. Cicerone Marco
Tullio Fabia (gens) Furio Camillo Marco Mastarna ed i Vibenna Mecenate Caio
Cilno Ocresia Porsenna Ravnthu Servio Tullio Spurinna (gens) Tanaquilla
Tarquinio Lucio Prisco Tarquinio Lucio il Superbo Tullia Velia Virgilio Publius
Maro Vulca MARCO TULLIO CICERONE
Marco Tullio Cicerone nacque nel
RAVNTHU Ravnthu appartenne a due delle più
grandi famiglie tarquiniesi: per nascita a quella dei Thefrinai e per matrimonio
a quella ancora più prestigiosa e storica degli Spurinna. Quando morì fu deposta
con gli Spurinna nella regale Tomba dell’Orco, dove ancora s’intravede dipinta
in una nicchia, sullo sfondo di un paesaggio agreste. Indossa una tunica bianca
ed è distesa con meravigliosa scioltezza in banchetto, accanto al marito Velthur
il Grande, l ‘eroe che al comando di due eserciti etruschi partecipò come
alleato di Atene all’assedio di Siracusa. Le sue quinquereme combatterono
magnificamente nella battaglia di Lisimelia, ma quella fu l’ultima azione
militare di vasta portata in cui, nel meridione, apparvero le forze navali di
Tarquinia. Perché, come era stato scritto inesorabilmente, il tempo concesso
dagli Dei alla nazione etrusca stava per concludersi e nel silenzio del cielo
sereno era già risuonato lo squillo terrificante della tromba sacra che ne
annunciava la fine. Roma invadeva le terre, atterrava le rocche, devastava i
porti, ma Tarquinia resisteva e contrattaccava. Ogni volta, a difendere la
libertà della città santa al nomen etrusco c’era uno Spurinna, strettamente
legato per vincoli di parentela alla matriarca Ravnthu. Prima scese in campo suo
figlio Velthur il giovane, poi suo nipote Avle, che i romani chiamavano Aulus.
Avle Spurinna spodestò dal trono Orgolnius, re di Cere, liberò Arezzo dalla
rivolta degli schiavi, tolse ai Latini nove città fortificate. Poi carico di
orgoglio, di rancore e di sete di libertà, affrontò Roma in campo aperto. Tanta
era l’ira di entrambe le parti che nessuna iniziò lo scontro con i giavellotti,
gli archi e le altre armi da getto. La battaglia fu subito aperta con la spada,
corpo a corpo, e la già inaudita violenza iniziale si accrebbe durante la lotta.
I tarquiniesi vinsero e il prezzo che imposero ai vinti fu durissimo: con un
implacabile cerimoniale che si protrasse per giorni e giorni, in un mare di
sangue che inondò il Foro di Tarquinia, trecentosette prigionieri romani furono
giustiziati davanti all’Ara della Regina. Nella seconda battaglia per la
libertà, le truppe etrusche inferiori per numero furono sconfitte. Questa volta
fu Roma a non avere pietà. I tarquiniesi vinti furono passati per le armi la
sera stessa, sul luogo dello scontro. Trecentocinquantotto tra i più nobili
furono invece trascinati nell’Urbe. Qui, in un crescendo di orrore che superò
quello dell’eccidio dell’Ara della Regina, furono pubblicamente massacrati. I
ricchi oliveti, i vigneti, i campi della città vinta furono bruciati e gli
impianti idraulici insabbiati. Tarquinia non morì subito, anzi conobbe altri
anni di effimero splendore. Poi, pian piano, uscì dalla storia. Mezzo millennio
più tardi, però, un cittadino della Roma Imperiale, che nonostante l’oblìo dei
molti secoli trascorsi voleva onorare il ricordo dei suoi antenati etruschi,
fece incidere in una epigrafe, gli “Elogia Tarquiniensia”, le lodi degli
Spurinna e il racconto delle loro grandi gesta. Tra i nomi degli eroi, con
grandissima dignità e rispetto, volle immortalare anche quello di Ravnthu, la
donna che orgogliosamente fu al centro della loro gente e della loro storia.
L’epigrafe degli Elogia è conservata nel Museo Nazionale Archeologico di
Tarquinia. SERVIO TULLIO Secondo la tradizione sesto re di Roma, che avrebbe
regnato dal 578 al
TARQUINIO Lucio PRISCO Secondo la tradizione
quinto re di Roma, che avrebbe regnato dal 616 al
MECENATE Caio Cilno Caio Cilno Mecenate, nato ad
Arezzo nel
Capitolo
2
Incredibile, ma vero, il mio primo viaggio a
SARTEANO era stata una vera e propria sorpresa che mi aveva fatto dimenticare in
parte il vero motivo per il quale c'ero andato. Dopo alcuni giorni ricevetti una
telefonata, era
Zona “

TOPOGRAFICA DELLA ZONA (SOLAIA)
Qui le Tombe sono di
varie tipologie: a gruppi di tre, a schiere a zigzag, a schiere lineari, anche
di trenta tombe tutte in fila. In genere non si somigliano l'una con l'altra,
le tipologie sono simili, ma c'era
una certa attitudine alla personalizzazione, sia per quanto riguarda gli
ingressi, sia per la forma dei Dromos, e a volte persino i Nicchiai sono di
tipologia molto diversa l'un l'altro, e la grandezza delle camere all'interno,
varia di grandezza e forma quasi sempre.
Pensate che una di
queste tombe si presenta con un Dromos lungo
Naturalmente gli
artefici di questo scavo hanno pensato di non svuotare per tutta la sua
lunghezza il Dromos dal suo Riempiticcio ma per risparmiare tempo e fatica,
hanno fatto uno scavo perpendicolare, dritto verso il basso, seguendo il
frontale, tutto questo per arrivare velocemente alla chiusura d'ingresso della
camera centrale.
Forse non avevano
pensato che lungo tutto il tragitto del Dromos, ai lati potevano esserci altre
tombe e nicchie, a volte più ricche delle camere centrali stesse, in quanto in
alcune tipologie di seppellimento, la camera centrale ospitava il defunto, con
o senza sarcofago, ma le offerte venivano disposte nelle nicchie laterali.
Le nicchie laterali
sono importanti anche perché il capofamiglia in genere veniva seppellito per
primo, nella Camera centrale, lasciando però la sua eredità materiale ai figli,
i quali alla loro morte avevano come ornamento non solo gli oggetti propri e le
offerte, ma anche una serie di cose ricevute in eredità dal capofamiglia.
Poi ci sono le Tombe
povere, così dette perché molto piccole, con un Dromos di
Queste Tombe‑povere
non sono nemmeno orientate come le altre, alcune sono rivolte ad ovest, altre a
nord in maniera molto differente dalle altre tipologie d'orientamento locali.

IMMAGINE
DI UNA TOMBA ETRUSCA APERTA IN LOCALITA’ SOLAIA
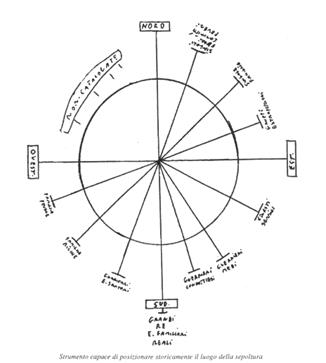
STRUMENTO DI NOSTRA REALIZZAZIONE
E durante questi
studi, che il nostro lavoro ci ha consentito di portare a termine fra le altre
cose uno strumento inedito, da noi inventato, che serve a stabilire la classe
sociale a cui apparteneva il defunto della tomba individuata, in base alla
precisa misurazione del punto cardinale indicato dalla direzione dei Dromos
della stessa.
Vogliamo sperare che
questo strumento possa essere d'aiuto agli studiosi di questo settore, noi siamo
pronti a dar loro qualche consiglio sul come adoperarlo, del resto anche
abbastanza preciso.
Al centro della
Solaia si trovano resti di mura, ad una certa profondità. I racconti parlano di
una antica costruzione chiamata “Il Chiesone”, questi resti di fondamenta, e
residui bassi di pareti laterali, sarebbero appartenuti a questa remota
costruzione ormai non più visibile.
Siamo riusciti a
sapere ben poco riguardo a questo Chiesone, poiché la gente non ne parla
volentieri, anzi, al sentirlo nominare cambia volutamente argomento.
Comunque, si vedono
benissimo i resti che delimitavano un perimetro rettangolare e lasciano
supporre che in quel punto ci fosse stato un tempo un edificio corrispondente
alle descrizioni dei pochi che ci hanno raccontato le storie di questo luogo.
Si racconta inoltre
che a profanare la maggior parte delle tombe nella zona della Solaia, siano
stati gli uomini alle dipendenze del Marchese Bargagli, operai e braccianti ed
abili lavoratori del terreno locale, mandati da lui nei "tempi morti" a scavare
in queste zone. Il risultato degli scavi venne
poi donato a vari musei della Toscana e del Lazio dallo stesso Bargagli, probabilmente
ora sono in
mostra in qualche museo famoso.
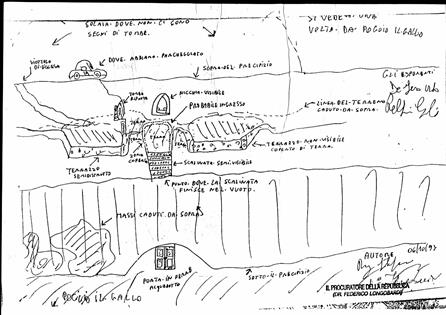

”Questo ingresso o tunnel quadrato è
stato scoperto da una frana che fece distaccare parte della parete verticale ,
subito a destra del secondo terrazzone
a pochi metri
dalla scalinata centrale.”
Gli uomini venivano
la mattina presto, nel periodo in cui non avevano mansioni stagionali da
svolgere nei campi e a gruppi di cinque o sei alla volta iniziavano a scavare
le tombe, armati di pale e picconi.
Non era poi tanto
difficile a quei tempi individuare i Dromos, perché all'inizio di ognuno c'era
un cippo.
Oggi di questi cippi
non c'è più traccia, sono stati tolti tutti dalla loro posizione originale, e
quindi l'individuazione dei Dromos non è più semplice come una volta. A meno di
non usare lo spillone, o altri metodi di ricerca, non sarebbe più possibile
trovare il punto preciso della locazione dei Dromos.
La parte a nord est
che delimita la stessa fine della Solaia, è un precipizio molto profondo, che
s'estende per qualche chilometro da sud verso nord-ovest, passando anche per
Abbiamo controllato
questa profonda scarpata, in alcuni suoi punti scende fin sotto il profondo muro
di pietra.
Abbiamo visto i
resti di una scala in pietra ancora abbastanza visibile, questa sale verso la
parete perpendicolare partendo dal vuoto, ciò significa che una parte di questa
scalinata scolpita nella pietra, è mancante, e ciò convalida l'ipotesi che sia
precipitata con una enorme valanga o sfaldatura, a valle.
Vicino al punto dove
c'è la scalinata si vedono dei resti di mura ed anche dei pezzi di muratura a
mattoni neri e rossi, si notano ancora le pareti (solo i resti) che facevano
parte di costruzioni in pietre e mattoni, murati con cemento particolare.
Sulla destra della
scalinata c'è un terrazzo in pietra, ai piedi di una caverna, di forma
rettangolare, scavato nella parete dura, sulla sinistra l'altro terrazzo,
meno visibile del primo, in quanto ne
mancano molte parti.
Tutto fa supporre
che questa imponente struttura rupestre, (come ricostruita nel nostro disegno),
faccia parte della parte esterna di un Tempio sotterraneo, o comunque qualcosa
di grande importanza, l’accesso del quale deve essere stato un tempo sicuramente
alla fine della scalinata, che finisce a parete, con l’ultimo scalino scolpito a
ridosso della parete verticale rocciosa.
Stando in piedi
diritti verso la parete, sull’ultimo scalino, dovremmo avere di fronte a noi
(ben chiuso e non visibile) l’ingesso della struttura sotterranea, che sia un
Tempio o no, ne dovremmo discutere parecchio.
Si vede molto bene
che in questo punto manca una parte di roccia, sicuramente questo piano una
volta si estendeva verso est per una ventina di metri più in avanti dell'attuale
precipizio.
Il precipizio in
questo punto è di una profondità di 25/30 metri, guardare in giù fa una certa
impressione. Analizzando la zona siamo riusciti a trovare un viottolo
(sicuramente una volta strada praticabile), che porta sotto il precipizio.
Portandoci in
direzione della scalinata, si vedono enormi massi caduti dall'alto e da questo
punto si riesce a capire bene anche la loro posizione originale.

VISTA DI UN “NICCHIAIO” IN LOCALITA’ SOLAIA
Sono delle montagne
di pietra divise in più parti e non molto distanti l'una dall'altra, girando
attorno ad uno di questi massi, abbiamo scoperto che uno di loro, ad una certa
altezza presenta uno scavo nella pietra a forma di nicchia.
Dopo aver analizzato
bene la forma e la profondità di tale nicchia scavata nella pietra, si deduce
inequivocabilmente che questo masso gigante faceva parte della parete superiore
del precipizio, e la nicchia apparteneva ad una delle tombe che abbiamo
analizzato nella parte superiore.
Unendo i fatti
quindi possiamo dire che le storie raccontate dagli anziani sono molto
credibili, e in ogni modo molte delle cose che hanno raccontato coincidono con
le nostre analisi.
Siamo andati quindi
a controllare il punto dove sarebbe esistito, sempre secondo le voci e le
testimonianze raccolte, il famoso Chiesone.
Questa costruzione,
sarebbe stata una chiesa enorme con una storia molto particolare. Nell'anno
1911/12 circa, nei pressi di questa chiesa veniva festeggiata,
La storia dice poi
che i partecipanti alla festa s'ubriacarono e incominciarono a ballare nudi, al
suono della fisarmonica, tutt'intorno e dentro il Chiesone. Si racconta che a
mezzanotte Dio volle punirli per aver osato tanto. I partecipanti che erano
andati in gruppo a smaltire la sbornia, si trovarono proprio sul precipizio
rivolto ad est, nella zona della scalinata dove esisteva un piccolo insediamento
chiamato Solara (da qui il nome SOLAIA). In quel momento, si racconta che per
punizione ci fu una specie di terremoto e la parte della Solaia che conteneva
tutto l'insediamento si staccò precipitando a valle, portando con sé tutta la
gente e tutto il resto.
Quindi, (secondo la
leggenda), una grossa fetta di terreno precipitò a valle ruotando su se stessa,
capovolgendosi, per poi finire al suolo schiacciando tutto quello che si trovava
sulla parte superiore.
Si narra poi che
durante la notte della candelora, venendo qui a mezzanotte si possa udire,
stando in silenzio e concentrandosi, il suono della Fisarmonica, le grida di
quella gente, ed i loro canti di tanti anni fa.
Per quanto riguarda
la parte in basso, sotto il precipizio c'è da notare un'altra cosa. Tanti anni
fa (nessuno conosce la data precisa) ai piedi di questa parete altissima,
all'incirca sotto l'insediamento SOLARA, in direzione della scalinata, è stato
trovato attaccato alla parete, al livello del terreno, un cancello alto due
metri, e largo tre, tutto di bronzo lavorato da mano etrusca.

SOLAI, IMMAGINE DI UNA ANTICA CAVA DI TRAVERTINO
Un ex abitante del
posto ci ha raccontato che persone distinte e ben vestite, fecero portare via
questo cancello, lui dice di aver visto dove si trovava il cancello, prima che
fosse portato via, ma adesso che la parete è tutta
uguale sarebbe impossibile individuarne il punto
preciso.
Quello che non si
riesce a capire è, perché non ci fosse nulla dietro al cancello, nemmeno un
ingresso o un'entrata, solo pietra dura, e piatta, o almeno così sembra, ma
solitamente non si mette un cancello dove non c'è ingresso, quindi, sapendo la
posizione esatta, si potrebbe scoprire qualcosa. Ma lasciamo pure alcuni dubbi
su questo fatto, perché altrimenti si rischia di pensare troppo ad una cosa
tralasciandone altre, magari più importanti.
Un vecchio signore
che 40 anni fa abitava in un casolare dalle parti di Solaia, ci ha raccontato
che una notte, durante un sogno, l'immagine di un etrusco gli apparve dicendo
il punto preciso dov'era nascosta la propria tomba.
La descrizione
datagli nel sogno così diceva: "Tu vai in questo posto,

SOALIA, UNA DELLE MIGLIAIA DI TOMBE DEPREDATE IN ANTICO
e troverai, (ma solo
se ci andrai da solo), un Dromos, dapprima simile agli altri, ma poi la tomba si
dividerà in due camere, tu dovrai aprire quella di sinistra e troverai un tesoro
immenso".
Questo signore la
stessa notte, andò sul posto, e siccome era un po' pauroso e superstizioso,
portò con sé un amico.
Tutto era come
nel sogno, trovarono il Dromos di
normale fattura, poi dovettero scegliere, arrivati ai tappi, la camera di
sinistra, come aveva detto l'etrusco del sogno. La delusione fu grossa quando,
tolto il tappo di pietra che serrava l'ingresso della
camera, non trovarono un tesoro, ma solo
un mucchietto di cenere al centro del pavimento e nient'altro.
Ricoprirono tutto
per bene e, delusi tornarono ciascuno alla propria abitazione.

IMMAGINE DI TOMBA ETRUSCA – ULTIMI SCAVI
L'uomo anziano sognò
di nuovo quella notte, e ancora l'etrusco gli parlò dicendogli: "Ti avevo detto
d'andare da solo, ma non mi hai voluto ascoltare e quindi non meriti niente".
Poi gli disse di
riprovare, ma questa volta da solo, scegliendo la camera dì destra. L'uomo non
tornò subito sul posto, e fece passare un po' di tempo, ma quando decise di
tornarvi, l'erba era cresciuta e non riuscì a trovare il punto preciso dello
scavo.
Raccontando oggi
quest'avvenimento, amareggiato dice: "Avevo quasi trovato un tesoro, mi è
sfuggito per paura e per superstizione."
Queste storie sono
state raccontate per tanti anni, dai vecchi durante le
veglie, magari davanti ad un focolare acceso mangiando caldarroste, o dopo aver
trebbiato nell'aia durante la gran cena finale, o magari durante la
scartocciatura del granoturco, tra una barzelletta e l'altra.
Storie di tesori,
gente che di notte rientrando a casa vedeva per la strada delle galline coi
pulcini d'oro, ma non riusciva ad afferrarli, gente che ha
avuto apparizioni di etruschi nel bosco della Solaia. e che li descrive in un
modo realistico e
dettagliato.
Uno dei racconti che
ci ha
colpito di più è quello di un uomo, che quando era ragazzino giocando nei prati,
al di sotto della Solaia, tra il precipizio della Scalinata e Poggio Il Diavolo,
per nascondersi dai suoi amici durante i giochi, s'intrufolò in una piccola
apertura del terreno, all'interno constatò che era molto più grande di quanto
avesse immaginato, dopo aver camminato per parecchi metri sotto terra, si trovò
di fronte un lago sotterraneo molto grande, ai bordi del quale vi erano ingressi
di caverne che andavano in differenti direzioni, formando delle diramazioni a
stella.
Naturalmente questa
persona adesso anche volendo non si ricorderebbe più il punto preciso di questo
eccezionale ritrovamento, perché sono passati troppi anni. Noi siamo andati sul
posto con lui, ma dopo 40 anni è difficilissimo rintracciare in una così vasta
zona, un buco ormai ricoperto o otturato, di circa 80 centimetridi diametro.
Noi siamo certi che
in questa zona ci sia ancora tanto da scoprire, e molto più di quello che dice
la gente del posto. Non ci arrenderemo certo, perché le nostre ricerche daranno
sempre risultati affascinanti.
Vi siete mai chiesti
per esempio come avessero fatti gli etruschi a scolpire e scavare i loro Dromos
con un orientamento cardinale così preciso, senza adoperare una bussola? Gli
Etruschi non avevano una bussola, ma uno strumento precisissimo che noi, dopo
averlo scoperto, e ricostruito, abbiamo chiamato POLARIUM. Dal disegno si
capisce abbastanza bene com'era adoperato dagli Etruschi per orientare verso
qualsiasi punto cardinale, senza sbagliare di un grado l'orientamento dei loro
Dromos.

IL
POLARUM “
Il Polarum o
Polarium, non è altro che una vera e propria bussola dell'epoca etrusca. Era
usato dagli architetti disegnatori e progettisti di strutture architettoniche e
funebri.
L'utilizzo di
quest'apparecchio era estremamente semplice, e permetteva di stabilire senza
calcoli troppo complicati, i principali punti cardinali, poi di seguito anche i
rispettivi punti intermedi.
Il Polarium veniva
così utilizzato: costruito su di una pietra piatta, della grandezza di circa cm.
50x60 veniva appoggiato sul terreno in un punto piano con la parte più larga
rivolta al mezzogiorno.
Su questa pietra
veniva praticato un foro, dove poi si inseriva un'asse molto simile a quella di
una meridiana.
All'alba, appena
compariva sulla pietra l'ombra dell'asta centrale, veniva incisa una tacchetta
in corrispondenza del segno dell'ombra, si aspettava poi il tramonto, per
incidere una seconda tacchetta nel punto preciso in cui si trovava l'ombra al
momento della sua scomparsa.
A questo punto gli
etruschi prendevano una cordicella sottile, poi la tagliavano alla lunghezza
che coincideva con la prima tacchetta della mattina, e la seconda della sera, ed
il gioco era fatto, sarebbe bastato poi mettere, come si sol dire, doppia la
cordicella, per poi andare a segnare con la terza tacchetta il punto preciso
del mezzogiorno.
Facile in seguito
tracciare gli altri punti cardinali, eseguendo di seguito altri passi come il
secondo ed il terzo, ad ogni altro doppio della cordicella si trova un mezzo
punto, ed al prossimo doppio un quarto di punto.
Ecco quindi svelato
il mistero: gli etruschi avevano la bussola, ma non si chiamava così.
CENNI STORICI:
IL CULTO DEI MORTI
Gran parte delle conoscenze che abbiamo sulla
civiltà degli Etruschi proviene dalle tombe (iscrizioni, pitture, sculture,
suppellettili, ecc.). Naturalmente tutto questo materiale ci fornisce molte
informazioni su come veniva considerata la vita dopo la morte, e che sorta di
culto veniva riservata ai defunti. Abbiamo quindi prove inequivocabili di
quanto, secondo una credenza diffusa nel Mediterraneo, si ritenesse che la
individualità del defunto sopravvivesse alle sue spoglie mortali, nel luogo
stesso dove il corpo veniva sepolto o cremato. Ne consegue l’esigenza di
agevolare questa sopravvivenza, da parte dei congiunti, arredando il sepolcro
come una casa, contornando il defunto dei suoi gioielli, delle sue vesti,
eventualmente delle sue armi, e fornendo cibi e bevande.
Vennero così a formarsi grandi insiemi di tombe
disposte a file, divise da strade, che costituivano vere e proprie città dei
morti (necropolies), come mostrano gli esempi di Caere (Cerveteri) e di
Tarquinia. Le tombe più grandi spesso venivano fatte a imitazione delle case,
rivelando il lusso e il gusto artistico dei nobili etruschi.
All’origine veniva effettuato quasi
esclusivamente il rito della cremazione, ma in seguito solo poche città
continuarono a praticarlo, passando al rito più orientaleggiante
dell’inumazione. Nel casi della cremazione, le ceneri venivano conservate in
urne a forma di abitazioni o entro vasi che tentavano di riprodurre le fattezze
del morto, ma in un secondo periodo i corpi venivano adagiati su letti
direttamente scavati nella roccia o dentro sarcofagi di terracotta o altro
materiale.
L 'al di là:
La mistica unità del mondo celeste e del mondo
terrestre si estende
verisimilmente anche al mondo sotterraneo, nel
quale è localizzato, secondo le dottrine etrusche più evolute, il reame dei
morti. Gran parte delle nostre conoscenze sulla civiltà degli antichi Etruschi
proviene, come è noto, dalle tombe (la stragrande maggioranza delle iscrizioni è
di carattere funerario; alle pitture, alle sculture, alle suppellettili
sepolcrali siamo debitori dei dati fondamentali sullo sviluppo delle forme
artistiche e sugli aspetti della vita). Ed è naturale che le tombe ci offrano,
più o meno direttamente, indizi sulle credenze relative alla sorte futura degli
uomini e sui costumi e sui riti collegati a queste credenze. Ciò nonostante
siamo ancora ben lungi dall'avere una idea chiara dell'escatologia etrusca.
Motivi complessi e contrastanti denunciano livelli diversi di mentalità
religiosa ed influenze eterogenee. Ne risultano problemi tuttora in parte
irresoluti, singolarmente affascinanti.
Il carattere stesso delle tombe e dei loro
equipaggiamenti, soprattutto
nelle fasi più antiche, offre una testimonianza
inequivocabile del
persistere di concezioni primitive
universalmente diffuse nel mondo
mediterraneo, secondo le quali la individualità
del defunto, comunque immaginata, sopravvive in qualche modo congiunta con le
sue spoglie mortali, là dove esse furono deposte. Ne consegue l'esigenza,
fondamentale per i superstiti, di garantire, difendere, prolungare concretamente
questa sopravvivenza, non soltanto come tributo sentimentale di affettuosa
pietà, ma come obbligo religioso non disgiunto, probabilmente, da timore.
A questo genere di concezioni appartiene in
Etruria, come altrove (e segnatamente nell'antico Egitto), la tendenza ad
immaginare il sepolcro nelle forme di una casa, a dotarlo di arredi e di oggetti
d'uso, ad arricchirlo di figurazioni pregne, almeno originariamente, di
significato magico (specialmente pitture tombali con s.cene di banchetto, di
musica, di danze, di giuochi atletici, ecc.), a circondare il cadavere delle sue
vesti, dei suoi gioielli e delle sue armi; a servirlo con cibi e bevande; ad
accompagnarlo con figurine di familiari; e, infine, a riprodurre l'immagine
somatica del morto stesso, per offrire un incorruttibile «appoggio» allo spirito
minacciato dal disfacimento del corpo, onde in Etruria (come già in Egitto)
sembra nascere il ritratto funerario. Ma quale sia l'effettiva e più profonda
natura delle idee religio- se che traspariscono esteriormente in così fatte
costumanze e come esse abbiano potuto sussistere ed evolversi accanto ad altre
credenze è cosa ancora tutto sommato assai oscura.
All'origine della storia delle città etrusche
vediamo infatti dominare
pressoché esclusivo un rito funebre, quale è
quello della cremazione, che non può non riflettere concetti estranei a quelli
del legame materiale tra spirito e corpo del defunto; che anzi, almeno nella
piena età storica, esso sembra talvolta significare un'idea di «liberazione»
dell'anima dai ceppi della materia verso una sfera celeste. Tanto più curioso è
osservare come nelle tombe etrusche del periodo villanoviano e orientalizzante
le ceneri e le ossa dei morti bruciati si contengano talvolta in urne in forma
di abitazioni o entro vasi che tentano di riprodurre le fattezze del morto (i
così detti "canopi" di Chiusi): ciò che rivela, già dai tempi più antichi del
formarsi della nazione etrusca, una mescolanza di credenze e forse anche un
riaffermarsi delle tradizioni funerarie mediterranee sul costume diffuso dai
seguaci della cremazione. Ne si può affermare che l'idea della sopravvivenza
nella tomba escluda assolutamente una fede nella trasmigrazione delle anime
verso un regno dell"'al di là". Ma è certo che in Etruria quest'ultima
concezione si venne affermando e concretando progressivamente sotto l'influsso
della religione e della mitologia greca, con l'attenuarsi delle credenze
primitive: e si configurò secondo la visione dell'averno omerico, popolato da
divinità ctonie, spiriti di antichi eroi ed ombre di defunti. Già nei monumenti
del Ve IV secolo, e poi soprattutto in quelli di età ellenistica, la sorte
futura è rappresentata come un viaggio dell'anima verso il regno dei morti e
come un soggiorno nel mondo sotterraneo. Soggiorno triste, senza speranza, a
volte dominato dallo spavento che incute la presenza di mostruosi dèmoni, o
addirittura dai tormenti che essi infliggono alle anime. È, in sostanza, la
materializzazione dell'angoscia della morte in una escatologia essenzialmente
primitivistica. E a simboleggiare la morte sono specialmente due figure
infernali: la dea Vanth dalle grandi ali e con la torcia, che, simile alla greca
Moira, rappresenta il fato implacabile; e il dèmone
Charun, figura semibestiale armata di un pesante
martello, che può
considerarsi una paurosa deformazione del greco
Caronte dal quale prende il nome. Sia di Vanth sia di Charun esistono
moltiplicazioni, forse con una propria individualità ed un proprio secondo nome.
Ma la demonologia infernale è ricca e pittoresca, e conosce altri personaggi,
come l'orripilante Tuchulcha dal volto di avvoltoio, dalle orecchie d'asino e
armato di serpenti; accoglie largamente la simbologia di animali ctonii, come il
serpente e il cavallo.
Anche per questa fase più tardiva le fonti
monumentali, nei loro aspetti frammentari ed esteriori, sono insufficienti a
darci un'idea sicura e completa delle credenze contemporanee sull'oltretomba.
Stando alle pitture e ai rilievi sepolcrali, parrebbe che il destino dei morti
fosse inesorabilmente triste ed uguale per tutti: la legge crudele non risparmia
neanche i personaggi più illustri, la cui affermazione di superiorità si limita
ai costumi sfarzosi, agli attributi delle cariche rivestite e al seguito che li
accompagna nel viaggio agli inferi. Esistono tuttavia nella tradizione
letteraria, alcuni accenni più o meno espliciti a consolanti dottrine di
salvazione, e cioè alla possibilità che le anime conseguano uno stato di
beatitudine o addirittura q i deificazione, attraverso speciali riti che
sarebbero stati descritti dagli Etruschi nei loro Libri Acherontici. Un prezioso
documento originale di queste cerimonie di suffragio, con prescrizioni di
offerte e di sacrifici a divinità specialmente infernali, sembra esserci
conservato nel testo etrusco della tegola di Capua, che risale al V secolo a.C..
Non sappiamo fino a che punto allo sviluppo di queste nuove concezioni
escatologiche abbia contribuito il diffondersi in Etruria di dottrine orfiche,
pita- goriche e, più ancora,
dionisiache (il culto di Bacco è, in verità,
largamente attestato anche in rapporto con il mondo funerario). Comunque le
speranze di salvazione sembrano restare collegate al concetto delle operazioni
magico-religiose, proprie di una spiritualità primitiva, piuttosto che dipendere
da un superiore principio etico di retribuzione del bene compiuto in vita.
Forme del culto
Le testimonianze monumentali, i documenti
scritti etruschi e i riferimenti delle fonti letterarie classiche offrono
numerosi dati per la ricostruzione della vita religiosa e delle forme del culto.
Si tratta di costumanze che, almeno per quel che riguarda gli aspetti
sostanziali (luoghi sacri e templi, organizzazione del sacerdozio, sacrifici,
preghiere, offerte di doni votivi, ecc.), non differiscono profondamente dalle
analoghe manifestazioni del mondo greco, italico e, specialmente, romano. Ciò si
spiega per un verso
considerando i comuni orientamenti spirituali
della civiltà greco-italica a partire dall'età arcaica, per altro verso tenendo
conto della fortissima influenza esercitata dalla religione etrusca su quella
romana.
Uno studio delle antichità religiose etrusche
non può quindi prescindere dal quadro, ben altrimenti particolareggiato e
complesso, che in materia rituale ci presentano
Sarà, in primo luogo, da attribuire agli
Etruschi quella concreta e quasi materialistica adesione a norme sancite ab
antiquo, quel preoccupato formalismo dei riti, quel frequente insistere sui
sacrifici espiatorii, che si avvertono nell'ambito delle tradizioni religiose
romane come un elemento in certo senso estraneo alla semplice religiosità
agreste dei prisci Latini e indizio della presenza di un fattore collaterale che
non può non riportarsi ad una antica e matura civiltà cerimoniale, quale è
appunto l'etrusca. Questa ars colendi religiones (secondo l'espressione di Livio
nel passo sopra citato) risponde in pieno al senso di subordinazione dell'uomo
alla divinità, che sappiamo predominante nella religiosità etrusca e presuppone
la fede nella efficacia magica del rito, proprio delle mentalità più primitive.
La concretezza degli atti cultuali si manifesta nella precisa
determinazione dei luoghi, dei tempi, delle
persone e delle modalità, entro i quali e attraverso i quali si compie l'azione
stessa volta ad invocare o a placare la divinità: quell'azione che i Romani
chiamavano nel loro complesso res divina e gli Etruschi probabilmente ais(u)na
(cioè, appunto, servizio
"divino", da ais "dio"): donde, anche, la parola
umbra esono "sacrificio".
Essa si svolge nei luoghi
consacrati (tempia) dei quali si è fatta già
menzione: recinti con altari ed edifici sacri
contenenti immagini delle
divinità. Sovente questi edifici sono orientati
verso sud e sud-est.
Il concetto di consacrazione al culto di un
determinato luogo o edificio è forse espresso in etrusco dalla parola sacni
(donde il verbo sacnisa):
questa condizione può estendersi, come in Grecia
e nel mondo italico e romano, ad un complesso di recinti e templi, per esempio
sulle acropoli delle città (Marzabotto); carattere in certo senso analogo hanno
anche le tombe, presso le quali o entro le quali si compiono sacrifici funerari
o si depongono offerte.
Speciale importanza deve avere avuto in Etruria
la regolamentazione
cronologica delle feste e delle cerimonie, che,
insieme con le modalità delle azioni sacre, costituiva la materia dei Libri
Rituales ricordati dalla tradizione. Il massimo testo rituale etrusco,
tramandatoci nella linguaoriginale -e cioè il manoscritto su tela parzialmente
conservato nelle fasce della mummia di Zagabria - contiene un vero e proprio
calendario liturgico, Con l'indicazione dei mesi e dei giorni ai quali si
riportano le cerimonie descritte. È probabile che altri documenti fossero
redatti nella forma attestata dai calendari sacri latini: e cioè come una
elencazione consecutiva di giorni contrassegnati dal solo titolo delle feste o
dal nome della divinità celebrata.
Il calendario etrusco era forse analogo al
calendario romano precesareo: conosciamo il nome di alcuni mesi e sembra che le
"idi", circa a metà del mese, abbiano un nome di origine etrusca; ma il computo
dei giorni del mese segue generalmente, a differenza del calendario romano, una
numerazione consecutiva. Ogni santuario ed ogni città doveva avere, come è
logico, le sue feste particolari: tale è appunto il caso del sacni cilfh
(santuario di una città non altrimenti identificabile), al quale fa riferimento
il rituale di Zagabria. Le celebrazioni annuali del santuario di Voltumna presso
Volsinii avevano invece carattere nazionale, come sappiamo dalla tradizione.
Tra le cerimonie e gli usi sacri può ricordarsi
quello della infissione dei chiodi per segnare gli anni (clavi annales) nel
tempio della dea Nortia a Volsinii, ricordato a proposito dell'analogo rito del
tempio di Giove Capitolino a Roma. Anche per intendere la natura e
l'organizzazione dei sacerdozi siamo costretti ad avvalerci del confronto con il
mondo italico e romano.
Abbiamo in ogni caso indizi per ritenere che
essi fossero varii e
specializzati, strettamente collegati con le
pubbliche magistrature e
sovente riuniti in collegi. Il titolo
sacerdotale cepen (con le variante
cipen attestata in Campania), particolarmente
frequente nei testi etruschi, è ad esempio seguito spesso da un attributo che ne
determina la sfera d'azione o le specifiche funzioni: come nel caso di cepen
fhaurx, che senza dubbio indica un sacerdote funerario (da fhaura «tomba»). La
dignità sacerdotale in genere o specifici sacerdozi sono designati anche con
altre parole: quali eisnevc (in rapporto con aisna, l'azione sacrificale), celu,
forse santi, ecc. Si hanno inoltre i sacerdoti divinatori: e cioè gli aruspici
(netsvis), rappresentati nei monumenti con un costume caratteristico composto di
un berretto a terminazione cilindrica e di un manto frangiato, e gl'interpreti
dei fulmini (trutnvt?). Il titolo marun-, è, come già sappiamo, in rapporto con
funzioni sacrali, per esempio nel
culto di Bacco (marunux paxanati, maru
paxafhuras): si osservi il doppio titolo cepen marunuxva, che indica
probabilmente un sacerdozio con le funzioni proprie dei maru. Si può ricordare
anche il titolo zilx cexaneri, nel quale si è voluto intendere qualcosa come
"curator sacris faciundis", (ma è congettura molto opinabile). Probabilmente a
confraternite si riferiscono termini collettivi quali paxafhuras,
formalmente analoghi a quelli che esprimono aggregati gentilizi (per es.
Velfhinafhuras nel senso dei membri della famiglia Velfhina) o altri collegi.
A Tarquinia esisteva in età romana un arda LX
haruspicum veri similmente di antica origine. Uno degli attributi dei sacerdoti
era illituo, bastone dall'estremità ricurva, che è però frequentemente
rappresentato nei monumenti anche in rapporto ad attività profane, per esempio
in mano ai giudici delle gare atletiche. L 'azione del culto è volta ad
interrogare la volontà degli dèi, secondo le norme dell'arte divinatoria; e
quindi ad invocare il loro aiuto e perdono attraverso l'offerta. È probabile che
l'una e l'altra operazione fossero strettamente collegate tra loro; benche sia
ricordata dalle fonti letterarie una distinzione tra vittime sacrificate per la
consultazione delle viscere (hastiae cansultatariae) e vittime destinate
all'offerta vera e propria, in sostituzione dei sacrifici umani (hastiae
animales). Del pari intrecciate in complicati cerimoniali sembrano le offerte
incruente (di liquidi e cibi) con quelle cruente di animali.
Il grande rituale di Zagabria e il rituale
funerario della Tegola di Capua descrivevano minuziosamente, in tono
prescrittivo e con un linguaggio tecnico specializzato, queste liturgie; ma lo
stato delle nostre cognizioni della lingua etrusca non ci consente di stabilire
con esattezza il significato di molti 'termini impiegati nella descrizione dei
riti e, pertanto, di ricostruirne in pieno lo svolgimento. La preghiera, la
musica, la danza dovevano avere larga parte nelle cerimonie. Una scena di culto
con offerte è rappresentata nella parete di fondo della Tomba del Letto Funebre
di Tarquinia.
I doni votivi offerti nei santuari, per grazie
chieste o ricevute,
consistono per lo più di statue di bronzo,
pietra, terracotta, raffiguranti le divinità stesse e gli offerenti, o anche
animali, in sostituzione delle vittime, e parti del corpo umano; inoltre vasi,
armi, ecc. Questi oggetti che erano ammassati in depositi o favisse, recano
spesso iscrizioni dedicatorie. Essi variano per valore artistico e per pregio
(la massima parte è costituita da modeste figuri ne di terracotta lavorate a
stampo): ciò che indica, intorno ai grandi centri del culto, una diffusa e
profonda religiosità popolare.
Il culto degli dei:
Dopo che i sacerdoti avevano ottenuto attraverso
la divinazione la
conoscenza del volere divino, si dava attuazione
a tutto ciò che ne derivava dal punto di vista del comportamento, sulla base
delle norme che facevano anch'esse parte della ''disciplina etrusca" ed erano
oggetto di trattazione nei Libri Rituales. Queste norme si traducevano (e si
esaurivano) in una serie impressionante di pratiche, cerimonie e riti
rigidamente codificati e ripetuti meccanicamente fino a diventare puro e
semplice formalismo.
Essi toccavano sia gli aspetti religiosi della
vita degli etruschi sia quelli civili, secondo il principio che ''ogni azione
umana doveva essere compiuta in conformità della disciplina". E per ogni rito,
cerimonia di culto o servizio divino doveva essere stabilito con precisione il
luogo, il tempo, il modo, lo scopo, la persona preposta e, naturalmente, la
divinità che veniva chiamata in causa. Le funzioni sacre si svolgevano perciò in
luoghi rigidamente circoscritti e consacrati (templi, santuari, altari) e il
loro svolgimento era codificato fin nei minimi particolari tanto che, se veniva
sbagliato od omesso anche un solo gesto, tutta l'azione doveva essere ripetuta
da capo. Musica e danza vi trovavano ampio spazio. Oltre all'uso di
sacrificare bovini, ovini e volatili,
particolarmente diffuso era quello dei doni votivi che potevano andare dagli ex
voto (statue e statuine di divinità e di offerenti), alle prede di guerra (armi,
carri), agli stessi edifici sacri (dedicazione di un tempio o di un sacello).
Tra le pratiche di carattere religioso quelle
destinate ai defunti avevano presso gli etruschi un carattere tutto particolare.
Esse erano legate alla concezione (del resto diffusa in altre civiltà del
Mediterraneo) che l'attività vitale del defunto, la sua ''individualità"
continuasse anche dopo la morte e che questa sopravvivenza avesse luogo nella
tomba.
Spettava però ai vivi, ai familiari e dei
parenti, garantire la sopravvivenza dell'entità vitale del defunto al quale
doveva essere data una tomba, cioè una nuova casa, e un corredo di abiti,
oggetti d'uso personali, cibi, di cui si serviva simbolicamente o magicamente.
Per la stessa ragione vitalità e forza venivano trasmesse al defunto con giochi
e gare atletiche che si svolgevano in occasione dei funerali o delle ricorrenze
anniversarie della
morte. Quanto alle pratiche proprie dei
funerali, la prassi non era
dissimile da quella che avveniva altrove:
esposizione del cadavere al
compianto pubblico e alle lamentazioni di donne
appositamente pagate (prefiche), corteo funebre e banchetto presso la tomba. Il
culto della ''sopravvivenza" nel sepolcro era ulteriormente sviluppato nel culto
degli antenati e in particolar modo del capostipite, specie delle famiglie
gentilizie. Tra il V e il IV secolo a.C., però, la fede della sopravvivenza del
morto nella tomba cambiò sotto l'effetto delle suggestioni provenienti dalla
civiltà greca. Ad essa si sostituì la concezione di un ''mondo dei morti"
(simile all'Averno o all'Ade) dove le ''ombre" soggiornavano.
Ai defunti vennero allora dedicati particolari
riti di suffragio, stabiliti dai Libri Acherontici, e offerte alle divinità
infere (in particolare il sangue di alcuni animali) che potevano consentire alle
anime il conseguimento di uno speciale stato di beatitudine.
Capitolo
3
Sempre
da esperta guida
Zona “

Località COLOMBARA
Il casolare
Colombara, o come lo chiamavano i contadini che v'abitavano
"Il Colombaro"
si trova a pochi chilometri dalla autostrada A1.
Ad un'altezza sul
livello del mare di
Ci si arriva
passando per "l'allevamento cavalli
Forneris", "Il Canneto", due chilometri
prima del casello autostradale Chiusi‑Chianciano scendendo da Sarteano, sulla
destra, a circa un chilometro dalla strada provinciale.
Il vecchio podere
appare ormai in disuso, circondato da erbe alte e rovi, il casolare ci fa
l'effetto di una città morta, dà un senso di desolazione, non vi abita più
nessuno da molto tempo e non possiamo farci niente se la natura a poco a poco,
sta risucchiando le mura indebolite dall'umidità e dall'incuria dell'uomo. Un
tempo era un casale veramente bello, completo di vasche con acqua corrente sotto
casa per i bucati a mano di una volta.
In questa località
nell'anno 1871 il Sig. Gamurrini scoprì i resti di un edificio

UN
RITRATTO DEL RE PORSENNA
termale,
appartenente all'epoca Augustea, presso le rovine, delle terme romane con
paramenti in Opus. Il Gamurrini rinvenne una grande tazza di vetro turchino, 4
lastre di tipo Campana, una raffigurava una giovane donna probabilmente
Aphrodite, seduta su un Diphrus, in conversazione con un piccolo Eros, e con un
cane seduto dietro di loro di circa 44x46 centimetri.
Alla sinistra del
podere, oltrepassata la strada c'è un vecchio stabile un po' più piccolo dove
erano tenuti gli animali.
Aggirando questo
stabile, anch'esso lui ormai in disuso, e guardando verso est si vede
l'autostrada Al, pochi metri più
avanti c'è una tomba etrusca e Dromos corto, orientata ad est. All'interno molto
spaziosa, è una delle più grandi tombe in questa zona, sopra di essa è nata una
pianta di fichi che ha affondato le radici fino a dentro la camera, il Dromos è
corto e in discesa, il pavimento
della camera è più basso di circa 25 centimetridel piano terreno. La gente del
podere dice che questa tomba fu scavata al tempo della costruzione dello stesso
e che i materiali ritrovati all'interno furono dati al conte, a quei tempi,
della Città di Chiusi. Questo podere è molto importante per noi, e non solo per
le sue quattro o cinque tombe ancora nascoste, scoperte ed individuate qui
accanto, ma perché questa posizione èra un passaggio,
obbligato, molto importante poiché più avanti su questa strada è situato il
podere
La tomba che vediamo
qui sicuramente è quella centrale, di una formazione a schiera, ossia
lateralmente dovrebbero esserci altre tombe non ancora profanate, tre a
sinistra e tre a destra a tre metri l'una dall'altra, e in riga, tracciando la
traiettoria diritta, ed impostata "sud-nord".
Sotto la strada, a
pochi metri dal Podere il suolo è di composizione pietrosa, con molte Tagliate,
(Tagliature di un metro circa nella pietra, geometricamente precise e lineari),
questo fa capire che in questa zona gli etruschi si fornivano di pietra a forma
di blocchi cubici, magari per le loro costruzioni, o per usarle come pietre, per
tappi o cippi tombali.
Nella campagna a
metà strada tra il podere Colombara e Il Canneto durante la lavorazione dei
campi per la semina, gli operai hanno scoperto molte volte dei mattoni e delle
tegole etrusche, hanno notato inoltre, che in certi punti esistono a mezzo metro
sotto terra dei canali molto lunghi di tipo: "Cunicoli a 4 mattoni a secco
simili a fognature di scarico quadrangolari". Questi canali scorrono verso il
basso in direzione del fiume Astrone, e sicuramente si trovano in questo punto,
perché le varie sorgenti e le acque trovate in questa zona fanno supporre che un
tempo, esistessero delle terme etrusche, ed i canali sotterranei sarebbero
serviti a convogliare le acque fino al fiume, facendo dei tragitti strategici.
Ma c'è di più:
questa è una zona di ZIRI, (così sono chiamati da queste

INGRESSO DI UNA TOMBA ETRUSCA PROFANATA IN ANTICO
parti quei
recipienti in terracotta murati sotto terra, e contenenti spesso dei preziosi
oggetti, come monete, fibule ecc), venivano praticamente usati come i nostri
moderni salvadanai, e a volte erano vere e proprie Tombe con all’interno il
corredo del defunto.
Un signore che un
tempo faceva il trattorista, ci ha raccontato che moltissime volte durante
l'aratura di questi campi, si accorgeva di tanto in tanto, che con la terra
l'aratro portava in superficie anche qualche tappo di Ziro, e a volte dei rossi
Tegoli, o mattoni.
Questo fa supporre
che questi prati, adesso pascoli per cavalli, un tempo fossero abitati da
etruschi, e che nascosti, ci siano ancora molti ZIRI e reperti, che la terra
prima o poi ci dovrà restituire. Sulla parte ad ovest del podere invece fra gli
uliveti esistono delle "nicchie a muro", cioè scavate nella facciata ad est
delle pietre sporgenti dal terreno, con pareti verticali che hanno una sporgenza
abbastanza alta da far sì che gli etruschi riuscissero a scavarvi dei buchi a
semisfera, tappati poi con dei Tegoli rossi, gialli, o muratura a tufo. Dentro
queste nicchie venivano messi dei vasi ed anche degli oggetti di bronzo,
specchietti, o pettini. Passeggiando per queste campagne, ogni tanto si possono
vedere sul terreno alcuni pezzi più o meno grandi di questi tappi di nicchie, i
quali erano costruiti in un materiale rosso, molto simile a quello dei mattoni,
ma più robusti, questo materiale è composto in parte da sostanza metallica,
questo perché i tegoli o tappi da nicchia fanno suonare i metaldetector come se
contenessero del ferro.
IL RE
PORSENNA
II tesoro nascosto più antico d’Italia è
certamente quello del re etrusco Porsenna, che risale al V secolo a. C. «Non c’è
popolo europeo ha scritto Werner Keller, autore fra l’altro del famosissimo
Questo antichissimo popolo italico si e lasciato
dietro un alone di mistero e una fama poco invidiabile. Venuti non si sa da dove
e nascosti dietro una lingua indecifrabile, gli etruschi sono stati presentati
per secoli attraversò tutta l’età classica come una razza di pirati crudeli,
adoratori di dei infernali, superstiziosi cultori di un’arte divinatoria spinta
sino al limite della follia, e incalliti libertini dediti ai piaceri più
smodati.
Solo negli ultimi decenni questo quadro è stato
smontato pezzo per pezzo egli etruschi, provenienti con ogni probabilità
dall’Asia Minore, hanno riassunto il loro vero volto di popolo civilissimo,
dedito ai commerci marittimi ne più ne meno dei fenici e dei greci; inclini ai
presagi offerti dai fenomeni naturali come tutti i popoli antichi; e colpevoli
del solo reato contro la morale di ammettere ai loro conviti anche le donne,
contrariamente ai pregiudizi misogini del mondo ellenico.
Anche il mito della lingua misteriosa si è
andato sfaldando seppure a fatica per lasciare il posto a testimonianze non
tanto indecifrabili, quanto indecifrate, e soprattutto difficili da interpretare
ai fini di un’esatta comprensione di quell’antica cultura. Una cosa però è quasi
certa: Roma nasce etrusca, fondata non dal suo eponimo Remolo ma dal terzo dei
suoi mitici re, Tarquinio Prisco, un etrusco poi seguito da altri due sovrani
della stessa origine, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. L’ultimo re di Roma
il Superbo, appunto viene cacciato attorno al
L’Etruria si stendeva dall’attuale Lazio
settentrionale a tutta
La leggenda pone sulla strada del re etrusco due
eroi destinati a fama imperitura: Muzio Scevola, che dopo aver fallito un
attentato contro la vita del lucumone decide di castigarsi da solo stendendo la
mano su un braciere ardente; e Orazio Coclite, l’orbo impavido che da solo
riesce a bloccare l’esercito nemico nel mezzo di un ponte sul Tevere. Gloriosi
episodi individuali che, come spesso avviene, serviranno agli storici della Roma
imperiale per abbellire la sgradevole realtà di un’occupazione manu militari
della Città Eterna.
Ma Porsenna, una volta padrone di Roma, non
rimette sul trono Tarquinio il Superbo; e cosi gli etruschi dopo aver fondato
l’Orbe diventano anche i padrini di quella Repubblica che poco a poco diventerà
la massima potenza del Mediterraneo per oltre quattro secoli prima di cedere il
passo all’Impero dei Cesari: un nuovo astro sorge, mentre il predominio etrusco
s’avvia al tramonto; e fora Porsenna, saggiamente, opta ben presto per far
ritorno a Chiusi dove morirà poco più tardi.
La tomba del lucumone è imponente, come si
addice a un personaggio di tanta rilevanza storica e leggendaria. Scrive Plinio
il Vecchio nel I sec. a. C., citando Varrone: «II re Porsenna giace sepolto nel
sottosuolo della città di Clusium, sotto un monumento di pietre squadrate, largo
Plinio non parla del tesoro, ma è noto che gli
etruschi con il loro culto della vita nell’oltretomba usavano riempire le
estreme dimore dei personaggi più importanti di preziosa oreficeria, come è
dimostrato dai vari ritrovamenti succedutisi nel tempo: lamine d’oro a Pyrgi,
collane e fibule a Vulci, monete d’oro e d’argento a Populonia; e poi scarabei
di pietre dure, bronzetti votivi, anfore, ceramiche, canopi dalla testa
d’animale.
Nel corso dei secoli la caccia al tesoro etrusco
è sempre stata di moda. A cominciare dal re ostrogoto Teodorico che nel V secolo
d. C. statuiva: «È conforme all’uso tradizionale restituire all’utilizzazione
umana i tesori che giacciono sotto terra e non lasciare ai morti ciò che può
ancora servire ai vivi. Onde noi ordiniamo di iniziare ricerche affinché l’oro e
l’argento vengano portati alla luce del sole, rispettando solo ciò che serve ai
morti, come le ceneri custodite nei mausolei e le colonne che ornano le tombe,
mentre non è disdicevole sottrarre l’oro che non ha più padrone...»
Da allora attraverso i secoli bui, il Medio Evo
e il Rinascimento il saccheggio delle tombe etrusche è continuato senza
interruzione, restituendo all’utilizzazione umana, come pudicamente si esprimeva
Teodorico vere e proprie montagne di oro lavorato e di gioielli.
La ricerca diventa sistematica nell’800, a opera
soprattutto dei principi Torlonia, proprietari di vasti domini presso Vulci, che
si circondano di archeologi ed esperti, come [’incisore francese Alphonse
Francois dotato di un fiuto straordinario e destinato a diventare famoso per la
scoperta presso Chiusi, nel 1845, del vaso che ancor oggi porta il suo nome. Ma
neanche il ‘naso’ di Francois è sufficiente per rintracciare la famosa ‘tomba di
Porsenna e il mitico tesoro Che secondo le leggende, vi sarebbe contenuto.
Certo, le imponenti cinque piramidi di cui
parlava Varrone — con i dischi di bronzo e le campanelle che tintinnano al
minimo soffio di vento — non ci sono più: ma Chiusi, l’antica Clausium, deve pur
ospitare da qualche parte il rifugio ipogeo del suo lucumone più famoso.
Per molto tempo le speranze si sono volte verso
il Poggio della Gaiella,
Un’altra vampata di entusiasmo si è accesa
alcuni anni fa, quando proprio nel centro storico, sotto la piazza del Duomo, è
stato scoperto un grande vano, sorretto da un pilastro e con le pareti ricoperte
di travertino. La ‘tomba di Porsenna ? La sala ha però condotto soltanto a un
nuovo labirinto che si è rivelato deludente quanto quello di Poggio della
Gaiella.
Il cosiddetto ‘mistero etrusco
ha anche eccitato la fantasia di gruppi esoterici che a decine si sono
dedicati all’impresa di stabilire un contatto, più o meno astrale, con gli
spiriti.
Il
Re e i fulmini:
Questa è una delle leggende etrusche di cui si è
conservata memoria. Plinio il Vecchio narrando del comportamento dei fulmini,
riporta una storia etrusca secondo la quale un fulmine fu evocato dal re
Porsenna per distruggere il mostro Olta che minacciava la città di Volsinii. Qui
un animale mostruoso dalla testa di lupo viene spinto dentro un puteale, cioè
una struttura simile ad un pozzo, che veniva costruita attorno ai luoghi colpiti
dalle saette: erano delle vere e proprie <tombe> dei fulmini.
Scoperto
il mausoleo di re Porsenna?
Ciò che rimane della tomba del re etrusco
Porsenna, il lucumone (o. magistrato con supremo potere civile, militare,
religioso) vissuto nel VI secolo avanti Cristo e che riuscì anche a espugnare
Roma, si troverebbe in un pianoro di ventisei ettari a est di Sarteano, nel
cuore dell’Etruria, e non a Chiusi (dove il sovrano nacque), come ritenuto in
prevalenza dall’archeologia ufficiale e soprattutto dallo storico latino
Varrone. A sostenerlo è l’architetto Angelo Vittorio Mira Bonomi dice in un
volume di oltre centoquaranta pagine corredato di foto, schemi e disegni, spiega
come il monumento non sarebbe una semplice tomba, ma un santuario-mausoleo ben
più grande, che per dimensioni e caratteristiche non poteva assolutamente
poggiare sul terreno sedimentario di Chiusi, ma soltanto su un basamento
roccioso come appunto è il pianoro.
Secondo Mira Bonomi, il mausoleo sarebbe stato
composto da un blocco quadrato di quasi ottantanove metri per lato, sormontato
da cinque piramidi, quattro ai lati e una al centro, alte ciascuna circa quattro
metri. Sarebbe stato costruito in travertino locale, legno e bronzo e per
portare a termine l’opera, una costruzione del tutto degna delle piramidi
egiziane, gli operai avrebbero impiegato, secondo le ipotesi dell’architetto,
ben undici milioni di ore lavorative.
E certo comunque che la tomba di Porsenna è da
secoli al centro dei pensieri e delle fantasie degli studiosi di tutto il mondo,
ma in realtà non è mai stata nemmeno lontanamente individuata. Nel cuore del
mausoleo, secondo gli scritti di Var-rone e di Plinio il Vecchio, sarebbe anche
nascosto un grande tesoro ed è proprio questo particolare a destare maggiori
preoccupazioni: si teme infatti che alla caccia “ufficiale” al monumento si
affianchi anche quella illegale dei
“tombaroli”.
In località Pianacce. A Sarteano (Si) proprio
dove noi avevamo fatto le più importanti segnalazioni, sembra sia venuto alla
luce un muro di fondamenta del V secolo, molto probabilmente annesso al Mausoleo
del Porsenna. Se così fosse: noi , con il nostro libro, e con le nostre scoperte
e segnalazioni, saremmo stati talmente precisi, da indicarne la esatta
locazione, gia 13 anni prima della venuta alla luce delle sue prime tracce.
Fiere
parole Da Gaio Muzzio Al Re Porsenna:
Mentre se ne andava di lì, facendosi largo da
dove egli stesso si era aperto un
varco con la spada insanguinata
attraverso la folla impaurita, poiché, accorsa la gente al rumore, le guardie
del re lo avevano arrestato, bloccato, lo portarono (lett. condotto) davanti al
seggio del re, perfino allora temibile più che timoroso, in mezzo a così grandi
minacce della sorte, disse: “Sono cittadino romano; mi chiamano Gaio Muzio.
Nemico, ho voluto uccidere un nemico, e di
fronte alla morte non ho minor coraggio di quanto ne ebbi di fronte
all’uccisione; tanto compiere quanto subire azioni valorose è degno di Romani.
Né io solo ho concepito questi sentimenti nei tuoi confronti; dopo di me c’è una
lunga fila di nomi che aspirano allo stesso onore. Perciò preparati a questa
prova, se ti piace: a lottare ogni ora del giorno per la tua vita, e ad avere un
pugnale nemico nell’atrio della reggia. Questa (è) la guerra che noi gioventù
romana, ti dichiariamo (lett. Questa guerra la gioventù romana dichiariamo).
Non temere nessun esercito, nessuna battaglia:
la cosa si deciderà fra te solo e ciascuno di noi.”
LABIRINTO "MAUSOLEO O TEMPIO"
Possiamo perfino chiederci se esistesse ancora
qualche cosa ai tempi di Varrone: è vero che il tratto citato è scritto al
presente, ma la notizia rimanne incompleta, secondo Plinio, perché Varrone
ripugnò - puduit – ad indicare l’altezza delle piramidi più elevate, come se
seguisse fonti di cui non si sarebbe veramente fidato, senza possibilità di
verificare sul posto.
E Plinio ricorda fabulae Etruscae per trovare la
precisazione sulla quale conclude la descrizione del monumento, di cui affermava
sin dall’inizio la fabulositas.
Lo scetticismo dei due antiquari è abbastanza
giustificato dalla sparizione di una costruzione alla quale la tradizione
attribuiva dimensioni considerevoli: una base quadrata di
Inoltre, queste stesse cifre, che suppongono un
modulo di
Rimane comunque un punto della descrizione del
monumento che sembra importante, mentre è più o meno trascurato dai
“ricostruttori”: tutti si sforzano di ritrovare la disposizione delle piramidi
su parecchi livelli, con piattaforme che le collegano e gli accessori, dischi o
gugliette, che le sormontano, ma ben pochi si preoccupano dell’ interiore della
base stessa del monumento, del cosiddetto labirinto che avrebbe contenuto e che
giustificherebbe il nome dato all’insieme.
E’ vero che la parola
sembra a volte indicare un monumento importante di pietra, senza che ci
fosse necessariamente dentro un percorso labirintico nel senso stretto che diamo
oggi a questo termine.
Perfino nell’elenco dei quattro labirinti che
da’ Plinio, è chiaro che almeno uno, quello che si colloca a Lemno – ma che
doveva trovarsi piuttosto a Samo non comportava nessun percorso completo, ma
solo un insieme di cento cinquanta colonne perfettamente equilibrate: Eppure nel
caso del monumento di Chiusi Varrone insiste sulla presenza di un vero labirinto
inextricabilis, che si ritrova in un Virgilio, nella descrizione del labirinto
cretese figurato sulle porte del tempio di Apollo a Cuma; poi parla della
necessità di utilizzare un filo per dirigersi dentro, ciò che non può non far
pensare al filo dato da Arianna a Teseo.
Questo labirinto è un labirinto quadrato.
Sappiamo che le monete di Cnoso rappresentano quello che sembra essere la pianta
del labirinto cretese, il più spesso sotto la forma di un disegno quadrato, ma
almeno una volta sotto la forma di un disegno rotondo.
Nella stessa Etruria, l’oinochoe di
Tragliatello, presenta un labirinto di forma rotonda, abbastanza grossolano.
In quanto alla ricerca sul territorio, si è
potuto credere un tempo che la sepoltura del re etrusco fosse stata ritrovata
nel tumulo di Poggio Gaiella , esplorato nel 1841, poi è stato capito che i
corridoi sotterranei che collegano le diverse camere funerarie fossero
probabilmente opera di tombaroli e non potessero dunque
rappresentare i passaggi di un labirinto antico.
E’ certo possibile supporre che codesto tumulo
sopportasse la costruzione descritta da Varrone, ma l’ipotesi e perfettamente
gratuita.
In realtà il problema della localizzazione
esatta del labirinto toscano si poneva già a Plinio, poiché non c’èra più
nessuna traccia nel suo tempo, come per il labirinto cretese.
Si dice che Papa Pio II, recandosi al congresso
di Modena nel 1459, e passando per Chiusi, cercò il labirinto che Porsenna, re
leggendario della città, avrebbe fatto costruire come sepoltura: l’interesse
archeologico per questo monumento non è dunque cosa nuova!
Ma di questo sepolcro sappiamo solo quello che
ci fornisce una testimonianza indirette di Varrone, trasmessa da Plinio, che
l’ha completata con dati presi, secondo le sue parole, dalle fabulae Etruscae.
Ancora la descrizione varroniana , "... Sepultus
sub urbe Clusso ... ", ci indica una posizione geografica che va interpretata
dalla cultura contemporanea.
Per le ragioni già espresse, il comprensorio
chiusino retto da Porsenna era un agglomerato di villaggi poiché dall'analisi
dei reperti archeologici lo sviluppo della Val di Chiana incominciò all'inizio
del VI sec. e fu rapido ( L. Banti, op. CIT. p. 226)
Il carattere agricolo di questa espansione è
dimostrato dal tipo dei nuovi insediamenti : fattorie, abituri, villaggi, di cui
si hanno tombe isolate, piccole necropoli lungo
In questa visione protourbana dove il concetto
dell'urbe usato dallo storico Varrone non è applicabile perché la città del VI
sec. nell'attuale centro di Chiusi non esiste, mentre esistono resti
attribuibili sempre a Età etrusche più recenti, la preposizione .sub + ablativo
con verbo di stato, credo vada interpretata come "davanti a", "nei pressi di",
dinnanzi a", e quindi "...
fu sepolto davanti alla città di Chiusi ... "
intesa come comprensorio protourbano di aggregazioni di villaggi densamente
popolati, centri d'intensa attività artigianale, nodi di particolare interesse
commerciale con residenze elitarie.
Infatti dato che il vasto e ricco insediamento
era disposto su un territorio interessato da emergenze di
oggi, basse colline, il punto di osservazione necessario per stare
davanti a - questo paesaggio proto urbane ed insieme i unto dal quale il grande
monumento poteva
essere visto in tutta la sua altezza; non doveva
essere certamente ai piedi di Chiusi, ma in una zona elevata della dorsale del
Monte Cetona da cui dominare la valle.
Il Labirinto, quel giochino che quasi tutti
abbiamo fatto in una qualsiasi rivista di enigmistica oppure visto in qualche
sequenza cinematografica, è in realtà vecchio di ben 30.000 anni e, alle
origini, non si trattava di un semplice gioco, bensì di un percorso iniziatico
denso di simbologie esoteriche.
Il Labirinto o Spirale della Vita, rappresenta
in realtà il passaggio dalle Tenebre alla Luce, la continua ricerca della
Conoscenza, tanto che anticamente, all'interno dei Labirinti, si trovavano i
Santuari preposti a particolari riti iniziatici. Il più antico Labirinto, oggi
ormai completamente perduto, fu quello fatto costruire in Egitto dal Faraone
Amenemhet III intorno al
Nessuno conosce esattamente lo scopo del
Labirinto di Fayum e secondo antiche tradizioni, lo stesso Mosè venne sottoposto
a tale prova per dimostrare di essere degno di custodire i segreti dell'Arca
dell'Alleanza.
Ma il Labirinto più conosciuto è sicuramente
quello di Cnosso, a Creta, anche questo ad oggi perduto, pur essendo la sua
pianta originale impressa in molte monete e vasi dell'epoca. Altro Labirinto
scomparso è quello che si sarebbe dovuto trovare nei pressi di Chiusi e che
avrebbe contenuto il famoso tesoro di Porsenna.
Numerosi infine i Labirinti che si trovano
impressi in quasi tutte le Cattedrali gotiche e in Italia quello della
Cattedrale di Lucca, il Labirinto di San Vitale a Ravenna, quello di Santa Maria
di Trastevere a Roma e quello di San Michele Maggiore a Pavia.
Un esemplare di Labirinto del 700 perfettamente
conservato si trova nella Villa Nazionale di Stra, presso Venezia.
Quando fu costruito il primo labirinto? Se
ponessimo la domanda allo storico Erodoto, vissuto quattro secoli e mezzo prima
di Cristo, risponderebbe aprendo le sue Storie, al libro II. Qui è descritto
appunto un labirinto, sito in Egitto, presso le piramidi. Il grande greco lo
vide e poté visitarlo. Costruito interamente in pietra calcare, di pianta
quadrata, racchiudeva vaste sale e aveva un portico con colonne monolitiche; le
camere dovevano essere migliaia. Da allora si gioca con le varie ipotesi. C' è
chi crede fosse il tempio funerario di Amenhemet III a Hawarah, c' è chi dice
altro.
Ma per rispondere meglio dovremmo fidarci dei
miti, recarci a Creta, rivedere con la nostra fantasia il celebre labirinto
costruito dall' architetto Dedalo per re Minosse e pensare che in quel luogo
dell' immaginario occidentale fu rinchiuso il Minotauro, l' essere dal corpo
umano e dalla testa taurina. L' eroe ateniese Teseo, aiutato da Arianna, figlia
del re, vi penetrò: uccise il mostro, liberò i fanciulli inviati come tributo e
guadagnò l' uscita grazie al filo che la donna gli diede. Alcuni archeologi
identificarono questo luogo con il palazzo di Cnosso, dalla forma intricata,
ricco di decorazioni di asce bipenni (in greco lábrys, da cui potrebbe derivare
appunto labirinto). Chissà qual è la via migliore; chissà se la tomba
labirintica, presso Chiusi, descritta da Plinio nel XXXVI libro della sua Storia
naturale, fu proprio quella del re etrusco Porsenna.
L' uomo ha avuto sempre necessità di creare
labirinti, fatti di pietra o di pensiero. Con essi ha anche spiegato quella cosa
inafferrabile che i filosofi chiamano realtà, o almeno i suoi percorsi
misteriosi. È impossibile uscire da un labirinto, soprattutto se non ha pareti
ben definite. L' idea attende ognuno di noi in opere insospettabili e ogni volta
ha la capacità di attirarvi la nostra anima. Il labirinto lo potete incontrare
nei suoni sublimi di Bach o nelle impalpabili note di Mozart o nella violenza
che si cela in talune disperazioni di Beethoven; ci state dentro senza
accorgervi quando vi fidate di un filosofo che vuol dimostrarvi con la ragione
l' esistenza di Dio. I letterati si direbbe quasi che siano costretti a giocare
con i labirinti, così come gli indagatori delle società. Gli esempi sono
infiniti, ma nessuno potrà negare che i più contorti tra quelli contemporanei li
abbia edificati la burocrazia. Nel 1913 lo scrittore russo Andrej Belyj, nel suo
romanzo Pietroburgo, ci aveva avvisati dell' esistenza del senatore Apollon
Apollonovic, capace di esercitare il controllo in una città-labirinto-prigione
attraverso una burocrazia implacabile e un reticolato di leggi oppressive.
Le nostre ricerche corrono in rete, desideriamo
scoprire informazioni e certezze da catturare con Internet. E anche in tal caso,
non è difficile dimostrare che ci siamo cacciati di nuovo in un labirinto. Erano
meglio gli antichi o l' attuale? Inutile rispondere, basterà ricordare che ogni
epoca ne ha bisogno almeno di uno, a sua misura. L' uomo medievale trovava l'
immagine del labirinto sui pavimenti delle cattedrali. Chiunque fosse entrato in
quella di Amiens, ne vedeva uno di rara bellezza. La sua fede gli consigliava di
percorrere i tortuosi tracciati in ginocchio, per meglio comprendere quanto
difficile fosse stata per il Cristo la via del Golgota.
Oggi tutto è cambiato, ma ogni giorno scopriamo
nello schermo del nostro computer che qualche calvario c' è, anche se camuffato
e virtuale.
Di divagazione in divagazione, rischieremmo di
condurvi in un altro labirinto. È il caso di riprendere il filo del discorso e
ricordare lo spunto da cui siamo partiti: un nuovo libro di Paolo Orvieto, dal
titolo Castelli labirinti giardini. Luoghi letterari di orrore e smarrimento
(Salerno Editore). Clausure mostruose, case maledette, segregazioni senza
motivo, fantasmi che ritornano inspiegabilmente, stanze della tortura, auto
reclusioni, sessualità che hanno abbandonato il corpo, bisogno di sotterraneo,
di inferi: nel fascinoso saggio questi e altri argomenti li visiterete
attraverso una eccellente documentazione letteraria. Il guaio è che, dopo la
lettura di queste pagine, le obiezioni mancano. È vero che «ogni epoca crea i
propri mostri, personifica in esseri altamente simbolici le proprie rimozioni,
le repressioni sociali e religiose, le proprie ossessioni e paure»? Di certo,
noi abbiamo ancora bisogno di scandalose infrazioni alla logica e di ficcarci in
qualche clausura, dove «incontriamo tutto ciò che sta contro la morale e oltre
la scienza».
Si cerca sempre in un labirinto, si incontra
prima o poi un mostro. Così, per fare un altro esempio, ci si rende conto
leggendo in Boiardo l' innamoramento di Orlando che appaiono tutte le possibili
impersonificazioni del male, forze che ci spingono verso lo stato selvaggio,
aggressivo. Non sono che degli antenati, neanche tanto lontani, di Frankenstein,
Dracula, Hulk. L' itinerario che il paladino percorre con le sue emozioni li
materializza per il lettore prima che siano stati inventati. Anche l' Antico
Testamento è gremito di mostri sottomessi da Dio, ma alcuni sono per l' uomo
invincibili. Possono riapparire come Moby Dick, trasformandosi nella celebre
opera di Melville. Egli paragona la sua balena al Leviatano (il «serpente
guizzante» di Isaia 27,1). Ma proprio in questa lotta, il bianco cetaceo diventa
qualcosa di indissociabile dall' uomo: lo scontro è lo sforzo per penetrare l'
oscurità, quel mistero con cui Dio ha avvolto la sua creatura precipitata sulla
terra. Un altro labirinto, insomma, con pareti fatte di acqua e tenebre. Da
temere e da inseguire.
Dalle donne sepolte vive di Poe ai bestiari
orientali, dai melodrammi con i vampiri al romanzo Pet Sematary (1983) di
Stephen King, narrazione liberatasi dall' incerto discrimine tra realtà e
fantasia, tra ragione e follia, da Fazio degli Uberti a Verga, da Borges a Eco,
Paolo Orvieto presenta ciò che Jung immaginava sepolto «negli strati più antichi
dello spirito umano». È un cammino a ritroso, verso una zona indeterminata del
nostro pensiero; si cerca in un labirinto infinito di cui si è persa la mappa.
Per questo non importa se mai sia esistita l' antica costruzione di Dedalo o se
effettivamente conteneva il Minotauro, perché qualcosa di quel mito continua a
vivere in ognuno di noi. Misteriosamente. Nella sua Critica del giudizio, Kant
ha scritto che l' arte deve mettere in gioco, coinvolgere tutte le facoltà
spirituali del lettore oltre ogni limite imposto dalla razionalità. I Greci
risposero tre millenni prima inventando un labirinto, al cui centro c' era un
mostro. Cercarlo o fuggirne? Combatterlo o lasciarlo tranquillo con il suo pasto
fatto di innocenti fanciulli? La risposta cambia in ogni epoca. Quella
definitiva temiamo che l' uomo non la conosca ancora.
Il simbolo del labirinto compare fin dai tempi
più remoti della storia umana ed è molto comune in Europa e in Asia. Già nelle
pitture rupestri si trovano spirali, cerchi concentrici intervallati da linee e
perfino labirinti a forma di ellisse che dovrebbero rappresentare il moto dei
pianeti.
Il più
famoso è il labirinto di Cnosso, fatto costruire dal re Minosse come prigione
per il Minotauro, mostro mezzo uomo e mezzo toro. Secondo il mito, il Minotauro
riceveva un tributo periodico di sangue da Atene: alcuni giovinetti ateniesi
venivano rinchiusi nel labirinto per servire da pasto al mostro. Questi fu
ucciso dall’eroe Teseo, che si sostituì ad una delle vittime sacrificali. Egli
ritrovò la strada verso l'uscita grazie ad Arianna, figlia di Minosse, che gli
aveva dato un grosso gomitolo di filo da svolgere durante il percorso di andata.
Dedalo, l’ingegnere ateniese che era il costruttore del labirinto e che aveva
dato ad Arianna il consiglio del filo, per punizione vi venne rinchiuso da
Minosse col figlio Icaro; riuscirono a fuggire per mezzo di ali di cera, ma
Icaro volò troppo in alto, il calore del sole fuse la cera ed il ragazzo
precipitò a terra.
Il labirinto più antico che si conosca nell’area
mediterranea è quello vicino al lago Moeris, in Egitto, costruito parzialmente
sotto il lago, che è un bacino artificiale alimentato dalle acque del Nilo.
Scrittori classici, come Erodoto, Diodoro Siculo, Plinio e Strabone, lo
descrivono immenso, con un piano sotto e due sopra la terra, con aree riservate
agli iniziati di un rito non ben specificato.
Secondo Platone, il primo labirinto della storia
umana sarebbe quello di Atlantide, fatto di cerchi concentrici alternati di
terra e di mare, con la parte di terra unita da ponti. In Italia il più noto è
quello attribuito a Porsenna, che si troverebbe nei sotterranei della città di
Chiusi.
Da sempre il labirinto simboleggia un percorso
interiore attraverso il quale lo spirito si può evolvere e innalzare ad un
livello superiore; il centro del labirinto, secondo Mircea Eliade,
rappresenterebbe la sacralità. Il cammino tortuoso per arrivarci assumerebbe
quindi una funzione di protezione del sacro nei confronti dei profani, essendone
riservato l’accesso ai soli iniziati: la difesa di un luogo sacro, di un tesoro
molto prosaico (fatto di denaro o di beni materiali) o spirituale (immortalità,
virtù, elevazione al divino, conoscenza di sé).
Il labirinto è stato utilizzato anche come
sistema di difesa alle porte delle città fortificate; per esempio, era tracciato
sulle piante delle antiche città greche. Voleva simboleggiare la difesa della
città o della casa che si considerava al centro del mondo. La difesa era rivolta
sia verso gli avversari umani, sia contro le influenze malefiche.
Sul pavimento della cattedrale gotica di
Chartres, in Francia, è disegnato il labirinto riprodotto qui sotto.
La sua forma è circolare e il diametro misura
Vuoi raggiungere la saggezza? Vuoi diventare
veramente abile in qualche arte? La musica, lo sport, la coltivazione dell'orto,
la conoscenza delle persone, l'amore, la matematica,...?
E quindi da supporre che il Famoso labirinto del
Porsenna sia solo una pietra quadrata e piatta magari attaccata in alto o di
lato, all’ingresso del Tempio Mausoleo, e non da interpretarsi come un insieme
di cunicoli gallerie, o altri passaggi sotterranei.
Capitolo
4
Quel pomeriggio io non riuscivo a dormire, forse
a causa della faticosa notte scorsa, o per il caldo che si faceva sentire. Io mi
sentivo coinvolto in delle situazioni strane, ma oramai avevamo preso l'impegno
d'aiutare
Zona “

Località S. LEONARDO
Questa località è un
insieme di tre poderi: S. Leonardo, Casa Bruciata, e Casa Bianca o Magazzino
Tabacchi, quest'ultimo chiamato così, perché fino a circa 18 anni or sono, era
uno stabilimento dove si produceva tabacco, essiccato, preparato e poi spedito
alle fabbriche di sigarette e sigari dello stato.
Il nome Casa
bruciata, si pensa derivi dal fatto che fin dalla sua costruzione, questa casa è
stata di colore scuro, quasi color fumo, c'è chi dice invece che il suo colore
sia dovuto ad un incendio che la rese così scura, molti anni fa.
Qui ci troviamo a

TAPPO SFERICO DI ROCCIA CHE CELA UN INGRESSO NASCOSTO
Un po' più in alto,
sopra la strada, tornando in direzione della statale, c'è un casolare agricolo
ancora funzionante, curato come si faceva una volta, con tanto di trattori,
carri e bestiame da tiro e pascolo.
Il padrone di questo
casolare possiede anche molte terre, le quali hanno la proprietà d'essere Terre
Etrusche, non si sa altro di questi campi, perché non è consigliabile
gironzolare troppo attorno alle proprietà di questa persona, che di notte invece
di dormire passeggia per le strade della sua campagna, per controllare se tutto
è tranquillo, o forse per la paura dei ladri.
Non tanto tempo fa,
riuscii a parlare con lui, e mi confidò parecchi segreti, tra i quali
l’individuazione casuale da lui fatta di alcune strutture Archeologiche, tra le
quali una piscina termale di forma ovale rifinita in mosaico attico.
In basso sotto il
Magazzino Tabacchi, (e dalla strada passandovi si scorgono bene), ci sono
ancora delle Tagliature sulla pietra, ne esistono in abbondanza, continue e per
una lunghezza di circa
Sicuramente anche
qui venivano tagliati dei pezzi di materiale che poi servivano per farne tappi
di tombe, ed altre costruzioni richiedenti
travertino o pietra.
Di Tombe se ne
vedono poche qui, e disposte poco geometricamente, di misura piccola, con Dromos
di circa un metro e, la maggior parte con l'ingresso rivolto in direzione del
Lago di Chiusi (est).
La strada sterrata
che dall'incrocio scende a valle verso nord, porta al podere S. Leonardo, dove
possiamo vedere sul retro del casolare un costone di pietra alto circa
In questa parete c'è
un'insenatura, che una volta era chiusa per celare un ingresso di dimensioni
notevoli, adesso si può vedere all'interno tutta l'insenatura fatta a caverna,
con il soffitto piatto, e le pareti lavorate perpendicolarmente.
All'interno di
questa caverna, si trova un masso di forma sferica, di enormi dimensioni, il
quale, dopo essere stato analizzato con cura, anche se la cosa appare molto
strana, risulta quasi certo che sia stato incastrato volutamente dall'interno
verso l'esterno, ricavato quindi

PARETE ROCCIOSA LUNGO
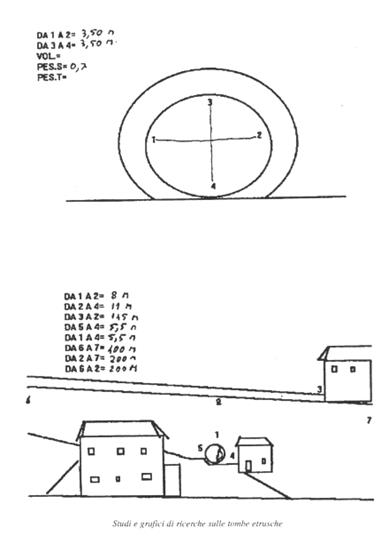
I
NOSTRI CALCOLI PER L’INDIVIDUAZIONE E IL CALCOLO DELL’INGRESSO CHIUSO
DALL’INTERNO DI “SAN LEONARDO”
all’interno della
caverna, in modo tale da poterlo rotolare verso
l’esterno, ed ostruire definitivamente l’ingresso.
Anche se dalle
nostre parti non si sono mai viste strutture del genere, è evidente, secondo
noi, che in questo punto dietro questo enorme tappo si trovi qualcosa di
notevole importanza archeologica.
Dal disegno ci si
può rendere conto di persona delle dimensioni del Tappo, c'è inoltre da notare
che su questo masso ci sono dei buchi, eseguiti da qualcuno che probabilmente
aveva pensato di provare ad entrare, o a vederne l'interno.
A chiunque sia stato
non è andata molto bene, in quanto l'enorme profondità di questo masso non ha
permesso di arrivare fino all'altra parte, per vedere cosa ci fosse dietro.
Qualcuno ha provato
anche a scavare nella pietra ai piedi del masso sferico, ma anche questa
soluzione non è valsa a molto, perché nemmeno in quel caso sono riusciti a
passare oltre il Tappo.
Il Tappo è di m. 3,50 x 2, con un volume approssimativo
di circa

VISTA DI UNA TOMBA ETRUSCA A DROMOS PROFANATA IN ANTICO
Sotto questi terreni
si snoda una rete di tubazioni del diametro di circa
L'acqua parte da due
“vasconi” artificiali costruiti in cemento, molto capienti, alimentati da una
sorgente poco distante.
Poiché, andando in
direzione dei prati e dell'allevamento si scende di livello un bel po' di
metri, l'acqua convogliata nei tubi per il dislivello subito, arrivava in basso
con una pressione molto elevata (9 atmosfere) e permetteva di far funzionare a
pieno ritmo e con un getto molto lungo, gli irrigatori nei campi sottostanti.
Questo vecchio, ma
ancora in parte funzionante impianto d'irrigazione, dà l'idea che prima
dell'uomo
moderno, in questa stessa zona avessero
fatto lo stesso i greci e i romani, magari con tecniche più rudimentali, e con
canali sotterranei fatti a mattoni, appunto quei canali, di tanto in tanto
individuati più a valle nei prati confinanti con il fiume Astrone.
Questa in fine è da
dire una zona di “cunicoli”, in quanto si sa che qui sotto esistono, vari tipi
di cunicoli o “tunnel” non ben definiti, ma di grandezza tale da presupporre
l’ipotesi, che siano stati passaggi costruiti all’epoca Etrusca.
CENNI
STORICI:
LE ORIGINI ETRUSCHE:
Degli Etruschi si sa ancora ben poco, ed i testi
sui quali oggi si basa la storia di questa civiltà risalgono all'antichità greca
e romana. Erodoto il grande storico greco offre una ricostruzione sulle origini,
ma gli Etruscologi e gli archeologi tendono oggi a limitare fortemente la sola
interpretazione di Erodoto; una teoria la sua, diffusissima fra tutti gli
scrittori classici. Il suo racconto sembra risentire troppo dai miti e delle
favole, che nell'antichità tendevano a far dipendere l'origine e la nascita
degli Etruschi, questo popolo occidentale, da una migrazione venuta
dall'Oriente, dalla Lidia, a seguito di una grave carestia in epoca mitica, e
cioè poco dopo la guerra di Troia, guidata da un grande condottiero: Tirreno.
Dionigi Alicarnasso discutendo la tesi di
Erodoto formulò un'altra ipotesi: quella dell'origine autoctona degli Etruschi;
mentre Livio in un discusso passo ha accreditato una terza teoria, di una
provenienza settentrionale di questo popolo, di cui i Reti e altre popolazioni
alpine sarebbero le spoglie.
Avevano ragione in parte tutti e tre anche se le
loro tre teorie sono errate.
Infatti, una certa resistenza all'origine solo
orientale, é motivata dalle difficoltà in cui oggi si trova l'archeologia, di
vedere nel continuo sviluppo un concatenamento delle civiltà che si sono
succedute nell'Italia centrale, non con una frattura abbastanza decisa e netta;
quindi non solo il frutto di un "solo" popolo straniero emigrante.
Per molto tempo si è pensato di poter collocare
questa frattura intorno al
Si é scritto (citando Livio X, XXXIII) che gli
Etruschi fondarono Bologna (Felsinea), Modena, Piacenza, Ravenna, Spina e
Mantova, mentre invece sappiamo oggi che queste località erano già abitate.
Bologna aveva un importante insediamento nell'area dell'attuale centro storico.
Un grande comprensorio a macchia d'olio che attorno all'anno
I palafitticoli, abbandonate le valli alpine e
la stessa Pianura Padana, vi erano già arrivati con la loro ricca cultura
intorno al
Anche i Galli Boi, nella metà del secolo IV, del
capoluogo emiliano ne rivendicarono la fondazione (chiamandola Bononia).
Altrettante pretese avanzarono i Romani nel
Oggi i recenti e continui progressi della
ricerca archeologica, hanno portato gli studiosi a poter concludere che tra le
tesi dell'origine orientale e dell'origine autoctona degli Etruschi non c'è un
vero e proprio contrasto; ci si va sempre di più orientando in una risoluzione
più equilibrata del problema. Si deve cioé concludere che se elementi orientali
sono giunti sulle coste tirreniche, questi (poco importanti numericamente) non
hanno modificato in modo sensibile e profondo gli insediamenti della civiltà
delle popolazioni preesistenti. Infatti, le basi della civiltà villavoviana
trovano nella civiltà etrusca uno sviluppo di certe sue caratteristiche
essenziali: ma non viene superata né tanto meno distrutta dagli Etruschi, bensì
in una forma, spesso non manifestata (altezzosamente quella etrusca) da entrambe
le due civiltà, sviluppata ed ampliata. Così sviluppata e ampliata la autoctona
che sarà questa a distruggere l'altra.
Il problema che non era stato risolto fino a
pochi anni fa, era invece la lenta comparsa (1800-
Questo popolo (noto anche come cultura detta dei
"Campi di urne") prima occupò le Valli Alpine e Prealpine, poi scese nella
pianura Padana, in Emilia, infine intorno al 1100-
Dai dati linguistici (molto compositi ed
eterogenei, la cui documentazione é attinta da materiali ed epoche diverse,
d'altre età e aree) e dalla documentazione archeologica si ricava un'organica e
logica sequenza di fenomeni culturali, in cui é difficile, se non impossibile,
fissare dei paletti, delle pause, alle quali attribuire il valore di un salto
qualitativo storico proprio di una sola migrazione orientale (Teoria di
Erodoto). E sulla base dei dati storici-culturali, linguistici e archeologici
sono da respingere sia quella autoctona (teoria di Alicarnasso) sia quella di
origine settentrionale (teoria di Livio).
Più semplicemente quella Etrusca, va intesa come
una migrazione avvenuta da diverse direzioni e in tempi diversi, ma sempre con
un'unica origine orientale. I palafitticoli del Nord, come a Costanza o a Ledro
(TN) ecc., 1000 anni prima, avevano con se moltissimi oggetti della cultura
Tracia-Micenea, e altrettanto portarono con sé quelli sbarcati poi in Toscana,
ma portandosi dietro la cultura Micenea di mille anni dopo, già assorbita ed
evolutasi in quella Pre-Ellenica. (1000-
Che i Tirreni-Etruschi provenissero dal mar Egeo
non ci sono più dubbi. La scoperta a Lemno di una iscrizione in lingua pre-greca
(arcaica- Fenicia 1 - origine 1519-
In Tracia (lo sappiamo da pochissimo tempo)
sembra sia esistita una grande civiltà millenaria, anteriore a quella Sumerica.
Qui del resto non molti anni fa, sono state rinvenute le Tavolette Tartarie e i
primi sigilli rotondi sumerici-babilonesi-egiziani; e sembra che proprio qui i
Sumeri scoprirono l'arte della scrittura. E forse i Fenici in seguito a contatti
con i Traci nacque loro l'idea dell'Alfabeto. La lettera N della Tracia del
Le Tavolette Tartarie hanno rimesso in
discussione l'origine della scrittura; un giallo, perché sono state trovate dove
non ci dovevano essere. E insieme a queste molti altri oggetti e tesori che
hanno sconvolto il mondo archeologico.
Sembra proprio che la preistoria Europea sia
nata qui, in Tracia.
Una civiltà quella della Tracia, che all'epoca
delle conquiste romane era del tutto scomparsa. I Greci l'avevano cancellata.
Anche se 4000 anni prima avevano fondato Troia, erano stati i primi a sbarcare a
Creta mille anni prima della civiltà minoica (il toro, il Taurus era un culto
Trace!), avevano creato quasi tutti gli dei greci (Zeus in Trace significa Dio,
e Dionisio suo figlio - nysos in Trace significa giovinetto; Lo stesso Orfeo e
l'orfismo era Trace. Il mitico Monte Olimpo era Trace, perché posto al confine
dell'antichissimo territorio Trace.
I Greci si impossessarono oltre che del
territorio anche di tutto la mitologia della Tracia. Molti, ancora oggi, credono
che la mitologia greca sia greca, invece é della sconosciuta Civiltà Tracia.
Quando i Greci fondarono sul Mar Nero, Apollonia nel V sec. a.C. eressero una
statua alta tredici metri (scultore Calamide) in onore del dio Trace affinché
proteggesse la... Grecia; e quel dio era Apollo onorato in Tracia 2000 anni
prima di quello greco (ritrovato a Dupljaja nel Banato) ecc. ecc. Poi se ne
impossessarono. Cosi la dea Cibele, era la dea delle fertilità Trace (famose le
statuette dalle grosse mammelle)
Se rileggiamo Omero (Iliade) scopriamo che
accenna a Reso, come al mitico Re Trace, elogia l'elevato grado di civiltà della
sua tribù, e resta affascinato dal suo cocchio e l'armatura d'oro puro e del suo
cavallo più bello del mondo. A Varna ultimamente è stato scoperto qualcosa che
dà ragione ad Omero. In Tracia ancora nel
E se rileggiamo anche Erodoto, narra di un
popolo con ottime regole e organizzazione sociale, dove ogni famiglia disponeva
di una propria casa, che dimorava sui laghi, le cui belle abitazioni non in
paglia ma in tavole unite, sono costruite in mezzo all'acqua sopra alti pali. Il
popolo - lui che scriveva nel
Solo intorno al VII secolo la civiltà etrusca
inizia a prendere coscienza della propria esistenza, della propria personalità,
della propria lingua, della propria autonomia, rispetto alle altre civiltà che
popolavano l'Italia a quell'epoca. Un tipo di società spiccatamente guerriera,
in contrasto con le culture esistenti nell'intera penisola, più mite, non
agonistica. Questo spiega l'ampia diffusione territoriale degli etruschi e di
conseguenza anche la supremazia culturale. Nei secoli che vanno da questa età
fino al II sec. avanti C., si ha il grande e rigoglioso sviluppo degli Etruschi,
che rappresentano per tutto questo periodo una grande forza politica, sociale,
ma anche culturale: si può quindi benissimo dire che la civiltà etrusca sia la
prima, grande, potente e fiorente civiltà italiana, pur con tanti difetti.
L'Apogeo della potenza etrusca, si ha
soprattutto nel VI secolo, quando gli Etruschi stipulano un'alleanza con i
Cartaginesi: alleanza che assicura loro il dominio di tutto il Mediterraneo
occidentale; quindi iniziano i floridi commerci.
Verso il 535 si ha una grande affermazione della
loro potenza marittima e commerciale con la grande vittoria nella battaglia
navale sui Focesi, al largo di Aleria, in Corsica.
Come riprova del grande splendore della civiltà
etrusca nel VII secolo e ancora nel VI, basterà ricordare come gli stessi Re di
Roma, cioè i Tarquini non fossero altro che Etruschi: quindi in questo periodo
gli Etruschi scendono a sud, espandendo il loro dominio e la loro potenza
militare ed economica in un "paese" ancora giovane, non ancora bene organizzato:
quello Latino. Nella seconda metà del VI secolo gli Etruschi vanno ancora oltre,
scendendo nella Val Padana fino alle foci del Po, istituendovi degli
importantissimi centri di vita commerciale e dei fondamentali punti d'appoggio
(Uno addirittura a Melzo). Mentre a sud giungono fino in Campania, a Capua,
mentre i nuovi greci - i moderni - vi stanno sbarcando da sud).
Capitolo
5
La notte era calda e tranquilla questa volta, le
Citte erano d'umore allegro, le si leggeva dentro gli occhi, s'erano presentate
quella sera con un abbigliamento semplice, e non certo da campagna. Ci trovammo
questa volta al podere "
Zona “

Località
Il podere
Il
podere
La zona è
pianeggiante, con molto verde e con un piccolo fiume che scorre, per poi unirsi
all'Astrone.
Nelle immediate
vicinanze del Casolare nell'anno 1857 furono rinvenute dal Dott. Lunghini, varie
tombe etrusche di epoca ellenica di
cui una conteneva alcune urne, con bassorilievi e
oggetti preziosi, tra i quali due tazze
d'argento, lavorate a rilievo.

TOMBA ETRUSCA PROFANATA
Andando a sud, in
direzione del fiumiciattolo (Fosso) c'è una località chiamata dalla gente del
posto “Fosso il Tono”; purtroppo la vegetazione prorompente non ci ha permesso
di vedere tutti i dettagli che ci aveva in precedenza elencato un vecchio
abitante del casolare, sappiamo solo che certe tombe, dalle descrizioni fatte
sembrano essere a Cassettone, venivano chiamate dalla gente del posto, le “tombe
zingare”, difficile capire per quale motivo.
In questo luogo
chiamato “Fosso il Tono” c'era una piccola fabbrica etrusca di vasellame, in
esso si trovano qua e là resti di vasi rotti o magari venuti male, e qualche
resto di antico forno di cottura in mattoni refrattari, usati allora
all’interno, per cuocere i vasi.
Non esiste più nulla
della piccola fornace, ci si deve accontentare del fatto che era qui
sicuramente, e con la fantasia ricostruire alcuni momenti di quel tempo in cui
gli etruschi costruivano e cocevano vasi dipinti, semplici, in bucchero, e
piatti, vassoi, o addirittura i famosi Ziri, per poi essere destinati alle zone
adiacenti, dove sarebbero stati messi sotto terra e murati per sempre.
Da qui in base a
testimonianze e racconti, dovrebbe avere il suo ingresso, il famoso tunnel, del
quale abbiamo parlato nella descrizione del “Podere Le Tombe”.
Ad ovest del podere
verso la campagna si trova una fonte d'acqua di vena naturale, che sgorga da
sempre, poco più avanti i resti di un insediamento etrusco, con uno strano
lastricato di pietra grande circa 40
x
Questi canali
fungevano una volta da canali di disluvio, o displuvio, portando a valle l'acqua
che altrimenti sarebbe infiltrata nel sottosuolo.
Forse invece questi
tagli, vista la loro disposizione a ventaglio, servivano ad allontanare l'acqua
da una tomba molto grande che dovrebbe trovarsi sotto il lastricato, con il suo
ingresso, in basso ai piedi dei canali, la tomba (ancora inviolata), deve essere
molto importante, viste le precauzioni adottate al tempo per tenerla asciutta il
più possibile adottando questa tecnica di canali.
Infine i canali
potrebbero essere veramente dei Dromos molto particolari come non se ne sono mai
visti in giro, però ognuno di loro nasconderebbe una tomba, chissà come
strutturata, e con quale tipo d'ingresso.
Un'altra risposta
potrebbe essere che questo lastricato sia il soffitto di un'enorme costruzione
sotterranea, ed i canali fossero serviti a diminuire l'effetto drenaggio delle
acque, le quali in tutti questi anni avrebbero potuto provocare l'allagamento
all'interno della grande camera centrale.
Parliamo infine dei
campi pianeggianti che si trovano a sud dei canali, in questi campi furono rotti
molti ziri dagli operai che aravano le terre, se ne trovano ancora i resti, e
addirittura qualcuno ci ha detto d'aver trovato delle monetine, durante le
arature, tra le zolle, affiorate casualmente nel arare la terra.
In questi prati
devono esserci a parecchi metri di profondità, alcuni canali, molto lunghi e
diritti che solcano la terra in direzione nord‑sud, almeno una decina persone,
ci hanno parlato di questi tunnel, e analizzando i racconti, uno alla volta,
tutti ci hanno indicato gli stessi punti, e lunghezze senza sbagliare di tanti
metri.
Alcuni sapevano dei
canali a causa della rottura casuale degli stessi, durante la lavorazione dei
campi, altri invece li avevano scoperti facendo delle fosse, in seguito usate
per piantarvi ulivi, hanno perforato con i picconi la volta del soffitto
d'alcuni tunnel, poi dopo aver sbirciato dentro con molta paura, il tutto è
stato ricoperto, mettendo delle assi di legno a forma di croce sulle falle
aperte, in modo che la terra di riempimento , non fosse caduta dentro il canale.
Le descrizioni si
assomigliano un po' tutte: "Ho visto un gran canale molto lungo, sia a sud sia a
nord non si vedeva la fine, nemmeno con la luce di una torcia, il tunnel che ho
visto era rivestito interamente di piccoli mattoni, la volta del soffitto era ad
arco, e il pavimento della stessa larghezza delle pareti, circa
Di seguito, le
parole di una Medium che fu portata in questo posto, per farle individuare il
punto di passaggio del "tunnel": “Mi concentrai e cominciai a scendere in basso,
sempre più sotto al livello del terreno, vedevo dapprima passare davanti ai miei
occhi le radici delle piante, poi una parete di mattoni, l'ho oltrepassata e mi
sono trovata in un tunnel, molto grande, umido, e lungo. Ho camminato in salita,
andando in direzione nord, per circa
Purtroppo, la medium
non ci disse altro, era stanca (così ci raccontano), e non ce la faceva più a
concentrarsi.
CENNI STORICI: Le musiche e
Si è più volte rilevata, nei testi etruschi, la
presenza di raggruppamenti regolari di parole e di sillabe, ripetizioni,
allitterazioni, rime, ecc. , che denunciano una forte disposizione alla forma
ritmica. Non abbiamo invece finora dati sicuri per la individuazione di una
metrica quantitativa, come nei versi greci e latini. Ma è in ogni caso assai
probabile che le iscrizioni dedicatorie, specialmente arcaiche, ed alcune
iscrizioni funerarie fossero verseggiate, come era uso frequente presso i Greci
e i Romani. danzatrice etrusca Ovviamente metrici e cantati erano i carmi sacri,
inni o preghiere, e forse anche quelli di contenuto profano. La musica
accompagnata dal canto, ma specialmente quella senza canto, deve aver avuto
grandissima importanza nelle cerimonie e nella vita pubblica e privata degli
Etruschi, a giudicare dalla testimonianza concorde delle fonti letterarie e dei
monumenti figurati. Gli strumenti (e di conseguenza anche il ritmo, l’armonia,
le disposizioni melodiche) sono manifestamente gli stessi che troviamo nel mondo
musicale dei Greci: una identità che non sorprende, se si tien conto degli
stretti rapporti di dipendenza che legano le città etrusche alla civiltà
ellenica per tanti altri aspetti. Fra gli strumenti a corda, rappresentati o
ricordati, sono la cetra, la lira, il barbiton; fra gli strumenti a fiato, il
doppio flauto (tibiae) e la tromba diritta (salpinx, tuba) o ricurva (cornu);
fra quelli a percussione, i crotali delle danzatrici. Il duo del suonatore di
cetra (o lira, o barbiton) e del suonatore di doppio flauto costituisce, come in
Grecia, un accoppiamento normale: lo vediamo rappresentato con particolare
frequenza nelle scene di banchetto o di danza delle pitture funerarie. Eppure,
nell’ambito di una comune civiltà musicale l’Etruria deve aver avuto, così nei
generi come nella pratica, certe sue particolari tendenze e tradizioni. Non può
trascurarsi l’insistenza con la quale gli scrittori antichi parlano dell’impiego
del doppio flauto presso gli Etruschi, quasi di uno strumento nazionale derivato
dalla Lidia e poi trasmesso dagli Etruschi ai Romani: il flautista o auleta si
chiamava a Roma, con nome derivato dall’etrusco, subulo. In verità l’auletica è
un genere largamente diffuso in Grecia, ma attribuito originariamente ai Frigi
ed ai Lidi: esso risponde ad un gusto musicale per il patetico e per l’
orgiastico. Anche in questo caso, come in altre manifestazioni della civiltà
artistica, gli Etruschi avrebbero accolto dalla complessa esperienza ellenica
certi elementi più vicini alla loro sensibilità, orientandosi specialmente verso
le forme elaborate nelle città greco-orientali dell’Asia Minore. Logicamente
dobbiamo supporre che la musica etrusca preferisse quei «modi» che i teorici
greci definivano lidio, ipolidio, frigio e ipofrigio, con i relativi sistemi
tonali, in contrapposizione con la grave e solenne musica dorica. D’altro canto
la tradizione greca, antica e concorde (Eschilo, Eumen., 567 sgg.; Sofocle,
Aiace, 17; Euripide, Fen., 1377 sgg., ecc.), attribuisce agli Etruschi la
tromba: salpinx. Pur non significando che questo antico strumento sia stato
inventato realmente in Etruria, ciò vuol dire che esso era caratteristico delle
costumanze militari e forse anche religiose etrusche, ed eventualmente
fabbricato ed esportato da botteghe di bronzisti etruschi (ma i monumenti
figurati rappresentano di preferenza la tromba ricurva, il corno, o diritta con
la sua estremità ricurva come il lituo). In ogni caso il favore accordato agli
strumenti a fiato corrisponde ad un notevole sviluppo delle pratiche musicali
distaccate dal canto. La musica non soltanto si collega con la danza e con la
mimica nelle grandi celebrazioni religiose e nelle manifestazioni sceniche, ma
sovente accompagna singoli momenti del rito ed azioni della vita pubblica e
privata, come le gare sportive, la caccia, la preparazione dei banchetti e
persino la fustigazione degli schiavi. Questo rapporto della musica piuttosto
con il gesto che con la parola trova il suo parallelo nelle forme peculiari
degli spettacoli scenici etruschi, che avevano, per quanto sappiamo (Livio, VII,
2, 4 sgg.), carattere di mimo ed erano rappresentati da attori-danzatori
mascherati (histriones o ludiones), talvolta anche con allusioni buffonesche e
satiriche. Ciò non esclude la possibilità di vere azioni drammatiche dialogate,
certamente favorite, a partire dal IV secolo, dall’influsso delle forme del
teatro greco (come attestano i frequenti modellini di maschere comiche trovati
nelle tombe etrusche). La danza ci è nota soprattutto dalle figurazioni
funerarie del VI e del V secolo. Sembra di regola eseguita da ballerini
professionali: danzatrici singole accompagnate da un suonatore di doppio flauto;
danzatori a coppia; ma soprattutto cori di uomini e donne procedenti in fila
distaccati e con movimenti individuali, guidati da musici (suonatori di cetra o
lira e flautisti) forse in funzione di corifei. I musici partecipano ai passi
della danza. Qualche volta si colgono nell’atto di ballare anche personaggi
della classe gentilizia alla quale apparteneva la famiglia del defunto. I
movimenti saltellanti delle gambe e i gesti accentuati e presumibilmente rapidi
delle braccia e della testa rivelano un genere di danza fortemente scandito,
agitato se non addirittura orgiastico, che si ispira presumibilmente alla greca
sikinnis di origine dionisiaca. Ma i documenti limitati nel tempo e nell’ambito
dell’arte funeraria non sono sufficienti a provare che questo genere sia stato
il solo coltivato in Etruria. Esso, comunque, si accorda con i «modi» musicali
che abbiamo supposto dominanti nel mondo etrusco.
Capitolo
6
La mattina, molto confuso mi soffermo un po' di
più sul letto, questa mattina è il mio giorno di festa, e posso rimanere a
riposarmi fino a che voglio. Mi sono messo a pensare ad occhi aperti fissando il
bianco soffitto della mia camera, con la mente lavoravo, e pensavo a tutte
quelle cose che m'erano successe, e mi domandavo perché proprio a me, a me con
quella Citta. Mentre sul soffitto bianco si formavano i miei pensieri visivi di
certe cose accadute in questi giorni. Con molta calma decisi; (visto che avevo
tutto il giorno libero solo per me), d'andare a visitare
Zona “
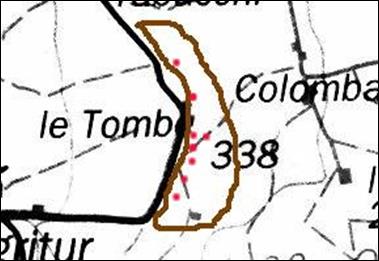
TOPOGRAFICA DELLA ZONA “PODERE LE TOMBE”
Località Podere Le
Tombe
Da queste parti si
respira un'aria buona, che sa di prati, e nello stesso tempo pulita, fine e
genuina, ed i turisti specie nel periodo estivo, vengono qui da tutte le zone, e
molto spesso fanno delle salutari passeggiate campestri e visto che qui non
manca il verde, scelgono appunto questa zona. In questi luoghi ci si può
sbizzarrire camminando per ore in strade di campagna e prati.
Avrete modo di
leggere una descrizione delle zone archeologiche di questo luogo, di carattere
prevalentemente ETRUSCO, piuttosto importante, per quanto riguarda la quantità
dei ritrovamenti locali.
Qui nel 1960, il
contadino locale, rinvenne una tomba del V secolo a.C., venuta alla luce a causa
di uno scavo per la gettata di un plinto in cemento.
All'interno vennero
rinvenute 2 armille di bronzo, un piccola croce ornata con "occhi di dado", e
sulla sommità una figura di uccello, simile al Martinpescatore.

PODERE LE TOMBE COME ERA NEL 1995
Poco distante da
questo punto, un anno dopo, venne rinvenuta una tomba con all'interno 5
Balsamari in vetro, 1 armilla, 1 Cannula terminante a testa di ariete, ed una
decorazione di bronzo con due teste di ariete, poi 2 orecchini d'oro, due
pettini, e molti altri frammenti.
Questo Casolare si
trova ad un'altezza di
Ci troviamo in piena
campagna, con un allevamento di cavalli a circa due chilometri di distanza, una
bella veduta, e tanto verde da tutte le parti.
Il nome di questa
località (le tombe) deriva dal Casolare, ormai in disuso, la cui costruzione
risale agli inizi dell'ottocento, e visto che già a quei tempi vennero rinvenute
diverse decine di tombe, sicuramente per questo motivo chiamarono questo
casolare “Podere Le Tombe”, quindi sia la zona che il casolare hanno lo stesso
nome.
Questa zona a
sud‑est di Sarteano, è situata a circa quattro chilometri ad ovest
dell'autostrada Al, e ad est nei confronti dei Monte Cetona, a nord invece
vediamo l'allevamento cavalli, e a sud il Paese di Cetona.
Parlando con gli ex
contadini, ormai anziani, che hanno abitato per tanti anni nel posto, si possono
sentire racconti, storie di ritrovamenti, e leggende molto interessanti, infatti
andando a parlare con uno di questi ci è stata raccontata la storia, (comune a
parecchi) di un tunnel di lunghezza incalcolabile, che passa sotto la zona Le
Tombe, e che sotto terra traccia un tragitto andando in direzione “
Un’altra persona, ci
racconta: "Un giorno, circa 45 anni fa, i contadini per ordine del padrone,
stavano scavando sul campo sottostante questo casolare, dei canali molto
profondi per poi inserirvi delle piante di vite, e, visto che nella zona c'erano
solo pochi centimetri di terreno, e poi subito dopo il tufo, in questi solchi,
veniva portata della terra, e quindi venivano riempiti in modo che i filari
potessero crescere con maggior vigore assorbendo con le loro radici il
nutrimento necessario.
E appunto durante
quest'operazione che, usando il piccone, uno degli operai ha sentito che il
terreno andava giù, e si è accorto che sotto c'era un vuoto.
Dettero subito uno
sguardo dentro, molto intimoriti e soprattutto superstiziosi, a causa di vecchi
detti su maledizioni, che sarebbero ricadute su chi avesse profanato Tombe
Etrusche ecc..
Presi dal timore di
dover raccontare il fatto al padrone, continuarono il loro lavoro, coprendo la
falla, creata con un Tegolo da tetto".
Alcuni degli anziani
che parteciparono a quest'evento dicono di ricordarsi addirittura il punto
preciso, dove quel giorno accadde il fatto, e quindi il punto dove si può
accedere al tunnel, e adesso lo conosciamo anche noi.

INGRESSO ANCORA DA APRIRE
E un peccato che un
posto come questo non sia stato esaminato più attentamente, per poi essere
scavato sistematicamente, e naturalmente in maniera legale, con l'opportunità e
la soddisfazione di poter mettere alla luce, e sistemare in qualche museo le
bellezze del passato, anche di questo posto dell'Etruria Toscana.
In questa zona ed in
questo posto in particolare si trovano molte architetture rimaste come erano un
tempo, ancora tutte da vedere e scoprire, per esempio ad est del podere, sotto
il muraglione sul quale è stato costruito lo stesso, ci sono delle lavorazioni
sulla pietra, che recano dei segni lasciati dagli Etruschi chissà per quale
impiego e motivo. In questo punto della parete di pietra abbiamo scoperto un
ingresso ancora celato, si vede bene anche se l'occhio dovrebbe essere
abbastanza esperto, per capire nei particolari come sia composta questa insolita
tappatura.
Si vedono anche
delle strane caverne su queste pareti, e non si riesce a capire bene se siano
naturali, o fatte dalla mano dell'uomo.
La parete di pietra
(muraglione) gira tutta intorno al Casolare in disuso per

PODERE “LE TOMBE” ANTICHE TRACCE DEI SUOI CONTADINI
circa ottocento
metri, calando di spessore man mano si sposta
verso nord‑ovest.
Un vecchio abitante
del luogo ci ha raccontato di alcuni rumori strani, che si sentivano durante la
notte, provenienti dalla cantina sotto il podere, molti dei suoi coinquilini
tentavano in quei casi di scendere in cantina (nella zona da dove pensavano
venissero i rumori), ma non riuscivano mai a capire bene cosa fossero né da dove
venissero.
Caso strano, ma vero
abbiamo notato che nel centro del pavimento di quella che una volta era la
cantina, c'è uno scavo che, a giudicare dalla terra smossa ed ora abbastanza
ricompattata, dovrebbe risalire a circa 10 anni fa.
Sicuramente questo
scavo sarà stato fatto per controllare se sotto il pavimento della cantina, a
qualche metro di profondità, in quel punto ci fosse stato qualcosa come una
tomba con l'ingresso da un'altra parte, ma con
In effetti, a
Sarteano molti sono i vecchi poderi che, per motivi non ancora chiari, furono
costruiti sopra a delle Tombe Etrusche.
Parliamo adesso di
queste tombe che si trovano a sud della casa, tutte dello stesso stile, anche se
differenti come struttura interna, e con dei Dromos di diversa misura, infatti,
variano dai
Queste tombe hanno
tutta la caratteristica d'avere gli ingressi, e i Dromos orizzontati
prevalentemente a sud.
Alcune hanno due o
più camere laterali, con la principale in fondo al Dromos, altre invece sono
solo nicchie, sia a sinistra sia a destra, però la camera principale davanti è
molto più grande.
In un punto della
necropoli manca un'enorme fetta di parete tufosa di circa
Non c'è che dire,
gli Etruschi avevano scelto un bel posto per le loro necropoli, i loro punti di
sepoltura venivano scelti con molta cura, stando attenti che la zona avesse più
sole possibile durante l'arco della giornata, e di spalle alla Necropoli,
guardando sud, non dovevano esserci altre montagne, o colline che si
interponessero tra le tombe ed il sole.
Considerando anche
il fatto che durante l'inverno il sole passa più basso all'orizzonte, e a quel
punto poteva esserci il rischio, che
In alcuni punti
della parete di pietra, una volta sicuramente di tufo più morbido, vi sono delle
forme geometriche, molto simili a Dromos delle Tombe

INGRESSO DI TOMBA ETRUSCA PROFANATA
Etrusche, mentre
invece si tratta di tagli nella parete di pietra, lasciati dagli Etruschi solo
perché in quei punti venivano attinte delle pietre cubiche e a volte
piattiformi, che sarebbero servite loro per farne dei tappi di chiusura, o
addirittura per costruire in posti molto lontani case fortezze ecc.
Si pensa, infatti,
(ed alcuni studi sui tipi di pietra lo confermano), che molte costruzioni
d'epoca etrusca che si trovano a Chiusi, siano state edificate usando del
materiale preso qui, e che esistesse una antica strada che collegava questa zona
a Chiusi, ma passando per un punto non bagnato dall'acqua, considerato che in
quel periodo tre quarti della zona più in basso, attorno a Chiusi, erano
allagati.
Quello che non si sa
con certezza, è come avessero fatto a quei tempi, con i pochi mezzi a
disposizione a trasportare tutto questo materiale (oltretutto di gran peso),
fino a delle distanze così grandi.
In questo luogo ci
si può arrivare sia da località Le Tombe, sia da un podere Casella, naturalmente
queste vecchie abitazioni sono riportate tutte sulle cartine topografiche di una
certa scala.
In breve per
arrivare qui si scende da Sarteano verso il casello di Chiusi Chianciano, un
chilometro dopo, oltrepassata la strada che porta alla Cartiera, si svolta a
destra, per una strada sterrata incontrando una prima abitazione sulla nostra
destra.
Subito dopo sempre
sulla destra si vede un casolare agricolo, continuando dopo un altro chilometro
circa, si passa davanti al vecchio magazzino tabacchi, dopo ancora un po', si
giunge al podere Le Tombe, che si nota subito arrivando, guardando a sinistra.
Eccoci nel luogo di cui avete letto la descrizione, nelle precedenti righe, qui
hanno abitato e sono stati sepolti molti dei popoli che vivevano, fra il settimo
secolo a.C. ed il secondo secolo D.C. Guardandosi intorno e respirando l'aria si
hanno delle sensazioni strane, sembra di poter rivivere quei momenti del passato
che anche se lontani, rimarranno sempre legati a questa terra e a queste pietre
lavorate, un po' arrotondate dal passare degli anni e dagli agenti atmosferici,
dalle acque e dai venti, e dai carri coi buoi, che con le loro ruote cerchiate
in ferro hanno scolpito le vie di pietra.
Attraversando il
campo andando in direzione podere Casella, davanti a noi c'è per terra un canale
scavato di recente, che va da est ad ovest, largo
Questo canale credo
sia stato fatto da degli scavatori clandestini, per cercare il passaggio del
famoso e leggendario tunnel, del quale si parla spesso. Visto che le indicazioni
da noi raccolte fanno supporre che questo tunnel si trovi veramente qui, anche
loro, avevano sicuramente pensato così, e, scavando il canale trasversale al
probabile tragitto, alla fine pensavano che sarebbero finiti per intercettare
perpendicolarmente il suo passaggio, e quindi aprirne la volta per riuscire ed
entrarvi ad esplorarlo con calma.
Secondo i nostri
calcoli, la profondità è notevolmente maggiore a quella presupposta dagli
scavatori clandestini, e quindi tutto quel lavoro (come si può facilmente capire
vedendolo di persona), non è servito a niente.
I contadini che
abitavano qui, tenevano in diversi punti attorno al podere dei sarcofagi di
pietra (vasche scavate in pietra di forma rettangolare di m. 2,20 x 65 x 50), e
li usavano per farci mangiare dentro gli animali, quelli che loro chiamavano
“trogoli”, non erano che dei sarcofagi ritrovati nei dintorni.
Adesso non se ne
trovano più in giro, perché durante un certo periodo sono andati a ruba, ed i
ricercatori di queste cose se li sono portati via quasi tutti.
Solo qualche
esemplare si è salvato, e si trova poco distante da qui, all'allevamento di
cavalli, usato come enorme vaso da fiori e comunque come ornamento. Una delle
tombe è molto più grande delle altre ed è l'unica senza

TRAVERTINO “VISTA DI ANTICHI TAGLI PER L’ESTRAZIONE”
tombe laterali o nicchie, la camera ha un soffitto talmente alto che ci si può
stare tranquillamente in piedi, l'interno è rettangolare e molto spazioso, della
grandezza di
Questa è la tomba
centrale, perché in questa necropoli esiste un sistema geometrico di tipo a
ventaglio.
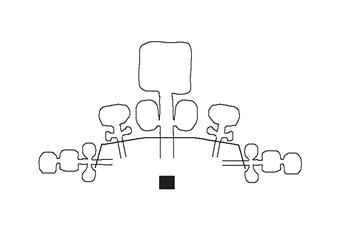
NOSTRA RIPRODUZIONE DELLE TOMBE A VENTAGLIO
Dalla tomba
centrale, ogni tre metri si contano sia a sinistra che a destra altre tombe, ma
retrocedendo di
Noi abbiamo provato
ad immaginarci la zona vista dall'alto , per renderci conto se ci fosse rimasta
qualche Tomba ancora non profanata.

L’ANFITEATRO DI PIETRA IN QUESTIONE CON DISEGNATE LE TOMBE DA APRIRE
Ci sono altre tombe
ancora inviolate, ma molto ben nascoste, noi siamo convinti che ci siano rimaste
ancora da scoprire cose parecchio interessanti, che si nascondono all'occhio
dell'uomo.
Magari dei tesori
nascosti sono proprio qui sotto i nostri piedi in questo momento, o solo un po'
più in là, sotto la collina, sotto un cespuglio, o sotto la scarpata. Insomma
questa è una curiosità che non dà pace, pensate quale sarebbe il piacere nello
scoprire qualcosa che risale a duemila trecento anni fa, il vedere per primi
quello che era celato e nascosto, ma nello stesso tempo vicino a noi, a pochi
metri.
Riportare alla luce
degli oggetti, che sono appartenuti ad un nostro avo del trapassato remoto,
immaginare i momenti in cui lui era lì, magari stava seduto guardando la valle
verso sud, e pensando a cosa avrebbe mangiato per cena, rotolando fra i denti un
piccolo ramoscello staccato da una pianta lì vicino.
I suoni poi dovevano essere di una
bellezza fonocromatica indescrivibile, senza rumori di autostrade o aerei, che
oggi passano di continuo facendo un baccano atroce. Insomma la qualità fonica e
la propagazione dei suoni, oggi non ci permetterà mai di provare tali emozioni,
nemmeno andando in una moderna sala di registrazione, con le pareti
insonorizzate e altri vari accorgimenti fonoassorbenti.
CENNI
STORICI: L’
organizzazione politica: ETRUSCA
All’epoca dei contatti dell’Etruria con Roma la
vita politica della nazione etrusca poggia essenzialmente sopra un sistema di
piccoli stati indipendenti facenti capo a città preminenti per grandezza e per
ricchezza. Non sappiamo quali fossero le effettive condizioni del periodo
arcaico; ma la coesistenza di diversi centri di grande importanza a poca
distanza l’uno dall’altro, come Veio, Caere, Tarquinia, Vulci, con propri
poteri, caratteristiche e costumanze, sembra effettivamente ispirarsi al sistema
della città-stato proprio delle contemporanee colonie greche e fenicie
d’occidente. Questa struttura politica - estesa anche nel Lazio etruschizzato -
è designata tecnicamente in latino con il termine populus, di probabile origine
euusca, che appare, in un certo senso, sinonimo di civitas, dell’osco-umbro
touto, toto. In etrusco il concetto è reso, probabilmente con diverse sfumature,
dai termini spur-, mex e forse anche tufi (dall’italico). Il nome ufficiale dei
populi è quello degli abitatori stessi delle città: Veienti, Tarquiniesi,
Ceretani, Chiusini, ecc. È probabile che con il procedere del tempo le singole
città sovrane si siano aggregate un territorio più o meno vasto, sottomet- tendo
altre città rivali, come vediamo in atto nella più antica storia di Roma; ma non
è escluso che alcune delle città conquistate possano aver conservato una
parziale autonomia o siano state legate da rapporti di alleanza con i dominatori
(ciò che potrebbe spiegare l’esistenza di centri di media importanza
specialmente nell’Etruria interna, come Nepi, Sutri, Blera, Tuscania, Statonia,
Sovana, ecc., nel territorio delle maggiori città, cioè di Veio, Tarquinia,
Vulci). Si consideri inoltre la possibilità di vincoli di dipendenza delle
colonie dalle città di origine: per esempio nella espansione etrusca in Campania
e verso settentrione. Ma in realtà, per quanto ci consta, il principio
dell’autonomia e del frammentismo politico deve aver prevalso anche nella
costituzione dei domini etruschidell’Italia meridionale e settentrionale. Il
centro della vita politica e culturale dell’Etruria è dunque da ricercare nelle
grandi città dominanti, di cui possediamo gli splendidi resti, e che il computo
tradizionale calcola in numero di dodici (solo in età romana si parla di
quindici popoli). Quali sono queste città? Certamente all’epoca della conquista
romana si contano tra di esse Caere, Tarquinia, Vulci, Roselle, Vetulonia,
Populonia, Volsinii, Chiusi, Perugia, Cortona, Arezzo, Fiesole, Volterra; Veio
era stata annessa al territorio romano già dall’inizio del IV secolo, Alcuni
centri minori dovevano essere ancora autonomi nel IV e III secolo a.C., come
parrebbe risultare da monete con i nomi di Peithesa, Echetia e di altre città
non meglio identificate. Nuclei abitati fiorenti in età arcaica, quali
Acquarossa, Bisenzio, Marsiliana d’ Albegna (Caletra?) e la stessa Vetulonia,
decadono più tardi: altre città si svilupperanno soltanto alla fine della
civiltà etrusca, sotto il dominio di Roma, quali Siena, Firenze, Pisa, Luni. Una
fase anteriore a quella dell’organizzazione urbana non è documentabile
storicamente: ne possiamo quindi conoscere il sistema politico e i reciproci
rapporti dei villaggi protostorici dei quali restano tracce nel territorio
etrusco. Accenni indiretti di scrittori e l’analogia con la costituzione
primitiva di Roma potrebbero far supporre che la popolazione delle città fosse
ripartita in tribù e in curie. Per il resto, cioè per il rapporto fra queste
ripartizioni interne e i nuclei territoriali di aggregazione dai quali sarebbero
sorte le città stesse, nonche i centri minori dipendenti, regna almeno per ora
l’oscurità più completa. Ogni città-stato o città capitale (caput) di uno stato
costituisce un mondo politicamente ed entro certi limiti culturalmente a se
stante (si pensi ad esempio allaspecializzazione dei prodotti artistici, per cui
tra le altre Tarquinia eccelse soprattutto per la pittura funeraria, Caere per
l’imitazione dell’architettura interna delle tombe, Vulci per i bronzi e per la
scultura, e così di seguito). Gestione interna, commerci, eventuali imprese
navali dovettero essere autonome come nelle poleis della Grecia arcaica e
classica. Le notizie delle fonti storiche ci persuadono a ritenere che anche la
politica estera fosse decisa con sostanziale autonomia da ciascuna città secondo
i propri interessi. Tuttavia esistono altri indizi, sempre delle fonti, che ci
indirizzano verso il ricordo di un tipo di associazione delle città etrusche per
la quale si è usato modernamente il termine di lega o di federazione. Dobbiamo
chiederci quale sia l’effettiva natura di quest’ultima istituzione, che ha dato
luogo a discussioni tra gli studiosi. L ‘esistenza di forme associative tra
diverse comunità autonome è un fatto ben noto nel mondo antico, in Grecia come
in Italia, sia pure con diverse caratteristiche a seconda dei tempi e dei
luoghi; ne può quindi destare meraviglia. Per l’Etruria gli scrittori antichi
non usano, a quanto ci consta, un termine specifico per indicare l’associazione
stessa; ma parlano dei duodecim populi, dei duodecim (o quindecim) populi
Etruriae o semplicemente di Etruria, di omnis Etruria. Il numero dodici delle
grandi città dell’Etruria propria - alle quali facevano riscontro altrettante
della Etruria padana e della Campania - ha probabilmente un carattere rituale:
come in altri casi analoghi del mondo antico, e forse, ma non necessariamente,
per analogia con le dodici città della lega ionica (considerati gli antichi
legami culturali fra Etruria e lonia asiatica). Che si tratti per altro non
soltanto di uno schema ideale, ma di una reale istituzione politica, può dedursi
da quei riferimenti, principalmente di Livio (IV, 23; V, 1; X, 16, ecc.), nei
quali si accenna ad una adunanza di consultazione annuale o comunque periodica
(concilium) tenuta dagli stati etruschi e dai loro capi (principes) al Fanum
Voltumnae. Ha giustamente posto in rilievo L. Pareti che simili testimonianze
non sono sufficienti a provare il carattere continuativo ed un forte potere
soprastatale del supposto istituto federale etrusco. Accertata l’esistenza di
feste e di giochi annuali panetruschi nel santuario di Voltumna - non altrimenti
da ciò che sappiamo relativamente al mondo greco per Efeso, Olimpia, Delfi,
Corinto -, si potrebbe infatti supporre che soltanto circostanze politiche di
carattere eccezionale, come la minaccia di Roma, possano avere indotto i
rappresentanti dei diversi stati etruschi a concertarsi nel santuario nazionale
e financo a coalizzarsi in una lega politica e militare. Ma esistono d’altra
parte riferimenti che paiono indicare una certa continuità dell’istituto ed una
relativa subordinazione ad esso dei singoli stati: ad esempio il passo di Servio
(ad Aen., VIII, 475), nel quale è detto che l’Etruria aveva dodici lucumoni, o
re, dei quali uno era a capo degli altri, o gli accenni di Livio (l, 8, 2; V, 1)
alla elezione di un re da parte dei dodici popoli, ciascuno dei quali forniva un
littore per i fasci, e più tardi alla elezione di un sacerdote al Fanum
Voltumnae in occasione delle adunanze degli stati etruschi. In sostanza
dall’attendibilità delle notizie contenute in questi riferimenti dipende il
nostro giudizio sulla lega etrusca. È interessante notare che in due delle
testimonianze si parla di re: ci si riferisce cioè preferibilmente ad epoca
arcaica. Ma in altro passo di Livio si parla di un capoelettivo della comunità
degli Etruschi, il quale alla fine del V secolo (cioè all’epoca del conflitto
tra Veio e Roma) era un personaggio designato con il titolo di sacerdos, e
perciò dotato di poteri eminentemente religiosi (o ridotti alla sola sfera
religiosa). In alcune iscrizioni latine di età imperiale ricorre il titolo
praetor Etruriae che appare anche nella forma praetor Etruriae XV populorum,
cioè della comunità nazionale etrusca che in età romana pare accresciuta di tre
città. Ora fra le cariche esercitate da personaggi etruschi e ricordate da
iscrizioni in etrusco conosciamo il titolo zilat? mexl rasnal. Dal celebre passo
di Dionisio (I, 30, 3) in cui gli Etruschi sono designati con il nome nazionale
di Rasenna sappiamo che la parola rasna dovrebbe significare «etrusco, Etruria».
D’altra parte la magistratura indicata con la parola zilat?, che pare sia la più
elevata fra le cariche delle repubbliche etrusche, equivale assai probabilmente
al praetor dei Romani. Per mexl si può pensare ad un genitivo della parola mex
che ricorre nella iscrizione della lamina d’oro lunga di Pyrgi, e forse tradurre
“dei populi”. Risulterebbe così una corrispondenza del titolo zilat? mexl rasnal
con praetor Etruriae (populorum). Si può discutere se questa carica si
identifichi con la suprema presidenza elettiva dei populi etruschi, o con una
magistratura di rappresentanza dei singoli populi nel concilio federale, come
quella dei principes ricordati da Livio. La prima ipotesi sembra oggi la più
probabile. Se le notizie relative alla supremazia di uno degli antichi sovrani
delle città etrusche non sono del tutto prive di fondamento, si potrebbe
arrischiare l’ipotesi che una forma originaria di legame unitario esistesse fra
gli Etruschi del sud all’inizio dei tempi storici, sotto la egemonia di una o
dell’altra città. Più tardi questa antica unità avrebbe assunto il carattere di
associazione religiosa, commerciale e politica, con feste e adunanze nazionali
nel santuario di Voltumna presso Volsinii. La elezione di un supremo magistrato
annuale è forse il ricordo dell’alta sovranità di un capo sugli altri. Sappiamo
da Livio che verso la fine del V secolo il re di Veio poneva la sua candidatura
alla elezione - il che conferma implicitamente l’importanza della magistratura
nazionale -, ma ne usciva battuto.
Era costituita dal padre e dalla madre che
convivono con i figli ed i nipoti, e si distingue dalla famiglia romana o greca.
Gli Etruschi sembrano aver avuto sempre delle famiglie solide, i cui componenti
erano legati tra loro da stretti vincoli molto sentiti e vissuti intensamente;
nessuno dei familiari contestavano al "pater familias" l'autorità di guida, che
verrà a lui attribuita soprattutto dai Romani, come appare da tante iscrizioni
nella quale la filiazione é appunto paterna. Grazie a queste iscrizioni noi
possiamo oggi conoscere i principali nomi di parentela in lingua etrusca: clan
significa figlio, sec figlia, puia sposa, tusurthi gli sposi; nonno si diceva
papa, nonna atinacna, fratello thuva, nipote papacs.
Del resto la stessa iconografia così tipicamente
etrusca delle tombe, che presentano il marito e la moglie sdraiati l'uno accanto
all'altra, adagiati sul letto funebre, in atteggiamento dignitoso e
affettuosamente familiare, nel gesto di protezione (vedi immagine d'apertura)
del marito e nella tenera fiducia della moglie, esprime l'importanza che la
famiglia aveva presso gli Etruschi. La coppia era solida.
Da notare che nelle tombe compare in evidenza
sempre accanto al nome il prenome del padre e della madre di entrambi i coniugi.
"Vel Titio Petronio, figlio di Vel e di Amelia
Spurinna riposa qui con la moglie Veila Clantia figlia di Arrus".
La donna etrusca, infatti, presso gli scrittori
greci e romani, non godeva di grande reputazione; se la donna greca e quella
romana vivevano nell'ombra della casa, l'ideale della donna etrusca ed i suoi
costumi sono profondamente diversi. Dal marito é tenuta in alta considerazione.
(I mariti romani al massimo, quando lo facevano,
scrivevano sulle tombe della loro sposa "domum servavit". Che in poche parole
voleva dire é stata una "buona servetta della mia casa").
La donna etrusca "esce" molto, ha un'importanza
a livello politico e anche amministrativo, vive cioè pienamente la vita della
famiglia e della società. Le donne etrusche non godono soltanto di una libertà a
confronto delle donne romane, ma all'interno della società civile adempiono
anche una funzione preponderante addirittura: al punto tale che ha fatto
giungere a conclusioni forse eccessive, facendo parlare di vero e proprio
matriarcato delle donne etrusche. A testimonianza non vi sono solo esempi
storici di donne particolarmente in vista nelle vicende politiche, ma anche
esempi archeologici che ci mostrano l'importanza che la donna ha nelle tombe
etrusche: non soltanto nella posizione, ma anche nella scelta dell'arredamento.
Insomma la donna etrusca vive pienamente tutta
l'attività intensa della società etrusca, occupando un ruolo di vero privilegio,
investita quasi da un'autorità sovrana: é lei l'artista, la donna colta, curiosa
delle preziosità dell'ellenismo e promuove la civiltà e la cultura del proprio
paese, ed infine é venerata nella tomba come se fosse una dea. Fatto curioso è
che nei ritratti dei coperchi delle urne, sono rappresentate in un realismo
straordinario, non evitano di mostrare crudamente i segni della vecchiaia, la
riproduzione accurata dei difetti fisici, o la bruttezza del proprio viso. (come
quella presente al Museo Grandacci a Volterra). Si fanno ritrarre (si suppone
ancora quand'erano in vita) fedelmente; ci tengono a rimanere se stesse;
indubbio segno di un forte carattere.
Capitolo
7
Il mio oroscopo mi diceva che sarebbe stata una
serata indimenticabile, la notte era bella, allegra e tranquilla;
ZONA “
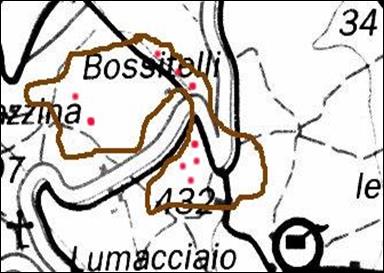
Bossitelli è un
Casolare a circa tre chilometri da Sarteano, sul podere c'è poco da dire, la sua
posizione è molto vistosa e di gran lunga più bella di tante altre della zona,
insomma un casolare di quelli che fanno gola a molti.
I suoi dintorni sono
molto interessanti e suggestivi, situato accanto alla strada che porta alla
Cartiera e davanti alla statale che scende a Chiusi, ha una visuale ampia e
bella, sia ad est che verso sud.
Il punti di
interesse archeologico sono due, uno si trova ad ovest del podere ed è un campo
di circa due chilometri quadrati, dove si possono notare, subito dopo l'aratura,
i segni evidenti di resti, di un
insediamento etrusco, e le classiche grandi chiazze rosse, in corrispondenza di
dove sono stati devastati gli ziri durante le tante lavorazioni del terreno.
Pezzetti di mattone
rosso, piccoli frammenti di vasi, sia rossi sia colorati, resti di muratura
etrusca, ed altro, si possono trovare facilmente camminando e guardando
per terra.

VISTA DI UNO STRANO INGRESSO RUPESTRE “SOTTO IL GORONE”
Questa zona di Ziri
e acquedotti sotterranei Etruschi, è stata tartassata da scavi e ricerche, lo si
vede bene in alcuni punti, perché esistono segni di vecchi saggi, che con il
tempo si sono riassestati.
Si possono trovare
anche pezzi di coperchi di Ziri o resti degli stessi, tutto intorno all'area di
questo prato. Al confine ovest dove finisce il campo, e confina con un viottolo
di campagna, poggiato lì da una parte c'è un blocco di muratura etrusca in
mattoni, e detriti di terrecotte sbriciolate di colore rosso.
La seconda zona, è ad est del podere, attraversata la
strada che porta alla Cartiera, si trova una scarpata molto ripida in pietra
tufacea di circa 3‑4 metri di altezza, che si estende da sud verso nord.
Ai piedi di questa
scarpata vi sono alcune tombe d'epoca incerta, alcune scavate nella pietra ed
altre costruite in basso, fra la fine della parete ed il livello del terreno,
alcune invece sono ancora da aprire, e se ne percepisce
chiaramente, la loro locazione esatta..
Scorrendo lungo
questa parete in direzione della Cartiera si trovano poi delle tagliature
rettangolari, segno di lavorazione Etrusca e di prelievo di materiale,
sicuramente anche in questo caso servito per costruzioni e tappi da tombe. Si
intravedono in questo punto alcune tombe aperte per metà, in cui praticamente il
lavoro di scavo non è stato portato a termine, invece altre ancora sono da
aprirsi e si vedono chiaramente, calcolando accuratamente le distanze, i loro
punti di collocamento a schiera.
Poco più in alto,
tra il termine di un campo e l'altro, dove il confine è segnato da un muricciolo
di un metro e cinquanta circa, c'è una caverna a tunnel, con l'ingresso aperto e
ben visibile, dentro si può avanzare per circa cento metri, poi ci si imbatte in
una frana che impedisce di proseguire la perlustrazione. Osservando le pareti
interne e la formazione tufacea della conformazione di base, questa galleria o
tunnel, sembrerebbe essere stata scavata dall'uomo.
La traiettoria di
tale tunnel punta ad ovest, e sembra andare in direzione del Gorone, appunto,
nelle vicinanze del cimitero di Sarteano.
Noi siamo convinti che questa parte di tunnel sia un
proseguimento o una variante del famoso, (altro pezzo di tunnel) che incomincia
dalle parti del Casolare Le Tombe. A sud del podere Bossitelli, attraversata la
strada provinciale, c'è un altro casolare, su questo posto abbiamo raccolto una
storia molto interessante: circa 20 anni fa, il nuovo proprietario del casolare,
decise di restaurarlo, e facendo i lavori di muratura nella cantina, si rese
conto che una delle pareti di tale stanza era stata costruita a mo' di tramezzo,
e visto che mancavano

due o tre mattoni, e
si poteva vedere guardando dentro con una torcia elettrica, che c'era una
profonda caverna, che andava in discesa, e in direzione sud, diritto verso il
podere “Le Tombe”.
Di questa caverna si
sa solo che fu tappata e murata per paura della sospensione dei lavori da parte
delle autorità competenti, poiché se fosse stato denunciato il fatto, sarebbero
sorti vari problemi che avrebbero rallentato i lavori di restauro, della cantina
del casolare.
Tracciando su carta,
i punti nei quali il tunnel è stato più volte intercettato, si scopre che il
tragitto è proprio come lo descrivevano gli anziani che hanno abitato nel podere
“Le Tombe”.
Infatti il tunnel ha
senza dubbio inizio nelle vicinanze dei podere “
Non molto distante
dal podere Bossitelli, in prossimità dell'incrocio che porta alle Cantine, ed
anche al podere Lo Scrogio, ci sono due magnifici esemplari di Tombe Etrusche di
tipo camera in tufo al livello del terreno, scavate direttamente nella parete di
roccia.
Una di queste tombe
è stata usata da un uomo che coltiva il suo orto lì vicino, come ripostiglio per
attrezzi da lavoro, e forse anche come pollaio.
Al di sopra di
queste, si scorgono nel piano segni di vecchie tombe etrusche distrutte in
parte, nel periodo in cui fu costruita la strada che scende a Chiusi. In curva,
per allargare la carreggiata, è stata distrutta la parete di tufo per alcune
decine di metri cubi, con la conseguente rottura delle pareti laterali della
camera di alcune tombe.
A ridosso della
strada statale, invece notammo per caso “la faccia di pietra” (quella nella
fotografia sopra), una strana pietra lavorata che sembra voglia rappresentare
una specie di teschio stilizzato. Che fosse un segno ad indicare un ipotetico
ingresso, ne siamo quasi certi, li dietro quella roccia potrebbe esserci una
camera tombale, visto che sia il tipo di materiale, che lo spazio, e la
posizione, confermerebbero positivamente tale supposizione.
CENNI STORICI:
PORSENNA ED I MONUMENTI:
Possiamo perfino chiederci se esistesse ancora
qualche cosa ai tempi di Varrone: è vero che il tratto citato è scritto al
presente, ma la notizia rimanne incompleta, secondo Plinio, perché Varrone
ripugnò - puduit ad indicare l’altezza delle piramidi più elevate, come se
seguisse fonti di cui non si sarebbe veramente fidato, senza possibilità di
verificare sul posto. E Plinio ricorda fabulae Etruscae per trovare la
precisazione sulla quale conclude la descrizione del monumento, di cui affermava
sin dall’inizio la fabulositas. Lo scetticismo dei due antiquari è abbastanza
giustificato dalla sparizione di una costruzione alla quale la tradizione
attribuiva dimensioni considerevoli: una base quadrata di
Capitolo
8
Quella notte
ZONA “
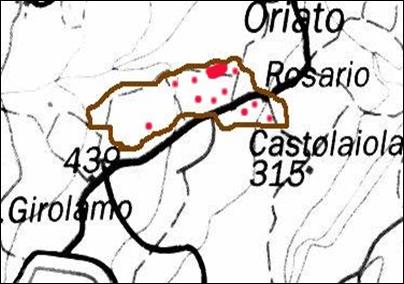
Località Castolaiole
Castolaiole o Le
Costolaie, è una zona molto vasta. Ci s'arriva da una strada sterrata che ha
inizio lungo la statale che porta da Sarteano a Cetona, dopo i primi
Per quanto riguarda
il Podere Le Pianacce c'è una storia interessante, raccontataci da un suo
vecchio abitante: a quest'uomo è capitato più volte questo fatto, tornando a
casa la sera per cena, dopo essere stato a lavorare nei campi.
Erano circa le 19,
quel giorno, l'uomo stava tornando a casa salendo la vecchia via cupa che porta
fino a davanti il Podere Le Pianacce, ad un certo punto intravide la figura di
una persona che lo aspettava in cima alla salita; quando però lui si avvicinò a
questa figura, lei si spostò in direzione dei capanno dei fieno, poco distante
dal casolare.
L’uomo allora,
incuriosito, seguì questa figura che sembrava lo volesse guidare in qualche
punto dietro il capanno ed infatti, arrivato all'angolo sud‑est del capanno, la
figura si fermò e con la mano destra puntò l'indice verso il basso, in un punto
del terreno a pochi metri dall'angolo del capanno stesso.
Subito dopo la
figura sparì fulmineamente, come se si fosse dissolta nell'aria, l'uomo si
ricorda bene tutti i particolari, la sera era luminosa e ci si vedeva molto a
causa del chiarore della luna che illuminava la zona, quindi non si può trattare
di un effetto ottico o altro.
La cosa continuò a
ripetersi per tre o quattro volte, sempre nello stesso modo, e la figura sempre
nello stesso posto, indicava ogni volta lo stesso punto.

IMMAGINE DI UNA TOMBA ETRUSCA A DROMOS L’ULTIMA A SINISTRA DEL PIANORO
Al contadino dopo un
po' di giorni venne un'idea: "Scaverò una fossa in quel punto, vi pianterò un
noce, e così controllerò cosa c'è lì sotto, nel punto indicato da quella strana
figura".
Infatti il giorno
dopo l'uomo prese gli attrezzi e incominciò a scavare dietro il suo capanno del
fieno, a circa un metro di profondità, il piccone picchiò su qualcosa di diverso
dal terreno; egli allora pulì bene la parte e si rese conto che si trattava di
un coperchio rotondo di materiale rosso simile a quello dei mattoni.
Era il coperchio di
uno Ziro, non c'era dubbio. Il contadino volle completare la sua opera, e scavò
più in profondità aggirando lo Ziro, per poter poi aprirlo meglio e controllare
il suo interno.
Alzato il coperchio,
capì subito che la cosa era più importante di quanto lui avesse immaginato,
infatti all'interno dello Ziro (che in questo caso fungeva da salvadanaio), vi
erano monete in bronzo Etrusche, ben conservate e molto belle.
Allora, ricollegando
i fatti, l'uomo capi che quella figura gli stava indicando il punto dove si
trovava una fortuna.
Tutto questo è
quello che sappiamo e che ci è stato raccontato, ma la verità quale sarà? Questi
fatti, simili ad altri di molti anni fa accadevano frequentemente, e non
possiamo nemmeno dire che il racconto sopra citato fosse l'effetto dei buon vino
genuino di campagna, poiché quell'uomo era astemio. Fino a pochi anni fa il
podere Le Costolaie era disabitato, potevamo tranquillamente aggirarci nei
dintorni, poi ne è entrata in possesso un'associazione cattolica, e vi è stato
istituito una comunità di riabilitazione per ex tossicodipendenti.
Ci sono una ventina
di ragazzi o forse più, in quella comunità, i quali fra le altre cose, sono
riusciti a riordinare ed a rendere bellissimo quello che prima era un podere
abbandonato e tetro.
Nel
Poco distante dal
casolare, in località Le Pianacce, venne ritrovata dalla Soprintendenza nel
dicembre del 1954 una tomba a camera con Dromos scavato nel travertino, di metri
6,70 di lunghezza, e circa I di larghezza.
La camera, anch'essa scavata, si trovava sotto un rialzo
di roccia a fianco di un muretto a secco, la pianta della tomba di tipo
rettangolare (m. 3,75 x 3,05), è decentrata rispetto alla porta (in. 0,45 x 1,52
al centro e 1,40 ai lati), il pavimento è più basso della soglia d'ingresso di
circa
All'interno furono
rinvenuti vari frammenti di bucchero pesante, un frammento di ceramica attica e
figure nere, 7 monetine di sottile spessore, in argento. L'epoca della tomba è
da attribuirsi sicuramente al periodo arcaico.

TOMBA CHE SERVI’ COME ABITAZIONE E RIFUGIO
Sempre in località
Le Pianacce, nel maggio del 1954 venne scoperta una tomba del IV secolo a.C., di
tipo a camera scavata nel travertino, con quattro celle disposte all'estremità
di un Dromos, lungo
A pochi metri da
questa zona, accanto alla "Chiesina dei Bel riguardo", ormai sconsacrata fu
rinvenuta nel 1880 una tomba di epoca Ellenistica, con all'interno tegole e urne
pertinenti alla famiglia dei Teta e accanto ad essa un'altra tomba a camera del
VI secolo a.C., con all'interno dei frammenti di Neckamphora a figure nere e una
parte di vaso a figure rosse.
Sempre qui nell'anno
1880 venne scoperta un'altra tomba, di epoca Ellenistica, con tegole e urne
iscritte sempre pertinenti alla famiglia dei Teta.
Ma la parte più
interessante di questa zona è quella in alto, proprio vicino al Tabernacolo di
S. Giuseppe, la quale veniva chiamata dai contadini "Alcova".
Si tratta di un altopiano con a sud un precipizio in
pietra e tufo duro a spugnosità fitta, vi si gode un panorama molto bello, sul
bordo, in cima al precipizio. Qui si trovano le prime Tombe Etrusche,
percorrendolo da ovest verso est: la prima è quasi una caverna, senza Dromos e
completamente scavata nella pietra, di m. 2x3, alta
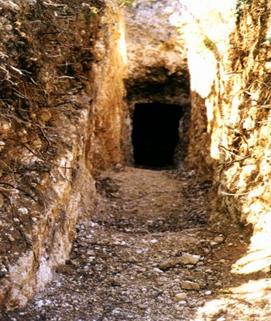
TOMBA DI FAMIGLIA “DI SAN GIUSEPPINO” IN LOCALITA’ PIANACCE
Andando ancora
avanti c'è una tomba, veramente bella, sia all'interno che vista da fuori.
Non ha il Dromos
molto lungo, circa due metri e mezzo, l'ingresso è molto ampio, quasi a
grandezza umana e dentro è grande e spaziosa con ai lati due scalini rialzati, i
quali sicuramente servivano da sostegno per due sarcofagi. Questo capolavoro di
architettura sotterranea è isolato, non ha accanto altre tombe come di solito
invece è di norma in questa zona. Sicuramente della serie cui apparteneva questa
tomba, ne è stata profanata solo una, perché era la più semplice a individuarsi,
in quanto il suo Dromos era stato portato alla luce dalle piogge, che lo avevano
ripulito dalla terra di riempimento.
Ci spostiamo un po'
più avanti di circa
Rigorosamente
rivolta Al mezzogiorno, con un Dromos di notevole lunghezza e largo circa due
metri, vediamo qui una tomba di famiglia, a cinque camere, ma queste sono veri e
propri appartamenti. In fondo al Dromos, davanti alla tomba centrale, ci si
trova ad una profondità di circa dei metri, ed è per questo che questa enorme
tagliatura è stata circondata con della rete, in modo che persone o animali in
libertà non vi cadessero dentro, con il rischio di farsi male.
Lo stile e la
grandezza di questo lavoro sotterraneo è classico delle tombe di famiglia.
In assoluto le più
ricche, nelle Necropoli che siano state ritrovate in queste zone.
Parlando con gli
abitanti della zona ci è stato raccontato che furono dei soldati in tempo di
guerra a profanare quella tomba, ma non si ricordano bene se fossero stati
tedeschi o francesi.
Certo è che per
liberare questo Dromos dal suo riempimento ed accedere così alle sue camere,
avranno dovuto rimuovere almeno due o tre camion di materiale.
Dalla sua forma, il
tipo di architettura, e i dati da noi pazientemente raccolti su di essa, tutto
fa pensare che sia tomba all’estrema destra, facente parte di una struttura a
schiera tipica, con tre tombe, di cui la centrale di solito è quella più
importante e ricca. Quindi si tratterebbe di trovare quella finale alla estrema
sinistra del pianoro, per poi misurare il centro tra le due, ed è in quel punto
preciso secondo i nostri calcoli e studi vari, che si dovrebbe trovare una
sepoltura di enorme importanza.
A questo punto
bisogna proprio dirlo, ci troviamo di fronte ad una scoperta di rilevante
importanza, perché tutti i nostri studi fatti di questo periodo, ci portano a
capire che in questo punto, date le dimensioni, la posizione, l'orientamento, e
le scritture del Varrone, riviste e meglio interpretate, dovrebbe esserci il
sepolcro del Re Porsenna, ben nascosto, accanto alla via cupa o degli inferi, la
quale serviva a quel tempo, per gli spostamenti dai luoghi di preghiera, fino al
luogo della sepoltura, ed ancor prima ai tagliatori di pietra per portare le
grosse pietre verso il basso.
Sarà dunque qui, in
questo punto da noi individuato,
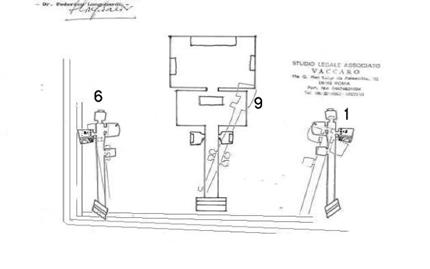
COSI’ DISEGNAMMO IL PIANORO NEL 1995
ALL’ESTREMA SINISTRA, ACCANTO AL VECCHIO MURO SI DEVE TROVARE IN QUESTA
POSIZIONE ESATTA.
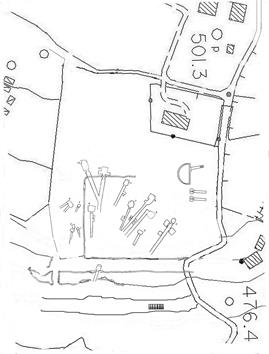
ECCO COME
SI PRESENTANO OGGI LE TOMBE SUL PIANORO IN QUESTIONE, DOPO GLI SCAVI:
Al di sotto della
scarpata, proprio vicino a questa tomba scavata nel tufo e di grandezza di circa
tre metri, c'è una strada incassata, la già più volte nominata "Via Inferi",
antica strada etrusca con alcune tombe lungo le pareti stesse veramente belle,
senza Dromos ma con ingresso a porta.
Questa strada era
percorsa dagli Etruschi per condurre i defunti verso il luogo della sepoltura,
facendo un tragitto che somigliava molto ai nostri moderni funerali, ma nello
stesso tempo portava anche ai luoghi di preghiera e venerazione, sia degli dei
che dei sovrani.
Le pareti della Via
Inferi sono state più volte ripulite, e liberate dalle erbe e dai rovi, quindi
l'occasione di scoprire altre Tombe laterali lungo la via sicuramente non sarà
mancata, ma noi crediamo che ci sia ancora molto da scoprire lungo la stessa,
anche perché conoscendo un po' le composizioni architettoniche etrusche, non è
possibile che qui ci siano solo alcune tombe, senza che rispettino una cadenza
geometrica precisa.

Ricostruendo per
intero questa via, mettendo insieme in pratica i pochi punti di essa rimasti
ancora visibili, noi l'abbiamo tracciata, ed abbiamo notato che conduceva anche
al Cimitero di Sarteano, sotto il pianoro nel quale si pensa finisse anche il
famoso tunnel.
Scendendo lungo
Naturalmente anche
nelle zone limitrofe al podere Le Castolaie ci sono alcune Tombe Etrusche, circa
undici o dodici, scavate nel tufo, che in questa zona si trova a circa 60
centimetrisotto il terreno. Queste tombe, per la maggiore sono del tipo a Pozzo,
o a Camera senza Dromos, ed alcune a Cassettone, (scavi rettangolari nel tufo
sottostante la terra, ricoperti poi con lastre di pietra o tegoli).
Da queste parti i campi sono spesso a gradoni, in altre
parole una
fetta di terra, poi dopo un dislivello di circa

TAPPO IN PIETRA DI UN INGRESSO TOMBALE
a forma di lunga
striscia di terreno, tutto questo è così da sempre, la zona molto ripida e con
tanti pendii era stata resa a scalinata già dagli Etruschi, per meglio sfruttare
i terreni, e poterli arare e coltivare come quelli pianeggianti.
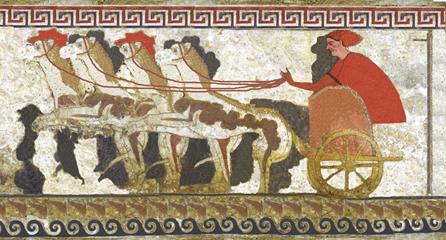
Ed è proprio al di
sotto dei muri o ai gradoni di dislivello, che molte tombe si vedono, scavate in
pietra, (una volta tufo duro), senza Dromos , tutte rivolte al mezzogiorno, come
d'altronde anche tutti i muri.
Da un calcolo
approssimativo, in questa zona ci dovrebbero essere, ancora nascoste il trenta
per cento delle Tombe Etrusche, naturalmente le più difficili da individuare,
quelle che i Tombaroli hanno lasciate alla madre terra, che le fa ancora da
custode.

A metà strada di Via
Inferi, un po' d'anni fa c'era un Casolare, che ora è diventato una villa. La
gente lo chiamava Il Podere di Silvio, e qui gli alloggi degli animali erano
vere e proprie tombe etrusche, usate come pollai, o stanze.
Tombe molto grandi,
al punto che in una di queste, vicino alla casa, i vecchi contadini di un tempo
ci parcheggiavano il carro dei buoi, mezzo di trasporto usato fino a circa 30
anni fa nelle campagne, quando ancora i trattori e le automobili non erano
frequenti come oggi.
Anche sulla parte
bassa delle Castolaie c'è molto da vedere, specialmente in fondo al campo piano
con il vecchio vigneto.
Sotto il muro di
fine campo ci sono addirittura delle rovine di un edificio molto piccolo, di
origine etrusca, non si può dire che sia un insediamento, ma è una buona
occasione per chi volesse ammirare questi resti, e farsi un'idea di com'erano
certe abitazioni.

UNO DEI DIPINTI DENTRO
FOTOMONTAGGIO DELL’INTERO PIANORO VISTO DA DAVANTI AL CENTRO
Scorrendo sullo
stesso piano, di queste rovine, sia a destra che a sinistra lungo in Greppo si
trovano alcune tombette profanate, ma anche qui non sono a distanza regolare
l'una dall'altra, ciò significa, come del resto avrete già intuito, che ne
esistono ancora molte da aprire, nei punti dove tra le due tombe visibili c'è
troppo spazio.
Questi sistemi di
ricerca, non sono teorici, ma frutto di tante esperienze acquisite durante anni
ed anni di attenta analisi, delle diverse tipologie di scavo, usate dagli
Etruschi, nell’intento di preparare le strutture delle necropoli, che poi
sarebbero diventate tombe.
In conclusione,
siamo convinti e ne abbiamo prove certe, che questo “pianoro” sarebbe stato il
più indicato e somigliante alle descrizioni antiche, nel quale si potrebbe
nascondere il sepolcro del Re Porsenna (da non confondersi con il Mausoleo, che
era una struttura a se stante, ed in altra posizione), sempre in una delle 14
zone da noi descritte.
Il Varrone infatti
parlava di Tempio, Mausoleo, Enorme costruzione, ma non ha mai detto che fosse
allo stesso tempo anche il sepolcro del Re.
Capitolo
9
Recandoci
in località "IL POGGIONE", io e
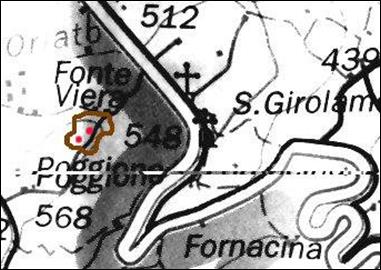
Il Poggione, anche
S. Girolamo è una località in periferia di Sarteano, non molto distante dal
centro abitato, circa
Ci si arriva
deviando appena giunti alla Madonnina lungo la dritta pianeggiante che porta
alla zona industriale di Sarteano, Via Etruria. Dopo aver deviato a destra, in
prossimità dei piccolo Tabernacolo si sale un po' per una strada sterrata,
abbastanza ripida, passando sulla sinistra del podere S. Girolamo, si continua
per altri
Salendo per il bosco
sulla nostra destra si intravede la prima Tomba, a forma di caverna, senza
Dromos, e scavata sotto una grossa falda di pietra, la tomba è molto spaziosa
all'interno, ci si potrebbe stare in piedi, anche in molte persone, da una
perlustrazione approssimata sembrerebbe trattarsi di un Dolmen, in questo caso
quindi ci troviamo di fronte ad una struttura che risale a circa 8000 anni fa, e
ci sarebbe da controllare se accanto ne esistano altri simili, come risulterebbe
dai nostri studi.
La tomba in
questione è isolata, e le sue compagne di serie non sono ancora state scoperte,
questo perché il dosso allungato dove è stata scavata, è lungo a tal punto che
potrebbero esserci inserite altre 4 Tombe a sinistra e
Nella zona poco
distante, denominata Belverde vennero ritrovati infatti dei resti di questi alti
umani.
Abbiamo dato anche
un nome a questi umanoidi, “Homus Rovus”, o Uomo dei Rovi, perché viveva fra i
rovi delle zone allora aride e abbondanti di vegetazione spinosa, ed ortiche
molto più pericolose di quelle di oggi. Abbiamo poi cercato di attribuire loro,
un periodo di esistenza che va, sempre secondo noi, dal
Il materiale
tufaceo, da loro usato misto a lastroni di pietra, è della qualità migliore,
preferita sia dagli Etruschi che da altri. Se si calcola che le tombe isolate,
siano da considerarsi l'uno per cento solamente, mentre tutte le altre invece
sono a Schiera o a Ventaglio, qui in questo punto devono esserci
indiscutibilmente altre tombe ancora inviolate.
Addentrandosi ancor
più nel bosco c'è un posto più in alto, roccioso e solido, dove esistono delle
caverne o grotte, dalle forme regolari e levigate in alcuni punti, da far
pensare che un tempo siano state abitate da
umani.
Entrando in una di
queste caverne si scende verso il basso per alcuni metri, poi risalendo, la
caverna si divide in due, la parte sinistra sbuca poco dopo all'esterno, la
parte destra invece continua verso l'entroterra tracciando una semicurva, poi
passa per un punto dove si vede l'esterno guardando in alto, infine continua
ancora sotto terra. Qui ci siamo fermati perché occorrerebbe, per proseguire,
una attrezzatura da speleologi.
Arrivati in cima al
bosco il terreno comincia a ridiscendere verso Nord e poco più in basso ci sono
delle tombe a Cavernetta, circa sette di piccola grandezza. La particolarità di
essere rivolte a nord le qualifica come tombe molto povere.

TOMBA ETRUSCA RICHIUSA DOPO
Molto rare in questa zona, queste tombe piccole venivano
usate dagli Etruschi per gente di
poca importanza. C'è chi dice invece che le tombe rivolte a nord sarebbero state
di Etruschi atei, che non riconoscevano gli dei adorati da tutti gli altri, e
che quindi, non sarebbe stato concesso loro, dopo la morte, di vedere ne la
nascita del sole, la luce, e ne il Mezzogiorno.
Da qui si vede
Sarteano da una latitudine che ci permette di ammirarlo in quasi tutta la sua
estensione, voltandosi dalla parte opposta invece c'è il monte Cetona, dà l'idea
di una schiena d'asino, o di un cono rovesciato, molto bello a vedersi.
Poco sotto alla casa
con piscina e campi da tennis, anni fa c'era una fontana di acqua potabile Fonte
Manduleta, molto frequentata da gente del luogo, per la ottima qualità delle
acque, cento metri a sud di questa sorgente, in un campo di ulivi, fra una
scarpata e l'altra ci sono resti di muratura romana, se ne vedono chiaramente i
resti, tipo pezzi di muratura a detriti rossastri in parecchi parti adiacenti al
punto della vecchia fonte d'acqua.
Le tombe in questo
punto sono dei tipo a Cassettone, cioè simili alle nostre fosse moderne, ma
coperte con delle enormi lastre di pietra, piatte e molto pesanti, parecchie di
loro infatti sono state individuate durante il passaggio di trattori, a causa
dello sfondamento dei soffitto, appunto fatto di tegoloni.
Nel prato che va
dalla zona della sorgente al punto dove c'era fino a poco tempo fa il lago
artificiale, furono rotti molti Ziri sempre durante la lavorazione del terreno
con aratri molto profondi, i quali venivano chiamati dai contadini aratri da
scasso, noi personalmente li avremmo meglio chiamati "Aratri da Ziri", visto che
non se ne salvavano molti al loro passaggio.
In questo prato si
dice che sia facile trovare delle monetine Etrusche, ma per lo più romane, zona
quindi questa, come si sol dire, da metaldetector.
Ad un chilometro
circa da qui, spostandoci in direzione est, c'è il casolare denominato "
Parecchi degli
abitanti che hanno avuto l'occasione di abitare in questo casolare, hanno
raccontato all'incirca la solita storia. Il fatto si è svolto sempre di notte,
nel primo racconto il contadino si era alzato ed andava a controllare la
stalla dei buoi, in quanto aveva sentito dei lamenti, e pensava che una mucca si
sentisse male, o addirittura stesse per partorire.
Quando ebbe finito
di controllare la stalla mentre si apprestava ad attraversare l'aia (piazzale
davanti ai Casolari, usato durante le trebbiature, e nel quale veniva allestito
il pagliaio), fu in quel momento che si stropicciò bene gli occhi fermandosi di
colpo, in quanto (sempre secondo il suo racconto), vide passeggiare per l'aia
una chioccia con 8 pulcini, la cosa strana fu che questi animali erano di un
giallo luminoso, praticamente sembrava fossero d'oro.
Quindi a questo
punto, noi dovremmo pensare che un suo vicino gli avesse fatto una burla,
verniciando magari una gallina e dei pulcini con della vernice dorata, per poi
portarli lì a casa sua a quell'ora di notte.
Noi non crediamo che
sia andata così, e Voi?
Un'altra storia è
molto simile a questa, ma la persona era una donna, anche lei abitava qualche
anno dopo nello stesso casolare. Questa donna una notte alle ore 12,30 circa
uscì, e nello stesso punto dell'aia vide anche lei la famosa chioccia con i
pulcini, d'oro.
Lei non si
accontentò di vederli passeggiare, ma lì rincorse, e dopo averli raggiunti,
racconta che si chinò per afferrare la chioccia con tutte e due le mani. Ma
quell'immagine non aveva materia, come se fosse una proiezione e non riuscì a
toccare la gallina.
Si spaventò a tal
punto che correndo per le scale di casa, cadde e si ruppe una gamba in due
punti, subito dopo il marito che aveva udito le sue grida scese correndo e cadde
rompendosi anche lui un braccio.

TOMBA PROFANATA E RIEMPITA DI SASSI
Fu da quel momento
in poi che incominciarono a dire che quel casolare era stregato, o maledetto,
anche perché dopo di loro un componente di un'altra famiglia si suicidò, dopo
essere diventato pazzo a causa di alcuni rumori insopportabili che sentiva la
notte sotto il pavimento della sua camera da letto.
I casi di
avvistamento di chiocce d'oro, da un'indagine accurata risultano circa 30, e
tutti quanti coincidono come descrizione agli altri, benché tutti i racconti,
per la maggiore sono stati fatti da persone che non si conoscevano tra di loro.
Attraverso diverse
ricostruzioni dei fatti siamo riusciti a ricostruire il tragitto che
percorrevano questi animali, cioè apparivano da dentro la cantina sotto la casa,
poi arrivavano fino ad un punto ben preciso. Attraversato il piazzale davanti la
casa, scomparivano nel campo coltivato, andando in direzione Podere Le Pianacce.
Queste apparizioni
potrebbero anche essere state alcune "presenze" di guardiani della Tomba del Re
che, apparendo sotto forma di diversi animali, tenevano lontano gli eventuali
malfattori dal punto della sepoltura, questa, naturalmente è solo una nostra
supposizione.
Questa tesi assieme
a noi la sostengono però anche altre persone, che sono al corrente di certi
argomenti, ma la verità, si sa, è sempre difficile da scoprirsi. In casi del
genere poi è più difficile che mai, quando cioè si parla di presenze,
apparizioni, energia fotocinetica, spiriti, fantasmi ed altro.
Bisogna riconoscere
che nelle nostre zone esistono anche molti luoghi e castelli con al loro interno
dei fantasmi, parecchi di questi sono famosi, e se ne è parlato anche in tv,
alla Rai ed in altri servizi fatti alcuni anni fa da Canale 5.
Quindi non c'è da
stupirsi di niente, nemmeno se la notte vi succedesse quello che è accaduto ad
un abitante di Sarteano, che ha addirittura parlato con un parente di Muzio
Scevola, vestito da romano e con abiti a colori.
Questo avvenimento
di circa 30 anni fa, è molto interessante, ed è accaduto in un piccolo Casolare
a circa
La persona in
questione era un vecchio contadino, non aveva fatto nemmeno le scuole
elementari, per mancanza di soldi da parte della famiglia, di certo quest'uomo
non conosceva la storia, né tanto meno Muzio Scevola, ma nel suo racconto dice
di aver visto questo individuo e ne sapeva il nome, si ricorda i particolari, e
afferma di aver parlato con lui.
Il colloquio fu
breve, il signore romano disse al vecchio contadino: "Sono il cugino di Muzio
Scevola, vengo per riprendermi l'oro, che ha perso in battaglia morendo qui
vicino, tu sapresti indicarmi il cammino per
Il vecchio gli
indicò la strada più breve per arrivare al podere le Castolaie, e poi la figura
sparì nel nulla senza lasciare traccia.
Questa storia è da
considerarsi quasi reale, visto che questo vecchio non era un bevitore, ed era
sanissimo di mente. Anche se molti di questi casi di apparizioni, visioni, ecc.,
facessero parte di allucinazioni o effetti ottici, almeno il 10 per cento di
essi, potrebbero essere autentici.
Capitolo
10
Salve avete notato che questa sera la notte è
più buia, disse

Questa zona è meglio
denominata Sferracavalli, a causa del suo pendio: un tempo sicuramente i cavalli
di passaggio perdevano i ferri, e quindi da lì il nome della antica strada che
conduceva a Vulci, punto di passaggio molto importante, sia per il commercio di
allora, che per i collegamenti. Qui poco distante, nel 1975 il Bargagli rinvenne
una necropoli con tombe a Ziro e a pozzetto, circa 150 tombe, di cui la maggior
parte Villanoviane. All'interno

PIETRE TAGLIATE IN EPOCA ETRUSCA
l’ornamentario era costituito da un'Olla d'impasto e gli
elementi di corredo erano tutti dentro e intorno ad essa.
Vennero ritrovate
numerose fibule in bronzo ed in ferro, un drago, una navetta, e 13 rasoi
semilunati, per lo più della tarda
età del ferro.
All'interno sono ben
fatte ma non troppo spaziose, scavate in un tufo molto duro, la gente del posto
dice che queste tombe fossero molto ricche, ossia contenessero reperti quasi
esclusivamente in oro.
Più in alto, ce ne
siamo accorti guardando, si nota una scarpata che nasconde altre tombe, del tipo
a schiera, molto simili a quelle della località Solaia, una in particolare è
quasi visibile ed ancora inviolata.
Alcuni Sarteanesi
sostengono che, anche nella cava esistono alcune tombe etrusche, magari rotte
durante qualche esplosione, servita a spaccare la montagna per raccogliere il
prezioso materiale che viene poi usato per fare strade, e costruire muri di
recinzione a ville, case ecc.
Oltrepassata la cava
per tutta la sua lunghezza, sulla destra c'è l'ingresso alla tenuta Aiuola,
anche all'interno di questa ci sono delle cose da vedere, ma essendo proprietà
privata e (chiusa), non abbiamo potuto accedervi.
Più avanti,
continuando per la strada principale, c'è una via sterrata sulla sinistra, che
porta ad un vecchio casolare di nome “I Pozzi”, prima di arrivare al podere si
notano sparse lungo i lati della strada delle strane fosse scavate nel terreno
di forma circolare. Un anziano signore che conosce queste zone fin da piccolo,
ci ha spiegato che queste fosse fungevano da fornaci di cottura, per vasellami
etruschi, e che venivano colmate di legna, per poi dar loro fuoco, poi
sull'orlo di esse, sopra delle grate metalliche, venivano messi a
scaldare i mattoni di materiale refrattario, formando dei castelletti tra di
loro, all'interno dei quali venivano posti i vasi per la cottura.
Tra il Casolare “I
Pozzi”, e le vicinanze del Podere “Il Troscione”, c'è una zona con terreni di
origine vulcanica, un misto di cenere e sassolini di colore grigio, inoltre il
materiale è composto per una minima percentuale da Carbonio, e Magnesio.
In questo punto abbiamo rinvenuto dei piccoli cristalli
dalla forma di diamante, pietre molto dure, forse più del quarzo tradizionale,
sicuramente di poco valore, in quanto, data la massiccia presenza di queste
pietre, se avessero avuto molto valore la gente del paese se ne sarebbe
certamente appropriata.
Capitolo
11
Eravamo tutti e due intenti ad ascoltare i
risultati della giornata di ricerche Donna mi domando a quel punto, perché fosse
stato sempre presente dentro di me il presagio, e strano che tu che fai un altro
mestiere ti appassioni anche di Archeologia e di ricerche sugli Etruschi, perché
tu che hai altre cose più interessanti ti appassioni così tanto a queste
ricerche, e ti piace una che , anche se molto bella , sai che è venuta dal nulla
e nel nulla prima o pio tornerà.
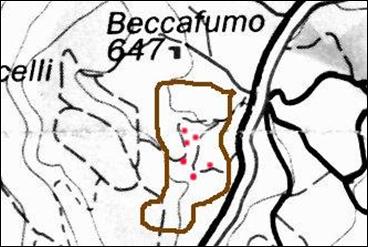
Beccafumo non è
molto lontano dalla località Cava, sempre sulla strada che porta a Radicofani,
svoltando a destra
In questo luogo a
pochi metri da un laghetto artificiale, di
La sabbia riempie
tutta la caverna Fino al soffitto e, visto che la grotta è scavata nella pietra,
questo fa supporre che sia stata messa e poi pressata con forza fino
all'esterno, per tappare questa specie di tunnel.
In fondo dove
finisce lo spazio libero e comincia la tappatura di sabbia, un istrice ha ben
pensato di costruirsi la tana scavando un buco notevole e molto lungo, che anche
puntandovi dentro la luce di una torcia, non se ne vede la fine. Tutto questo fa
pensare che il tunnel sia ancora molto più lungo, ma lo si potrebbe sapere
solamente togliendo tutta la sabbia, scoprendo così dove porti questo strano
tragitto sotterraneo.
I prati da queste
parti sono cosparsi di piccoli detriti rossi, tutti residui di mattone etrusco,
e di vasetti spezzettati durante le lavorazioni dei campi.
Scendendo a sud un
po' in basso i detriti aumentano, e si incominciano a trovare moltissime tegole
frantumate etrusche, alcune addirittura intere. Infatti qui le tombe erano del
tipo “a cassonetto o cassettone”, cioè delle fosse di due metri e mezzo per
Da qui ci siamo
allontanati un po', per visitare una parte molto bella di questa zona: in cima
ad una collina ci sono delle rovine, o meglio le vecchie fondamenta di un antico
castello, il castello "Delle Moiane", zona molto boscosa e con molta
vegetazione. Non si conosce bene l'epoca di questo castello, del quale sono
rimaste solo, con venti centimetri di sporgenza dal terreno, le antiche mura.
Abbiamo sentito dire
che sono state trovate qui, alcune monetine, ma non siamo riusciti a
rintracciarne nemmeno una, altrimenti sarebbe stato facile risalire all'epoca
cercando di scoprire la data della loro fabbricazione.
Il posto non c'entra
molto con la parte etrusca del nostro racconto, ma sarebbe molto interessante
cercare di scoprire se questo castello, abbia avuto i sotterranei, per visitarli
e chissà forse trovare anche un tesoro.
In località Spineta,
non molto distante da qui, dei lavoratori agricoli rinvennero casualmente una
tomba a nicchie, costituita da un lungo Dromos, con 21 Nicchie sui lati, ed una
in fondo al Dromos.
All'interno furono
rinvenuti frammenti di uno specchietto in bronzo, di epoca ellenistica, ed anche
un frammento di Tegolo con iscrizione.
In località Aiola,
sempre qui vicino, ma un po' più a nord, nell'agosto del 1957 il Prof. Maetzke
rinvenne una grossa fondazione a squadra, e numerosi frammenti di embrici in
ceramica grezza e a vernice nera, alcuni embrici grigiastri, di colore giallo
all'interno e di spessore di circa
Da questo punto
spostandosi ad ovest si arriva in una località chiamata dalla gente dei posto
Strascico della Regina, il nome le è stato dato perché c'è

MULATTIERA CHE PORTA ALLO “STRASCICO DELLA REGINA”
sul luogo un
viottolo in pietra, dove si dice non sia più cresciuta l'erba dopo che la regina
del castello, passando con il suo manto lungo, che strisciava sul terreno
tracciò questo percorso, per giungere fino al Pozzo del Diavolo, un pozzo
naturale del quale nessuno ha mai scoperto di quale natura fosse. Il pozzo,
(così si dice), non ha fine, lo hanno dedotto alcuni speleologi, i quali calando
un peso legato a delle funi, e facendolo scendere giù nel pozzo, con l'intento
di calcolarne la profondità, non riuscirono nel loro intento, in quanto le funi
finirono, e portatene delle altre, finirono ancora. Raccontano poi, che queste
persone decisero di rinunciare al loro intento perché non era possibile avere
altre funi, e si convinsero che quella voragine non aveva fine.
Questo è un posto
ricco di leggende e storie, dicono che, venendo qui di notte, e rimanendo in
silenzio, con un po' di fortuna si può sentire il rumore dello strascico del
vestito della Regina ed i suoi passi che ripercorrono il tragitto da lei fatto
tanti anni fa. Qualcuno invece afferma che il Pozzo dei Diavolo sia l'unico
accesso alle viscere della terra, dove appunto dovrebbe trovarsi il Diavolo, e
che nell'antichità i cattivi ed i ladri venivano gettati in questa voragine per
punizione, convinti che così sarebbero Finiti direttamente nel posto più idoneo
a loro, appunto all'inferno...
Capitolo
12
Quella notte
ZONA “

A
La strada che porta
fin qui è un po' stretta, ma molto agevole, davanti al casolare dalla parte
opposta dell'autostrada, c'è una fonte d'acqua, da qui il nome Fonte Galgana,
anche se stranamente, il podere porta il nome di Molin Canale.
La zona in questione
è poco più avanti sulla destra, la prima parte (quella più vicino alla strada) è
un bosco scosceso con pineta, salendo invece più in alto diventa bosco con
querce.
Le due curve che
separano Fonte Galgana o Molin Canale dalla zona della necropoli, un tempo non
esistevano, il passaggio avveniva lungo una antica strada ormai non più usata da
nessuno.

SULLA SINISTRA
In questa zona nel
1953 venne scoperta una tomba di età ellenistica, con una piccola camera, e tre
nicchie a loculo, dentro le quali c'era il corredo funebre, ovvero, una umetta
fittile, due coppe a vernice nera, ed altri frammenti di vario tipo.
Molto vicino a
questa, il 15 Gennaio del 1948 venne rinvenuta un'altra tomba a Ziro, ampia
circa
In effetti c'è
ancora oggi la vecchia strada antica che collegava queste due curve una delle
quali a tornante. Percorrendola, si passa in mezzo alle necropoli, una parte di
esse è sulla pineta a destra, sulla sinistra invece a circa venti metri dalla
vecchia strada, si può vedere la prima fila di tombe, una accanto all'altra, a
distanza di circa tre metri.
Salendo verso l'alto
a nord, s'intoppa sulla seconda Fila di tombe.
La geometria
strutturale in questa zona la si può facilmente capire vedendo come sono
disposte le tombe la direzione dei Dromos a sud, le file di tombe sono state
costruite in modo che le camere della prima Fila non fossero troppo vicine a
quelle della seconda, quindi si ha una struttura a pettine; in sostanza,
prendendo in considerazione due file, avremo uno "zigzag".
Una in basso e
l'altra in alto, con più distanza ai lati per quelle pluricamera, che presentano
lungo il Dromos, due camere laterali ed una centrale in fondo. Questi scavi sono
rimasti in parte scoperti e ben in vista, si possono vedere tranquillamente
anche nei loro particolari, senza sporcarsi troppo, o dover addentrarsi fra rovi
e piante spinate.
C'è da notare che le
tombe in basso a destra nella pineta, sono senz'ordine geometrico, mentre
invece, salendo alla nostra sinistra, si hanno le file a pettine, infine,
salendo ancora, si vanno diradando.
Ancora più in alto,
ed ancora più a nord si trovano altri gruppi di tombe, senza ordine di riga, né
sequenza metrica, ma molto più profonde ed anche con un Dromos di larghezza
superiore alle altre, mentre in questo punto, tendono a scomparire le tombe con
più camere, infatti hanno di solito una sola camera più grande ed al centro, in
posizione fine Dromos.
Le nicchie ai lati
dei Dromos, invece sono molto più numerose in questa zona, alcune ne hanno
addirittura 8, e spesso una delle file di nicchie è alta ed una bassa, al
livello del pavimento.
Analizzando una
delle tombe appartenenti alla lunga schiera, abbiamo notato che alcune sono
state usate in più epoche, lo si può capire dal diverso materiale di
riempimento: a volte muratura, dura e consistente e a volte invece di
riempimento pietrisco e tufo in polvere, inoltre le nicchie lungo il Dromos non
sono tutte uguali, ma dallo stile diverso, con la tegola di tappatura di un
altro colore. Alcune invece sono a due piani, in pratica la prima sepoltura, in
epoca più remota, fu costruita sotto al livello di quello che adesso è il
pavimento; la seconda sopra il Dromos riempito della prima, costruita in un
tempo più recente, con un'altra serie di nicchie, diverse da quelle del piano
sottostante. Per questo motivo non si può stabilire alcune volte, un'età precisa
di queste opere, anche se approssimativamente le lavorazioni sembrano essere
d'epoca etrusca .
In alcuni punti tra
uno scavo a l'altro, a distanza di tre metri, non vi è una tomba come le altre
ma un Nicchiaio, Dromos un po' più lungo dei solito, ma poco profondo, con sole
nicchie sia a destra sia a sinistra, a volte anche di distanza un metro l'una
dall'altra, ma nessuna camera di tomba.
Tutto intorno,
rispettando una geometria casuale ci sono dei saggi scavi di ricerca per tombe,
alcuni sono di un metro per due, profondi anche tre metri, forse questi punti
sono indicati agli scavatori clandestini dai famosi Pendolisti, persone convinte
di riuscire ad individuare i vuoti e le cavità sotterranee attraverso l'uso di
un pendolo recante all'interno dei materiali per "ricerca specifica, o come li
chiamano loro "i testimoni".
Forse questi saggi
sono stati fatti ad intuito o con dei calcoli in base alle distanze e teorie
sulle geometrie usate dagli etruschi nel costruire tombe.
Rimane il fatto che,
le persone del posto possono confermarlo, se si viene qui una volta al mese e si
ha una buona padronanza delle zone, si potrà notare che ogni volta c'è qualche
saggio in più. Ci s'accorge subito di certi saggi, perché si nota bene, da
lontano nel bosco la terra scavata e rimossa di recente, poi si vede che a terra
vi sono bottiglie vuote e pacchetti di sigarette; resti di un duro e faticoso
lavoro di scavo notturno.
Ci hanno raccontato, che in questa zona è usato un altro
metodo di ricerca, per individuare i Dromos delle tombe eventualmente scampate
ai picconi dei vari gruppi di scavatori clandestini; è usato un attrezzo
chiamato "spillone", in sostanza uno stilo di ferro con un manico rotondo tipo
manubrio all’estremità superiore montato perpendicolarmente all'asta.
Quest'attrezzo si
conficca nel terreno fino a raggiungere lo strato di tufo, che si trova a circa
40/60 centimetri sotto terra.
Di solito si fanno
delle punture al terreno, perpendicolarmente a dove si pensa che passi il
Dromos, e facendo un buco ogni dieci centimetri circa, si potrà stabilire,
calcolando la differenza tra quando va troppo giù e quando la profondità ritorna
normale, il punto preciso dove il Dromos si trova sotto terra, ed anche la sua
larghezza, e profondità. I ricercatori moderni invece si sono attrezzati bene,
la tecnica di ricerca è cambiata molto con il progresso dell'elettronica
moderna. Il "Georadar" per esempio è un apparecchio in grado di visualizzare il
sottosuolo fino ad una profondità di circa due metri e cinquanta, con un massimo
di
Ognuno di questi
numeri proviene da un punto preciso della sonda di scandaglio o "Antenna
Ricetrasmittente", viene poi riportato su un monitor sotto forma di un puntino
"Pixel" più o meno luminoso in base al valore del numero variabile di cui
parlavo prima (da zero a 255). La velocità dei dati, ed il completo
spennellamento dei monitor, da parte del Pennello Elettronico che si trova
dentro il Tubo Catodico, darà poi forma visiva del punto sul quale ci si trova
con la sonda in quel momento, fornendo anche l'immagine in movimento, e con la
possibilità di memorizzare il piccolo filmato digitalmente.
Ma torniamo a
descrivere la zona. C'è un Dromos di questi molto strano, uno degli ultimi della
seconda fila partendo dal piano della Strada Antica, il quale non è come gli
altri.
In basso dove ha
inizio il Dromos, ci troviamo ad un livello più basso di quello della fine
Dromos, dove c'è la tomba centrale frontale.
In 99 casi su 100, i
Dromos scorrono in piano, o magari tendono un po' a scendere verso il basso, e
l'ingresso della tomba centrale è sempre al livello dell'inizio del Dromos,
diversamente, la camera della tomba potrà essere di livello più basso rispetto a
quello del Dromos, ma mai più alto.
Quindi ci troviamo
di fronte ad una struttura insolita e diversa dalle altre,

SCARPATA DI PIETRA CON ALCUNE TOMBE RUPESTRI
con la camera
centrale più in alto del pavimento di circa un metro e ventidue centimetri,
mentre a metà strada fra l'inizio Dromos ed il frontale, c'è un repentino rialzo
di circa
Pensiamo che questa
differenza di livello non sia altro che una tomba costruita sopra un'altra già
esistente, con un riempimento fino al livello di copertura di tutte le volte
degli ingressi sottostanti di nicchie ed eventuali camere. Poi è stata costruita
l'altra tomba sopra il primo riporto. Quindi, a parer nostro, si tratta di una
tomba a due piani, con la parte dei piano inferiore ancora da scoprire, ma
tappata con una muratura ben più dura del nostro moderno cemento, un materiale
che è un insieme di detriti di mattone rosso, tufo fino ed un elemento ricavato
dalle piante, che. unendosi chimicamente al calcare delle acque, ha formato un
materiale durissimo.
Un altro punto che
non ci convince è un po' più a sinistra dove sembra mancare una tomba perché tra
le due non ci sono i soliti tre metri di distanza come tra le altre tombe di
tutta la fila, ma circa sei metri. Eppure nel centro di questo metraggio non ci
sono segni di Dromos, ed in questo punto c'è della pietra, quindi si vedrebbero
chiaramente le tagliature dei suo inizio.
Chissà, può essere
che per qualche motivo, all'ultimo momento abbiamo deciso che in questo punto il
materiale non fosse idoneo, e quindi abbiamo optato per non costruire questa
tomba, o forse esistono altri tipi di coperture, o di riempimenti di cui non
conosciamo l'esistenza.
Ad esempio, se
avessero riciclato lo stesso materiale dello scavo, per ricoprire il Dromos, con
il passare dei tempo si sarebbe indurito, e ricomposto bene al punto da far
sembrare il piano tutto unito e della stessa pasta.
Ma le cose strane
qui non finiscono mai anche perché la zona è vasta e con tanto bosco, da far sì
che non si riesca ad orientarsi bene se non si è esperti della zona, quindi
molte cose non si vedono nemmeno passandoci ad un metro di distanza.
Capitolo
13
E' tutta una foresta questo posto, dissi io e la
donna rispose: "E' una foresta adesso , ma ai miei tempi la zona era coltivata e
polita, senza rovi o erbacce". Il panorama era stupendo, da qui si vede il lago
di Chiusi, quello Trasimeno, e tutta la vallata compresa fra il nord ed il sud,
passando per un centro immaginario che è l'est. Ma vi dirò di più aggiunse
ZONA “
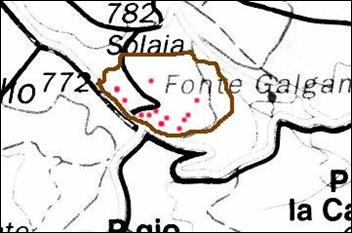
Ci troviamo in una
zona boscosa, le tombe sono disposte apparentemente senza alcun ordine
geometrico, i Dromos naturalmente sempre rivolti a sud, e le strutture interne
diverse l'una dall'altra.
Il sottosuolo in
questo punto è molto roccioso ed il tufo più duro di quello della zona
precedente, poco più in basso di qui. I Dromos non sono tanto lunghi, di circa
due, tre metri, le nicchie si vedono molto raramente, nei Dromos vi sono di
solito due tombe laterali grandi, ed una centrale principale.

GIANCARLO LUNGO IL VIALE CHE PORTA ALLA NECROPOLI
Alcune di queste
hanno una sola camera centrale molto ampia, all'interno sono solite essere di
forma rettangolare e non più rotondeggiante come quelle analizzate fino ad ora.
Gli etruschi in
questa zona hanno sfruttato per le loro tombe anche il cordolo sottostante la
vecchia strada, la quale sale all'interno della bassa Solaia, infatti alcune
tombe piccole, ad una sola camera di forma rettangolare, con piccolo Dromos,
sono disposte al disotto della strada, ben visibili passando per il prato
sottostante la piccola strada sterrata. Sono di solito a serie di tre.
Sotto questo piano,
a circa venti metri c'è la strada Sarteano Castiglioncello, in alcuni punti
questa è stata costruita scavando in profondità, tre metri di tufo per sei di
larghezza.
Durante la
costruzione della carreggiata, in quel periodo furono scoperte alcune tombe di
quelle un po' più profonde, percorrendo la strada in questo punto, si vedono
infatti ancora oggi sul ciglio destro, salendo verso Castiglioncello alcune
tombe. La loro camera centrale infatti è stata aperta sulla parete ovest, se ne
può vedere bene l'interno senza doversi addentrare troppo nei boschi o nella
campagna.
Da queste parti, i
curiosi appena finito un temporale, usano fare una gita lungo questa strada
Sarteano‑Castiglioncello, molto lentamente e soprattutto scrutando bene le
banchine di tufo della strada statale; piovendo, infatti, l'acqua porta via da
queste pareti due o tre centimetri di materiale dando così luogo spesso, allo
scoprirsi di qualche camera, la quale era quasi in superficie e sono bastati
quei pochi centimetri di terra tolta dalle acque, per portarla alla luce.
Infatti in
moltissimi punti, sempre durante la costruzione della strada, sono arrivati a
consumare il tufo, fino a pochissimi centimetri da qualche camera di tomba
etrusca. Qui vicino a pochi metri ci sono i resti, ormai solo le fondamenta, di
un vecchio podere una volta abitato, Il Fitto, casolare posto al centro di una
valle pianeggiante dove si trovano, forse ancora intatte alcune necropoli. Ad
est, sotto questa zona, c'è il Podere 1 Cappuccini, con una Chiesa che una volta
era una Frateria, poi, ancor più conosciute le Celle di S. Francesco. Da qui
conoscendo bene i viottoli lungo i boschi ci si può arrivare a piedi in dieci
minuti.
Per finire, Solaia
Bassa possiede un punto dove il pavimento è un lastricato unito in pietra, dove
ci sono molte tombe a Dromos corto, in pietra, e con camera piccola, in questo
piano di pietra si vedono su di esso anche delle staccature. Analizzando bene da
vicino, ci si rende conto che si tratta molto probabilmente di Ziri del tipo
scavati in pietra e coperti a lastrone.
Se queste piccole
fessure risultassero essere “tappi di Ziro”, in questo piano dovrebbero
essercene una quarantina, messi alla rinfusa, praticamente senza che si rispetti
un ordine geometrico ben preciso. Abbiamo raccolto su questo punto una storia di
un ex scavatore clandestino, che, quando era più giovane, assieme ad un suo
amico venne qui e, individuato un Dromos sotto la strada sterrata, incominciò a
scavare.
1 due faticarono per
quasi tutta la notte, ed alla fine riuscirono ad arrivare al tappo della camera
centrale.
Alle cinque di
mattina finalmente, facendo bene leva tolsero il tappo, ma la sorpresa fu
grande, la camera della tomba era vuota, il pavimento sembrava appena spazzato,
e non vi era traccia di nessun oggetto.
Chiedemmo: "Ed il
soffitto della camera quanto era alto?" Poco più di mezzo metro" risposero.
Questo dettaglio ci sembrò strano.
Parlando ancora con
quell'uomo gli facemmo poi capire, che in alcuni punti particolari, dove
l'infiltrazione delle acque è abbondante, succede questo: l'acqua gocciolando
dal soffitto porta con sé dei piccoli detriti dello stesso e con il passar dei
secoli si viene a creare un sedimento calcareo o arenario, a volte anche di
"Quindi voi
praticamente avete aperto una camera non di quelle già profanate, ma
"inviolata", e gli oggetti erano tutti lì, al loro posto, l'unico problema era
che non si vedevano, in quanto coperti da uno strato di deposito sedimentario."

ROCCIA A CHIUSURA DI UN TUNNEL CON INCISONE
La strada piccola e
sterrata in questione, a pochi metri dall'incrocio "Macchia Piana" è molto
importante, perché reca sulla sua sinistra, salendo, un piccolo arco che si
intravede appena, chiaro segno di una
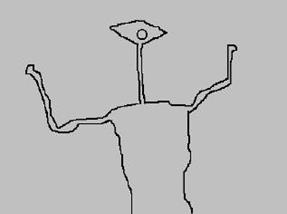
L’INCISIONE SULLA PIETRA ESTRAPOLATA
tomba etrusca, con
il Dromos che attraversa tutta la strada, e la
camera sicuramente
coincidente con la panchina sinistra.
In questo punto
anche un occhio non esperto potrebbe individuare che c'è una tomba con
sicurezza, addirittura guardando bene, sembrerebbe una tomba doppia, con due
camere vicine, divise forse da una piccola intercapedine.
Esistono inoltre due
avvallamenti sospetti, sembra che lungo questa piccola strada ci siano altre due
tombe e sicuramente, con lo scorrere delle acque, prima o poi se ne potranno
vedere i tagli dei Dromos ed anche i frontali.
Capitolo
14
Io e
ZONA “

Meglio conosciuta
dagli abitanti anche come "Romitori", a
Il nome di questa
località è dato da una storia, che avrete modo di leggere nelle prossime righe.
Poggio il Gallo o
"Romitori", come si può ben capire dal nome, è un poggio, non tanto grande, ma
abbastanza da far sì che gli etruschi costruissero anche qui delle tombe, e
chissà poi cos'altro.
Queste tombe sono
diverse da quelle della Solaia, anche se i luoghi sono molto vicini, si tratta
per la maggior parte di Tombe a Cassettone particolari tombe senza Dromos a
pochi metri di profondità e che hanno come soffitto dei tegoloni, simili a
quelle d'epoca romana che si possono vedere a
Sarteano in zone come S. Apollinare, Podere Colombara,
dalle parti della Cartiera, e nella Necropoli da noi scoperta di Beccafumo,
nella quale zona, in particolare, ve ne sono molte ancora vergini.
Ma questo posto non
è interessante solo per le Tombe Etrusche, bensì per una storia tramandata di
padre in figlio per migliaia di anni, una delle più strane storie legate a
questi posti e che si possono sentire raccontare solo da pochissime persone di
Sarteano.
Andando da Poggio il
Gallo in direzione Solaia, per i viottoli esistenti da migliaia d'anni, si passa
per un punto dove c'è un enorme blocco di pietra pesante migliaia di tonnellate,
che sembra appoggiato lì sul terreno, senza però farne parte, infatti è
distaccata da esso nella parte a contatto.
Su questa pietra,
nella facciata a sud‑est, c'è un'enorme strisciata come incisa da qualcosa, la
gente chiama questa profonda striatura della pietra "la codata dei diavolo".
La storia dice che
centinaia d'anni fa il diavolo venne fatto arrabbiare da qualcuno e lui, preso
da tutte le furie, con una codata ed un giro su se stesso riuscì a staccare un
pezzo enorme dalla parete nord‑est della Solaia, e scaraventarlo fino a qui.
Fu così che lasciò
sulla pietra questa strisciata molto evidente, curvata al punto che sembra,
guardandola bene, proprio una coda enorme e lunga.
Abbiamo voluto
parlare di questo luogo anche per un altro motivo. Qui, a poche centinaia di
metri, c'è il posto dove diceva d'essersi nascosto l'uomo del racconto
precedente, in sostanza l'ingresso sotterraneo al lago e alle caverne con
diramazione stellare.
Poco distante c'è
una zona chiamata Le Crocette, con un piccolo parco boschivo, delle panchine in
legno ed un braciere.
Dalle Crocette,
salendo per un sentiero di circa
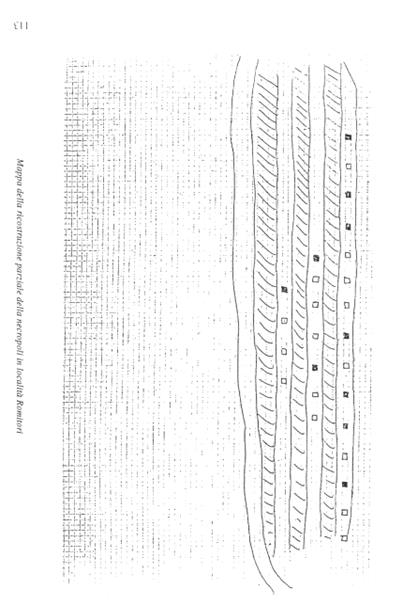
GRAFICA DELLE TOMBE A SCHIERA AI “ROMITORI”

NICCHIA RUPESTRE SOPRA
zona molto in alto,
il panorama è stupendo in tutte le direzioni, tanto bello che dà l'idea di
essere sulle nuvole e guardare dall'alto i piccoli paesi che si vedono, come
nelle foto satellitari.
Qui in alto vi sono chiare tracce di insediamento
dell'epoca Paleolitica inferiore. Nel 1965 vennero recuperati dei resti di
ceramica d'impasto provenienti da una grotta di epoca della fine dell'età del
bronzo, meglio classificabili come di fine del neolitico, inizio dell'età del
ferro.
Si notano subito
scendendo verso sud alcune tombe scavate in pietra, naturalmente già aperte,
formano una schiera di tre file, la prima fila è composta da 7 tombe aperte
visibili, a distanza calcolata come se fossero tutte visibili, di
Lo spazio che divide
le file di tombe è di
Ci sono inoltre
altre tombe, all'interno della Faggeta, orientate a Nord‑est, tombe cosiddette
povere, a parete, da giudicarsi eventualmente del tipo rupestre. Con camera
molto piccola, queste tombe hanno un volume di circa
La zona è molto
vasta, al di sotto nella faggeta, ed andrebbe analizzata più a fondo, si pensa
comunque che siano rimaste inviolate in questo punto circa 10 tombe dello stesso
tipo di quelle visibili.
Capitolo
15
La notte era calda e serena, io e
“In conclusione noi
saremmo molto felici, un giorno, finalmente di vedere le strutture da noi
scoperte ed individuate, portate alla luce, potendo finalmente ammirare, tante
altre bellezze del passato, le quali arricchiranno ancor più il nostro magnifico
ed unico Patrimonio Artistico Nazionale.
Abbiamo fatto tutto
questo per passione, e per gli altri, a noi come ricompensa, basterà
semplicemente il fatto di esserci riusciti.”
Hanno collaborato:
Stefano Romagnoli
(scrittore ricercatore ed esperto del luogo)
Vito De Ieso
(scrittore arrangiatore organizzatore e supporto)
Giancarlo Pellegrini
(scrittore promotore di azioni e fiduciario)
Monaci Marino
(fotografo)